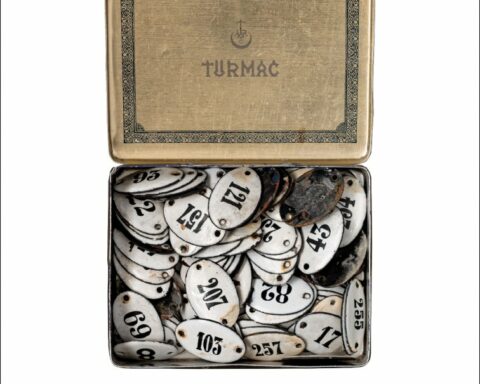Quello con la professoressa Stefania Zuliani è stato un incontro prezioso: non moltissime parole, quelle giuste, per capire cosa significhi amare il proprio lavoro e intenderlo come una parte di sé stessi, senza diventarne schiavi. Docente, tra le altre discipline, di Teoria del Museo e delle Esposizioni in età contemporanea e di Teoria della Critica d’Arte, la professoressa Zuliani ama definirsi “critica dell’arte e del museo nei termini della contemporaneità”. Durante il nostro interessante dialogo abbiamo parlato di arte e di ricerca, ma anche di politica, delle responsabilità civili degli artisti e della dimensione olistica della vita, sempre nell’ottica della trasversalità dei saperi, delle passioni e degli incontri.
Tra i corsi che tiene, sia in triennale che in magistrale, ce n’è uno – al corso di dottorato – che mi ha colpito particolarmente: il laboratorio di Digital Humanities. Può spiegare di cosa si tratta e come si intreccia con gli altri suoi insegnamenti?
Il laboratorio di Digital Humanities nasce all’interno del dottorato di ricerca di Metodi e Metodologie della Ricerca Archeologica e Storico Artistica di cui in questo momento io sono coordinatrice, perché abbiamo ritenuto con tutti i colleghi del Collegio che fosse necessario fornire anche degli strumenti tecnologici ai nostri giovani ricercatori. Non è più possibile pensare di fare ricerca senza avere anche la capacità di utilizzare al meglio le tecnologie sia per trovare e studiare i dati sia per la loro divulgazione e disseminazione. Il lavoro di ricerca deve necessariamente avere una ricaduta pubblica, reale, deve essere un contributo alla crescita culturale ma anche civile della società e gli strumenti tecnologici sono fondamentali. Saper produrre un sito web o una app o degli strumenti in grado di rendere accessibile a chiunque la ricerca scientifica – ovviamente formalizzata nella maniera più idonea – è diventata una necessità dalla quale non si può prescindere. Quindi, il laboratorio di Digital Humanities mette i dottorandi in condizione di poter sperimentare alcune delle tecnologie che riguardano anche l’Internet of Things, la conservazione dei beni culturali e la loro fruizione attraverso casi studio sui quali sono chiamati ad intervenire creando dei piccoli prototipi. In generale, tutto questo accade in un lavoro di gruppo sostenuto dal Centro ICT per i Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno e grazie al loro sostegno i nostri dottorandi realizzano dei prodotti che in genere hanno come oggetto di studio e sperimentazione il patrimonio culturale del nostro ateneo. Trattandosi di un laboratorio, c’è una parte di introduzione teorica, ma poi c’è una parte applicativa molto utile per gli studenti e per chi fruisce di questi lavori.
Lei ha collaborato per oltre vent’anni con la Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d’Arte contemporanea (Salerno-Roma) per la quale ha curato numerosi cataloghi e mostre. Come sono stati questi anni?
Sono stati anni importantissimi, formativi e lo sono ancora perché adesso, da un paio di anni, sono Direttrice Artistica della Fondazione Filiberto e Bianca Menna per la sua sede di Salerno. Questa collaborazione ha avuto un momento di interruzione e si è riattivata di recente con modalità diverse. Quando ho iniziato a collaborare con la Fondazione Filiberto Menna (non era ancora, appunto, Filiberto e Bianca Menna) ero poco più che laureata e quindi, ovviamente, è stato un luogo di crescita e di formazione e sono molto grata soprattutto della possibilità che ho avuto di godere della biblioteca, ho lavorato alla sua organizzazione e catalogazione prima ancora di impegnarmi nell’organizzazione di iniziative, eventi, laboratori didattici e mostre. Quello che per me è stato veramente fondamentale è stata la familiarità con i libri di Filiberto Menna. È stato molto importante per consolidare la mia formazione, per ampliare il raggio di azione e soprattutto per rendermi conto di come fare ricerca sul contemporaneo significhi, a mio avviso, sempre essere militanti come lo era Menna. Avere un’attenzione, una capacità e una volontà di incidere sul presente attraverso scelte critiche, prospettive e proposte che non sono soltanto consegnate ai libri ma anche alle attività che vanno nella direzione di una maggior consapevolezza dei linguaggi delle arti e della critica contemporanea.
Il professore Angelo Trimarco, critico e teorico dell’arte, è stato per lei un punto di riferimento e un maestro. Quanto e in che modo ha influenzato il suo lavoro e le sue ricerche?
Angelo Trimarco, come tutti i veri maestri, è stato fondamentale non tanto nell’orientare la mia ricerca rispetto agli oggetti di studio, quanto rispetto al metodo di studio. Nella mia esperienza di ricerca ho lavorato e lavoro molto sui temi dell’esposizione, del museo contemporaneo, sui problemi che riguardano anche la relazione tra l’andatura dell’opera d’arte e la sua esponibilità, su come l’esposizione definisca oggi l’opera d’arte contemporanea e di come il museo abbia un ruolo cruciale non solo nella comunicazione, ma proprio nella produzione di contenuti culturali. Questi oggetti non sono mai stati al centro dell’attenzione di Angelo Trimarco, ma sicuramente il modo in cui io ho avvicinato questi oggetti di studio nasce dal suo rigore e la sua attenzione al presente e alle problematiche del nostro tempo, una visione che non ho paura di definire anche politica. Questa è una parola che tante volte viene tenuta fuori dai nostri discorsi accademici e invece – così come Filiberto Menna nella sua stagione culturale e con le sue modalità ha fatto e, di conseguenza, anche Angelo Trimarco che è stato l’allievo prediletto di Menna – anche io credo che occuparsi di arte non significhi solo occuparsi di oggetti estetici, ma anche e soprattutto di pensieri e di persone che trovano poi espressione anche nelle opere come dispositivi e che attivano pensiero, conoscenza e relazione. Le opere hanno un valore conoscitivo, ci aiutano a comprendere il nostro tempo. Angelo Trimarco ha sempre lavorato in questa direzione, i suoi studi sono sempre stati molto attenti a cogliere le trasformazioni e le lacerazioni del nostro tempo e io, nel mio piccolo, ho provato a continuare a lavorare in questa direzione, ovviamente scegliendo uno spazio che è quello delle esposizioni e del museo che oggi mi sembra particolarmente interessante perché è cambiato molto lo scenario dei musei in Italia negli ultimi venti anni e oggi ci sono esperienze di museo che hanno un ruolo importante nella creazione di comunità e nell’opportunità di contatto tra culture differenti.
Come è cambiato nel tempo il lavoro del critico d’arte e del curatore di mostre e quali sono le principali riflessioni che ruotano attorno a questa professione?
Dalla metà del secolo scorso ad oggi c’è stato un processo che ha portato, da un lato, a una fase di marginalizzazione della critica d’arte a favore di una pratica curatoriale, dove l’attività preponderante è stata quella della curatela di mostre, mentre, dall’altro, l’attività critica – a causa anche della messa in discussione dei grandi sistemi concettuali, delle grandi costruzioni metodologiche che erano state formulate nei decenni precedenti e che hanno avuto un momento di declino dalla fine degli anni Settanta – ha perso terreno oppure si è rifugiata nelle stanze dell’università senza avere una reale presa sul dibattito pubblico. Si pensi, ad esempio, al ruolo che in passato molti intellettuali hanno avuto nell’essere non soltanto grandi studiosi e accademici, ma anche impegnati nella critica d’arte e nel proporre delle scelte anche in maniera polemica rispetto ad altre posizioni a sostegno della modernità. Questo dibattito acceso si è andato spegnendo nell’ultima parte del Novecento con un’affermazione della figura del curatore definito da molti più come un organizzatore di eventi, addirittura una figura mondana piuttosto che un intellettuale. Questo primo ventennio del nuovo secolo ha visto un’altra volta rimescolarsi le carte: maggior attenzione ai problemi di un’arte che non si misura solo con il mercato e i desideri dei collezionisti, ma che ha la capacità di incidere sulla società. Il dibattito critico si è in qualche modo rianimato senza più pensare che si possa arrivare ai metodi escludenti usati in passato, ma con una capacità di lettura che a partire dalla riflessione teorica si misura anche col fare.
La ricerca, l’arte e la sua attività accademica rappresentano una parte fondamentale della sua vita, qual è la sua seconda anima?
Per fortuna la passione mi accompagna sempre nel mio lavoro; quindi, non vivo la distinzione tra hobby and job, per me non è così. Anzi: ritengo che sia fondamentale, anche per i più giovani, pensare che al di là della specializzazione sia necessario avere uno sguardo più largo. Amo molto la musica, il cinema, il teatro, la natura, il cibo e il vino – una parte della mia vita non accademica è stata legata alla ristorazione – ma tutte queste stanno insieme: non chiudo la stanza dell’università e si apre un altro mondo, per me queste cose vanno necessariamente insieme e credo che sia importante ritornare ad una dimensione olistica in grado di tenere insieme aspetti diversi. Uno dei problemi più seri che ha vissuto la nostra università è stata una iper-specializzazione. Io sono laureata in Lettere Moderne e sono così contenta di avere studiato nel mio percorso la poesia, il teatro, la musica, la filosofia e di avere avuto una formazione che oggi è un po’ parcellizzata, anche se si sta tornando ad una formazione più trasversale. Questo, secondo me, è molto importante: quindi passioni specifiche non ne ho, nel senso che sono veramente appassionata ad una dimensione umanistica in senso ampio, non in opposizione alle tecnologie, anzi. Penso che tutto questo, vissuto insieme e senza esclusioni, ci aiuti a vivere meglio.
Come si descriverebbe in tre aggettivi?
Sono sicuramente molto tenace, ironica – ho avuto attestati di questo! – ed esigente.