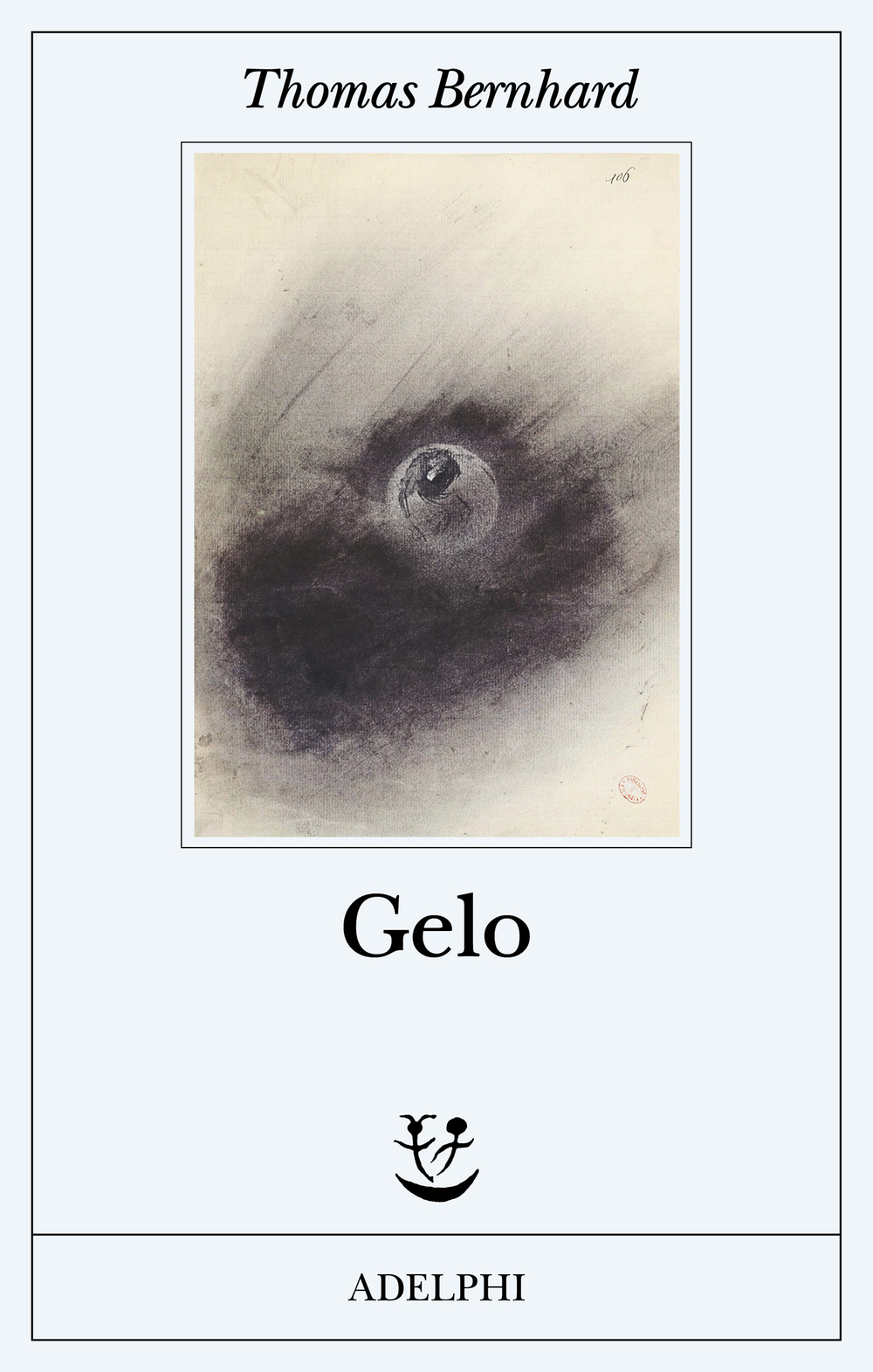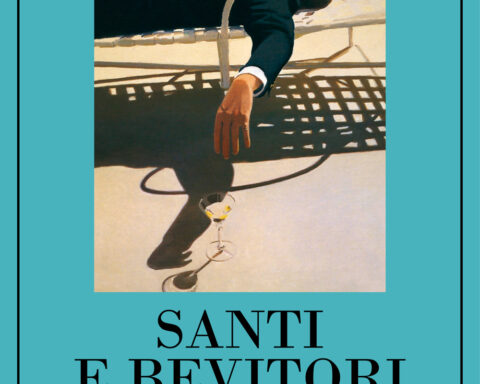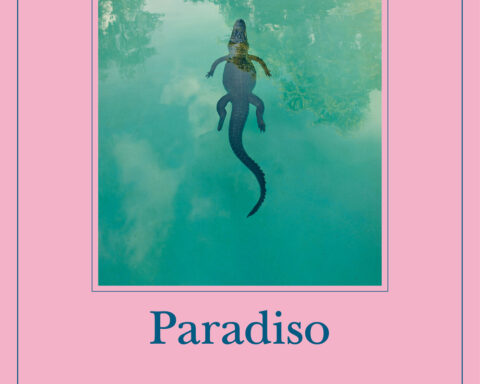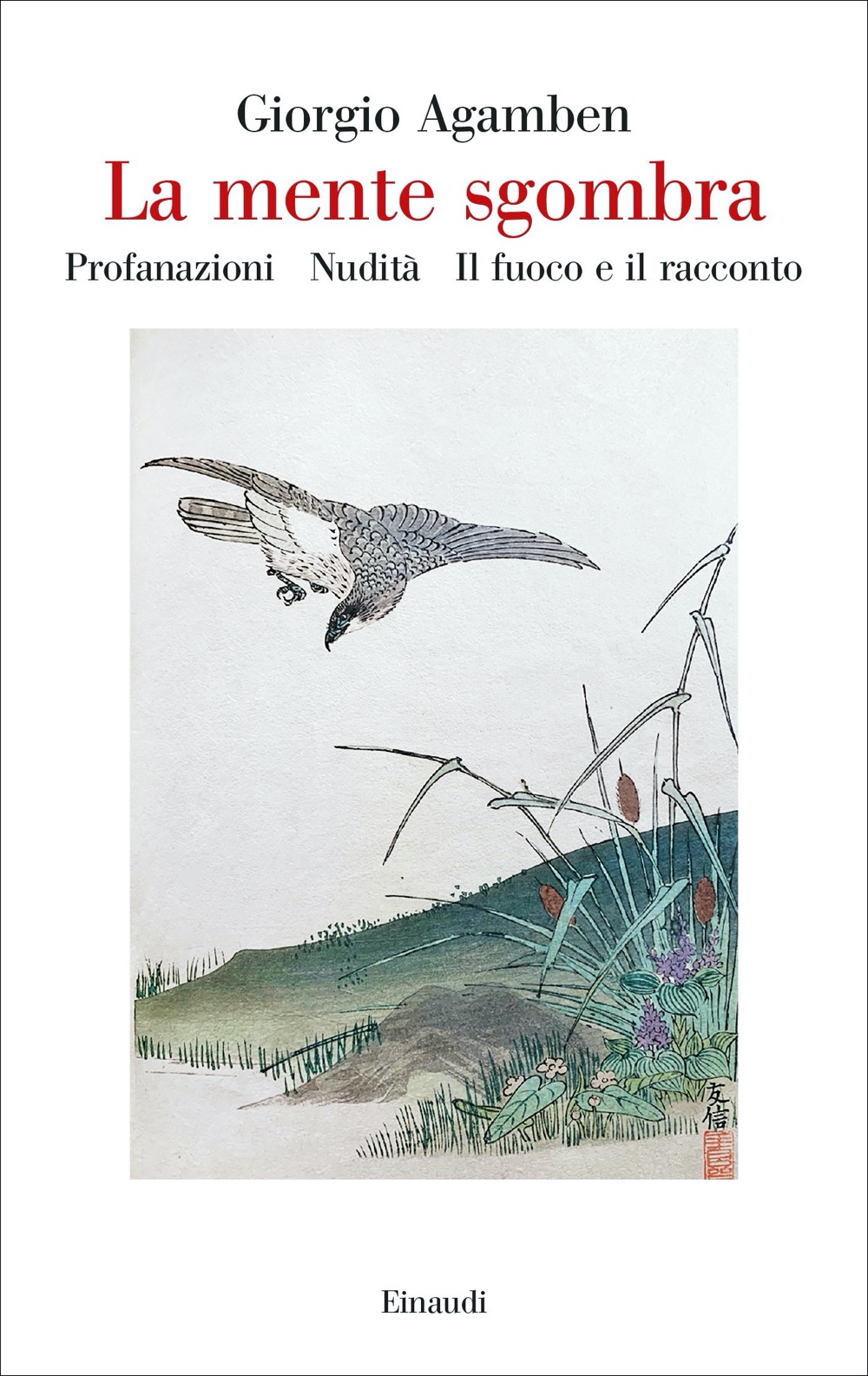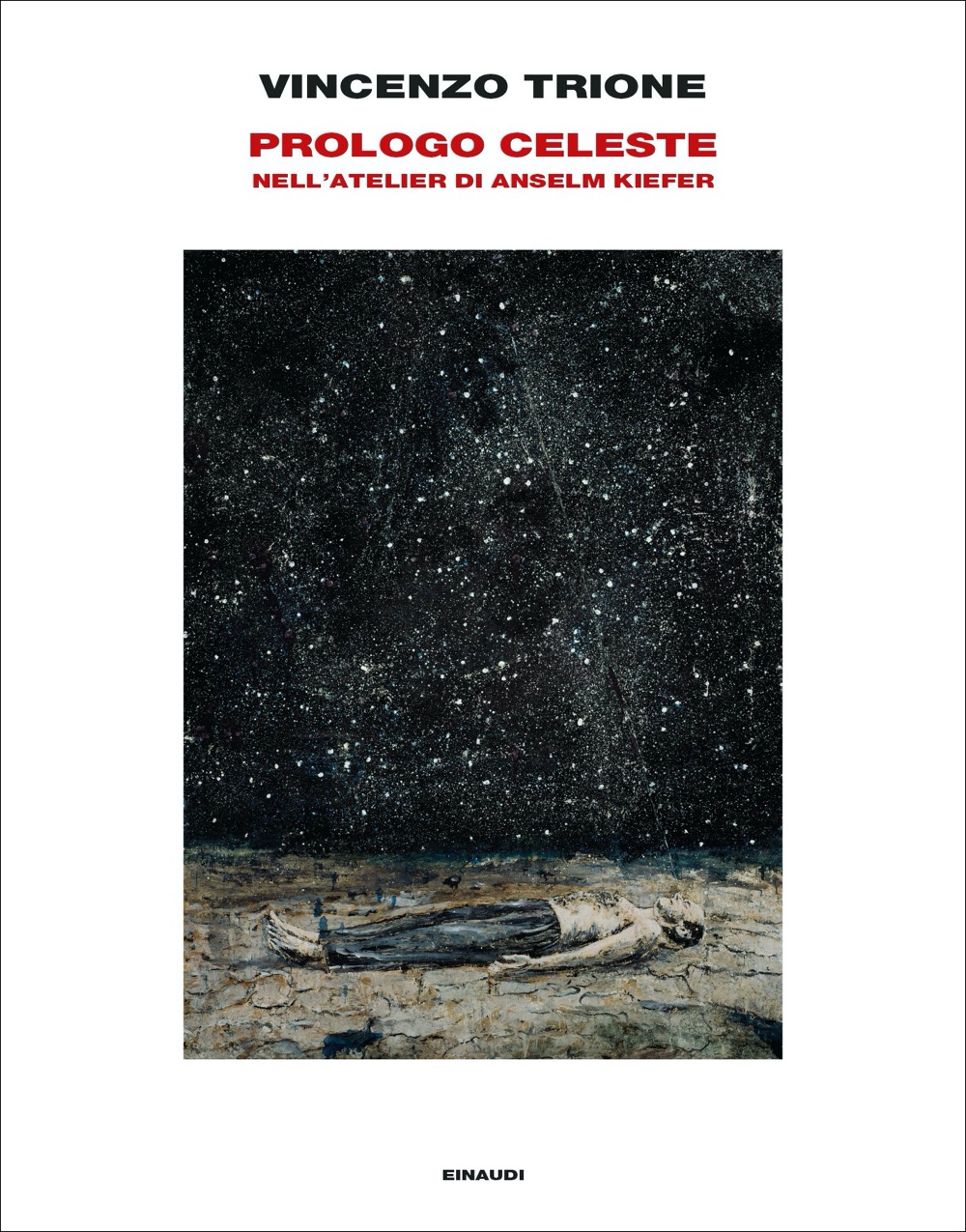Tutt’a un tratto si dà un’occhiata all’architettura del mondo e si scopre cos’è: un’ornamentazione universale dello spazio e null’altro. Dai minimi rapporti di grandezza, riproduzioni più grandi – tanto, si scopre che si è sempre stati perduti. Con l’età il pensiero si riduce al meccanismo di tortura che è lo sfiorare appena. Non c’è nessun merito. Io dico: albero e vedo enormi foreste. Dico fiume e vedo tutti i fiumi. Dico: casa e vedo i mari di case delle città. Così dico neve ed ecco gli oceani. Un pensiero in fin dei conti mette in moto tutto. La grande arte sta nel pensare in grande e in piccolo, nel pensare sempre simultaneamente in tutti i rapporti. Thomas Bernhard, Gelo, Adelphi, pag. 356.
Gelo (Frost) doveva essere originariamente il titolo di una raccolta di poesie del giovane Thomas Bernhard (1931 Heerlen, Paesi Bassi -1989 Gmunden, Austria) che l’editore Otto Müller rifiuta di pubblicare. Due anni dopo, nel 1963, uscirà a Francoforte per l’editore Insel, invece, il romanzo d’esordio che avrà lo stesso titolo della mai pubblicata, almeno interamente, raccolta poetica. Il romanzo, ora nelle novità Adelphi, ha un successo immediato. Il mondo letterario ne rimane folgorato per originalità di scrittura e di voce assolutamente rara e fuori dagli schemi di una cultura ancora intrinsecamente legata a modelli retrivi se non addirittura reazionari. In una conversazione avuta nel 1978 – Bernhard era ormai già uno scrittore affermato – con Peter Hamm, uno dei critici più influenti di allora, Bernhard evidenzia attraverso il ricordo del nonno, quelle che sono le sue insofferenze maggiori: avversione contro tutto ciò che è autorità, istruzione e stabilità. Si capisce, oltretutto, da questa intervista, cui lo scrittore non diede assenso di pubblicazione, l’intervista è stata pubblicata di recente per conto di Portatori d’acqua, il rischio di una lettura della sua opera in termini di mero autobiografismo, che peraltro avverrà e persisterà per lungo tempo.
D’altra parte, ritornando a Gelo, come potrebbe non manifestarsi una sorta di autobiografismo in un romanzo d’esordio? Tuttavia, se si esce da questa comoda ermeneutica, s’intende che Bernhard ha fatto della sua vita, della sua biografia – la sua infanzia tormentata, poi il collegio fino agli anni della malattia e del ricovero in sanatorio, in seguito anche i lavori più umili fatti per sopravvivere, o ancora la sua formazione al Mozarteum di Salisburgo – uno degli espedienti più riusciti per intercettare nella maniera più compiuta possibile un’idea di arte nella forma di una lingua. Una scrittura, quindi, che non solo è la cifra di un narrare ossessivo e incalzante, ma che diviene segno e ancoraggio dell’universo poetico di un autore che ha fatto del romanzo una metodica disciplina di esplorazione dell’orrore, sia per poterlo afferrare (penetrare) nelle sue inviluppate e destinali fortune sia per sottrarsene. Una scrittura assillante, opprimente e reiterata gli permetterà un’incisività e una penetrazione corrosiva e straziante fuori da ogni norma, quasi fosse la scrittura, un universo musicale a parte. Una partitura da dover dirigere e portare a termine a tutti i costi pena la dissonanza, la disarmonia, la stonatura. La letteratura ha moltissimo a che fare con la musica, dichiarerà Bernhard. E chi non ha conoscenze musicali, scrive, è già inadeguato in partenza. A Bernhard non gli interessa il contenuto, quanto piuttosto il ritmo, la riuscita di una scrittura, di uno spartito, di un’opera d’arte che diventa per questo illimitata, incondizionata, libera e ancora efficace e assoluta.
È utile a questo proposito leggere ciò che questo grande autore, tra i massimi del Novecento, scrive in L’origine (1975), primo romanzo di una lunga serie di cinque – è utile citarli un attimo: La cantina (1976), Il respiro (1978), Il freddo (1981), Un Bambino (1982) – che occupano la biografia dell’autore oltre che, letti tra le righe, un idea dell’arte come fascinazione della devastazione, del disfacimento, della corruzione, che sarà il cardine della sua produzione più matura ed esemplare. “… una cosiddetta mina aerea aveva colpito la cattedrale e la cupola era rovinata nella navata della chiesa. Tutta la piazza sotto la cattedrale era coperta di macerie, e la gente, accorsa come noi da ogni dove, guardava sbigottita quell’immagine esemplare, senza dubbio mostruosamente affascinante, una mostruosità che per me fu bellezza, e dalla quale non fui per niente spaventato”.
Ecco, guai a leggere Bernhard senza le dovute precauzioni. Lo stesso Bernhard, a proposito di Dostoevskij, dichiarerà di non essere per niente interessato ai fatti drammatici che l’autore russo raccontava nei suoi romanzi, ma a come li raccontava. Insomma, gli interessava la loro fattura. E si viene, finalmente, a questo tanto atteso Gelo che Adelphi manda in stampa nella traduzione di Magda Olivetti riletta da Marina Pugliano.
La storia è semplice, il libro racconta uno studente di medicina incaricato dal suo professore di svolgere un lavoro assolutamente segreto: osservare con attenzione e discrezione i bizzarri comportamenti del fratello, il pittore Strauch, che dopo aver bruciato tutti i suoi quadri, si è da qualche tempo ritirato in una sperduta valle, dove peraltro stanno costruendo una grandiosa centrale elettrica. La sua destinazione è dunque Weng, un luogo assolutamente cupo e malinconico, dove tutto sembra calcolato per riuscire fatale. Un posto, nonostante si tratti di una vallata, che si mostra subito come uno spazio claustrofobico impregnato di morte e desolazione. Gelo, appunto. Niente a che fare, quindi, con le immagini tipiche o da cartolina di un’Austria alpina e ridente, ma una feroce e irrispettosa descrizione di un vuoto, di una desolazione, di uno sconforto, di un orrore più vasto che ben si addice ai personaggi del romanzo, come anche si erige a segno di una critica feroce di Bernhard verso il suo paese natio. D’altra parte Bernhard non ha mai smesso di biasimare la condotta politica e la grettezza di una Nazione che riteneva alquanto oppressiva, dispotica e tirannica. Un’avversione talmente viscerale che le sue volontà testamentarie vietarono la pubblicazione delle sue opere letterarie come la rappresentazione di quelle teatrali in tutto il territorio austriaco. Una valle, quindi, come i suoi abitatori a dir poco inquietante e ostile, bieca e smisuratamente paradossale che si dà come un grande palco dove i personaggi della locanda, la moglie dell’oste, lo scuoiatore che fa anche il becchino, il distillatore di grappa, il gendarme e altre figure occasionali, ruotano in un vortice smanioso attorno alle due figure maggiori che sono lo studente e il pittore Strauch.
Ovviamente, il personaggio che primeggia su tutti è il pittore Strauch, capostipite di una lunga serie di personaggi cari a Bernhard, che con i loro intensi e ossessivi monologhi forniranno alla letteratura mondiale un’intensa ondata di scrittura ipnotica, seducente e martellante. Importuna. Asfissiante all’estremo della molestia. Una scrittura, uno stile che saprà, in ogni caso, unire l’efferatezza del vivere con la forma del romanzo. L’arte di Bernhard è, appunto, questa simbiosi di tecnica narrativa e di riflessione morbosa sull’esistenza. Forse, il solo modo per arrivare a quel nucleo nodale, necessario per Bernhard, di un pensiero provocante, indisponente, che stizzisce, che smuove quel tendere naturale della mente verso il suo riposo infernale. Verso la calma. Verso l’insulso, insomma. Verso l’inconsistenza di un’arte asservita. O di un’arte di stato. Essere artisti, scrive Bernhard in Colpi d’ascia (1984), vuol dire in Austria per quasi tutti asservirsi allo Stato e assecondarne i voleri per tutta la vita. Cosicché quella di Bernhard non è come si sostiene una letteratura nichilista, piuttosto la sua è una riflessione intransigente sulle prerogative dell’arte – si rammenti Antichi Maestri (1985) forse, il capolavoro assoluto di Bernhard – che come conseguenza non può che sfociare in profonde o parossistiche analisi sulla vita. Sentiamo, allora, il pittore Strauch, antesignano di tanti personaggi creati da Bernhard che ci hanno abituati a riflettere sui valori dell’arte e della sua imprescindibile necessità. – Non scriveva la Bachmann, grande poetessa tedesca, di quanto fossero necessari, indispensabili e inevitabili i libri di Bernhard? – Strauch: La tragedia non è sempre tragica, non è sempre vissuta come tragedia, benché si tratti sempre di tragedia… nessuna tragedia sconvolge il mondo. Nulla è tragico. Il ridicolo è infinitamente più potente di ogni altra cosa. Dentro il ridicolo vi sono tragedie in cui ci si addentra senza essere muniti di una lampada, come dentro una buia miniera. Nel ridicolo c’è la disperazione. È come se l’orrore fosse diventato realtà. Tutto si manifesta sempre in modo diverso. Il gelo per esempio… Ecco, questo e altri passi del libro, ce ne sono tanti e tutti di una magnificenza inaudita, escono dalla bocca di Strauch in una conversazione serrata con lo studente avvolgendo il lettore in una spirale frenetica di trascinante implicazione.
Non si vorrebbe più smettere di leggere, ma si continua come branditi da un incanto o da una disperazione, forse dovuta anche al fatto che non si riesce a intravedere un possibile esito del libro. E ciò ne accresce il fascino e la curiosità di là dagli effetti riflessivi, filosofici che il libro offre a piene mani. Una scrittura lucida, quella del giovane Bernhard, anche eccessivamente drammatica e pletorica, ma non ancora la “classica” scrittura di Bernhard, che tuttavia rivela già il talento e quella giusta dose di audacia che non manca in ogni buona letteratura. E che rivela man mano che si seguono le vicissitudini dei protagonisti (tutti), una sua coerente disamina della vita. E di come la vita intrinsecamente non può essere distinta da una buona razione d’imprudenza, o di follia. Ovviamente, si è nei territori di alta montagna, dove il pericolo è sempre imminente e i cambi di temperatura sono repentini e fatali. Che la montagna potesse avere affinità con le dinamiche dell’arte, oltre che della vita, non era per niente scontato. Bernhard, nel senso di questo libro dal titolo più emblema che sostanza, a distanza di anni continua a parlarci nella maniera più sorprendente possibile: restando un maestro di cui sembra impossibile poterne fare a meno.
[Thomas Bernhard, Gelo, Adelphi, pag. 356]