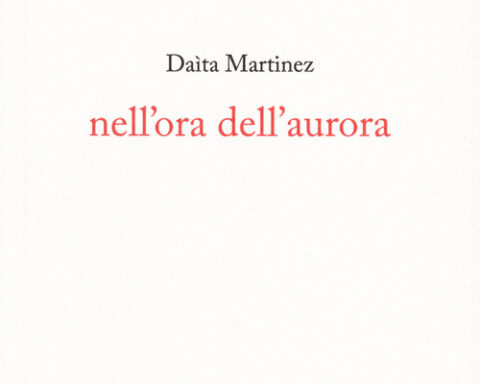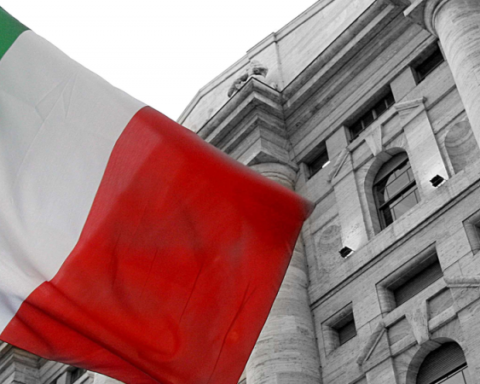In occasione di tre eventi che si terranno a Salerno (26 e 27 giugno 2024) alla presenza della scrittrice palermitana Cetta Brancato, organizzati dal Dipartimento di Studi Umanistici e dall’Osservatorio Interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità dell’Università di Salerno e l’Associazione Arcoscenico, torno ad occuparmi della scrittrice palermitana e della sua letteratura – nello specifico, poesia e teatro, ovvero teatro poetico – sempre di forte impegno civile e alta qualità letteraria: letteratura come testimonianza e denuncia di violenze, silenzi, omissioni, oblii; come strumento per recuperare voci di donne emarginate e silenziate dalla Storia ufficiale e più in generale di protagonisti, attori e vittime di atti di violenza e di soprusi aldilà di freddi resoconti storiografici, processuali, cronachistici.
Canto per Francesca
denuncia contro l’oblio
Il caso più eclatante e che si presta a molteplici letture è la marginalità a cui è stata relegata Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone morta con lui a Capaci. Il libro Canto per Francesca, di cui già mi sono occupata in queste pagine, è un monologo in prosa altamente poetica, alternato a una voce narrante, accompagnato da interventi ‘saggistici’ di Marcella Ferrara, Maria Teresa Ambrosini, Giuseppe Ayala, Amalia Settineri, Alessandra Camassa, che sottolineano la portata testimoniale dell’operazione e risaltano le capacità poetiche dell’autrice al fine di testimoniare un’esistenza stroncata tragicamente, che merita essere ricordata e valorizzata contro l’indifferenza e il silenzio che invece l’hanno avvolta: “L’autrice ha fatto dono della sua composizione all’ANM che, senza alcuno scopo di lucro, ne promuove la diffusione patrocinandone la stampa, affinché l’arte, dopo le loro opere, renda realmente vivi e immortali per le generazioni a venire Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicilio, Vito Schifani”.
Quindi, libro per ricordare “Francesca Morvillo, la moglie, la collega, la compagna che sostenne [Giovanni Falcone] e gli fu vicina, nella riservatezza che sfugge a ogni protagonismo, che scelse di restargli a fianco nei tempi difficili della sua vita professionale e personale e che pagò, essa stessa con la propria vita, tale scelta. Anche Francesca era un magistrato, un ottimo magistrato, di cui quanti la conobbero ricordano la sensibilità, l’intelligenza e la straordinaria dedizione al lavoro, specialmente alla tutela dei minorenni, ai quali dedicò la parte più significativa della sua professione […] La prima rappresentazione di quest’opera, con un dialogo a due voci, è il fulcro della commemorazione pubblica organizzata nel Palazzo di Giustizia di Palermo nel maggio 2017”.

Ed è stata rappresentata anche a Salerno il 28 settembre 2018, grazie all’impegno di Roberto de Luca e del compianto Francesco Forte, con letture degli attori Margherita Rago e Yari Gugliucci e nel luogo più adatto, l’Hotel Mare, confiscato alla criminalità organizzata.
Testo non facile, giacché al discorso sulla giustizia, sui delitti di mafia, su quella “soglia di marmo che separa il vivere dal morire […] Un’allerta di sensi da cui puoi tornare o non tornare mai più”, si affianca il discorso sommesso ma potente sull’essere donna magistrato in un mondo di uomini, ruolo conquistato solo nel 1960 grazie all’abrogazione dell’articolo 7 della legge n. 1176 del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche:
“Di lei, in questi anni, è rimasto solo il nome, / distrattamente pronunciato qua e là / e, subito dopo scordato, / ad apertura o chiusura di ben più ampi sermoni” recita Marcella Ferrara, giudice penale a Palermo, invitando la collega e amica Cetta Brancato a scrivere su Francesca Morvillo, “come atto di omaggio e di pietà di una donna a un’altra donna. / Perché non sia più dimenticata dagli uomini, persino da quelli che si dicono giusti”.
Una vita intensissima
tra labirinti e trappole
Mentre Francesca ricorda la sua vita con Giovanni e i lunghi giorni all’Asinara con la famiglia Borsellino, la voce narrante contestualizza e fa da contraltare ai ricordi intimi della donna, in una simbiosi convincente e drammaticamente realistica di micro e macro storia: “Fuori c’era Palermo, una volta […] Palermo, sovrana e operaia, rimane capitale di vezzi e di infamia. Donna, capace di oltraggi e di nobiltà, con pari furore prevarica infime case e dimore patrizie”. Sempre, la forza della parola poetica che infrange barriere e moltiplica sensi e percezioni di una realtà “mistica e volgare. Solo Palermo odora di pesce e d’incenso. E tanfo duro del potere. E sirene tante. Voci, come di lupo, sulle ampie strade che, instancabilmente, s’incrociano come labirinti o trappole, inondati dal sole di Sicilia. Fino al mare, dimenticato da tutti”. La polisemia del termine ‘sirena’ tra il luccichio del mare della Sicilia e i ‘labirinti o trappole’ della Palermo caotica e violenta ne è un esempio superbo, calzante e incalzante.
Difficile raccontare, riassumere: la voce di Francesca parla di sé donna, magistrato, moglie, vittima, sempre consapevole che il suo “sorriso di donna non è bastato al futuro, non è bastato all’amore”.
Poche parole per il suo lavoro nel “Tribunale dei minori, in cui i figli non tuoi lo diventano nella culla della giustizia, laddove il rigore si piega alla guida comprensiva di chi ancora deve attraversare la vita” perché il protagonista è sempre Giovanni, anche quando, entrambi “già frutti perfetti da consegnare alla storia”, Francesca descrive senza rabbia quel momento ultimo, quell’attimo sospeso tra vita e morte: “Forse, chi non ha mai pensato alla morte diventa subito immortale. Ma chi l’ha masticata, vivendo, la riconosce. Vi entra e vi sosta”. E la racconta…
L’unica magistrata
vittima della mafia
A Francesca Morvillo Cetta dedica anche un successivo lavoro, Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo (2022), a cura di Cetta Brancato, Giovanna Fiume e Paola Maggio, pubblicato dalla Treccani: “una ricostruzione corale di amici, colleghi e studiosi, [che] vuole rendere giustizia alla sottovalutazione dell’unica magistrata vittima della violenza mafiosa [oggetto di] una ricostruzione infedele e una rimozione collettiva” (bandella). Qui si evidenzia la vicinanza di Cetta Brancato, avvocata lei stessa, al mondo e ai protagonisti della Giurisprudenza siciliana, e si apprezza anche l’abbandono di un registro fantasmagorico e creativo a favore di una condensata narrazione di una vita e un sentire caparbiamente ancorati alla realtà evenemenziale.
Mi sono soffermata sui testi su Francesca Morvillo principalmente per un innato e dichiarato interesse di genere e di parità di genere, ma non posso non menzionare il precedente 19 luglio 1992 (2010), atto unico sulla strage di Via D’Amelio di cui Andrea Camilleri ha scritto parole attribuibili a tutto il teatro di Cetta Brancato, e che quindi cito a profusione sottoscrivendone ogni parola (19 luglio 1992 (vigata.org)):
“Cos’è questo testo drammatico (drammatico non solo nel senso di scritto per essere destinato alla scena) di Cetta Brancato che s’ispira a un fatto di sangue ad opera della mafia, […] fatto che sconvolse non solo la Sicilia ma l’Italia intera ed ebbe vaste ripercussioni nel mondo?
Certo che è, formalmente, esternamente, un atto unico, […] ma è una definizione, a mio parere, assolutamente riduttiva. […] Perché il suo cosiddetto atto unico è in realtà qualcosa che sta a mezzo tra l’oratorio e la sacra rappresentazione. Che sono già di per sé tra le forme più alte e nobili dello spettacolo. Ma sono portato ad azzardare di più: direi che questo della Brancato è soprattutto un poema a più voci, destinato anche alla recitazione, […] testo cioè che può essere solo letto, o solo ascoltato, e venir recepito lo stesso in tutta la sua interezza (e bellezza); dove la voce e il gesto dell’attore insomma diventano un complemento naturalmente importante, ma non rappresentano una conditio sine qua non.
E questo avviene perché nella drammaturgia della Brancato la parola è veramente tutto. […] 19 luglio 1992 è sì un poema che rende omaggio a un sacrificio, ma è, a mio parere, soprattutto un inno a quello che Merleau–Ponty chiamava l’unico eroe tragico possibile dei nostri giorni: l’uomo, quell’uomo che continua a fare quel che fa credendovi e pur sapendo perfettamente che lo scacco, il fallimento, la sconfitta, sono in ogni momento in agguato”.
Dal testo teatrale prende spunto il film di Antonio Raffaele Addamo Con gli occhi di un altro (2010), sceneggiatura di Brancato e Addamo, che amplia la situazione includendo comprimari e personaggi che prolungano nel tempo, dopo l’attentato, sensi di colpa, incubi e speranze.
Giovanni e Paolo
figure indissolubili
Anche per Cetta Brancato, quindi, Falcone e Borsellino sono indissolubili, ma suo grande merito innovativo è stato quello di aver costruito un trittico introducendo a pari merito Francesca Morvillo che a sua volta ha aperto la strada a tante donne dimenticate.

Su mafia, donne e giustizia ritorna infatti in un’altra opera teatrale, anche questa leggibilissima come puro testo narrativo, Mafia; singolare, femminile (2020), scritto in collaborazione con la magistrata Marzia Sabella, autrice a sua volta con Serena Uccello del testo Nostro Onore (2014) che rivendicava la ‘normalità’ dell’esperienza di donna-magistrato, ancor più in condizioni estreme e società tradizionalmente patriarcali come quella siciliana. La firma di Sabella, come le firme di tanti magistrati sia in Canto per Francesca che in Non solo per amore, rivendica e garantisce la fedeltà alle fonti giudiziarie e la correttezza di informazioni e procedure. Mafia: singolare, femminile presenta anche una introduzione puntualmente storicistica di Rosy Bindi che ne ricorda la prima rappresentazione nel luglio 2017, al teatro greco di Segesta, come commemorazione ufficiale a 25 anni dalla strage di via D’Amelio, voluta dalla Commissione Parlamentare Antimafia e l’Associazione Nazionale Magistrati: dinanzi a un carcere siciliano otto donne in qualche modo collegate ad azioni di mafia, più una prefica che scandisce con litanie funeste il susseguirsi delle figure femminili e un coro di ‘donne di mafia’ che gridano parole sconnesse, disordinatamente sovrapposte, ai loro uomini detenuti nel carcere, raccontano una società femminile diversificata nei ruoli e nella cognizione del fatto mafioso, spesso smentendo “il preconcetto sulla tardiva emancipazione della donna siciliana, unito alla consolidata quanto parziale lettura di Cosa Nostra come un’organizzazione maschile” (Bindi). C’è tanto da imparare e da riflettere ascoltando queste voci, da Santina che condanna il figlio collaboratore di giustizia difendendo la scelta radicale di omertà e fedeltà alla mafia, a Roberta, avvocata evoluta e raffinata, figlia di un capomafia detenuto, che nasconde tra le carte processuali pizzini e materiale proibito, a Monica, dottoressa dell’alta borghesia, incredula nello scoprire che suo marito, ostinatamente muto alle sue domande, è una “ specie di statista per uno stato di merda che si chiama Cosa Nostra” e che malinconicamente afferma: “Neppure la cultura ci ha reso liberi”.
Letteratura testimoniale
nel segno di Primo Levi
Voglio anche ricordare la ‘cura’ prestata da Cetta Brancato a L’inferno di Pianosa di Rosario Enzo Indelicato (2015), nella cui premessa scrive, ricordandoci tanta ‘letteratura testimoniale’ da Primo Levi in avanti: “Non si racconta l’inferno. Non. Non lo si immagina, neppure. Se non lo si vive. I lager impongono a chi ne sopravvive anche l’impossibilità del narrare: tranciano ai superstiti ogni voce, impalano la memoria sul legno del silenzio”.
Indipendentemente dalla colpa commessa, e/o attribuita in un processo, la testimonianza di Indelicato evidenzia una pena inammissibile, una condanna alla non-vita.
E al lager, quello indiscusso, dove sono approdati ebrei con la sola colpa di essere nati (libro di Liliana Segre e Gherardo Marone) e oppositori politici al nazifascismo, è dedicato La baracca degli intellettuali (2021), un altro atto unico in tre scene (Il carcere di San Vittore, Il campo di Fossoli, il campo di Mathausen-Gusen), pubblicato con una testimonianza di Liliana Segre e la prefazione di Giuliano Banfi: ricostruzione drammatizzata del rapporto e delle lettere autentiche tra Julia e Giangio, genitori di Giuliano, separati dalla brutalità fascista. Presentato nella Biblioteca Nazionale di Roma a cura dell’Anpi, è, anche nelle modalità di divulgazione e promozione, l’ennesima prova delle capacità di Cetta di muoversi su più livelli e linguaggi, sempre innalzando la bandiera della funzione civile della letteratura: “La baracca degli intellettuali rinnova la sfida di fare arte dopo la shoah […] si riconosce nella poesia e nell’arte l’unico modo per provare a dire l’indicibile, per rappresentare l’irrappresentabile” (Segre).
Camilleri, Segre, Valdini
il coro della legalità
Non sfugge a questo precetto neanche Ancora non è giorno (2019), sei atti unici prefati da Guido Valdini che ribadisce le parole di Camilleri sul versante della forma e del linguaggio e di Liliana Segre sul versante etico e concettuale: “la parola è costantemente liminare alla visione, nel senso che si mantiene sulla soglia della percezione […] pronta ad abbandonare quel che è dicibile per affidarsi all’immaginario di ciò che non è rappresentabile […] E in un tempo di diffusione barbarica, un teatro di poesia è tanto disperatamente inattuale, quanto inquietantemente benvenuto”. A tutti i prerequisiti perché testi di diverse tipologie di forme e contenuti possano entrare ‘di diritto’ in un discorso sulla ‘funzione civile della letteratura’ risponde pienamente Le stanze della luna che, leggiamo al finale, “è liberamente tratto da un omicidio avvenuto a Palermo […] Un uomo, fino a quel momento ritenuto donna e badante di un invalido, viene trovato cadavere nel bagno dell’abitazione. Unico testimone il giovane paralitico, immobilizzato su una sedia a rotelle e privo di facoltà mentali”. Quindi, un atto di violenza in uno spazio tendenzialmente claustrofobico, perpetrato ai danni di un soggetto – oggetto? – fragile, passibile di interpretazioni e letture morbose, che diventa metafora di vita ‘orchestrata’ da un misterioso ‘uomo in nero’ – prete, carabiniere, direttore d’orchestra, becchino, magistrato, mago, sempre ingabbiato in una divisa disumanizzante ma portatrice di potere – che incarna insieme il bene e il male, la legge e il sopruso, e descrive e giudica quella morte ripetuta ma sempre diversa, come diversa è l’identità che viene attribuita di volta in volta alla donna-uomo e al suo cadavere. Rapporto delicatamente ambiguo tra l’invalido e il suo custode, un dialogo su codici indecifrabili, un tamburo stretto tra le gambe del paralitico e suonato / percosso in infinite sfumature e lettere vergate dalla donna-uomo su specchi come paraventi mobili che ispirano nell’invalido suoni e, forse, sogni surreali: la ‘S’, ad esempio, “ha una velocità folgorante: appare e riappare come un bambino fra le gambe del padre. È simbiotica, ammalata d’amore. Aderisce alle consonanti e alle vocali nel tono sordido del sibilo […] E la ‘V’? La zanzara dell’alfabeto con due alucce trasparenti, eppure così insidiose. Si presenta alla fine, apparentemente innocua. Nella filastrocca dei suoni sembra scomparire, ma essa è madre di violenza, di veli, di vertigine, di vento”. Mentre “Sugli specchi navigano consonanti e vocali” prende corpo un’utopia che entrambi sembrano agognare: “Desideri uscire? […] Ti porterò al mare. Conosco una piccola spiaggia dove si ascolta il canto delle sirene e, finalmente, potresti dialogare senza il tamburo. La loro foce sonora nasce in una grotta di sangue, proprio come la tua: per questo ammaliano gli uomini. Per una sola volta saremmo felici. Dimmi di sì”.
Ancora una volta, la sirena ritorna nel mondo di Cetta Brancato per farci immaginare, o almeno sognare, un mondo migliore.