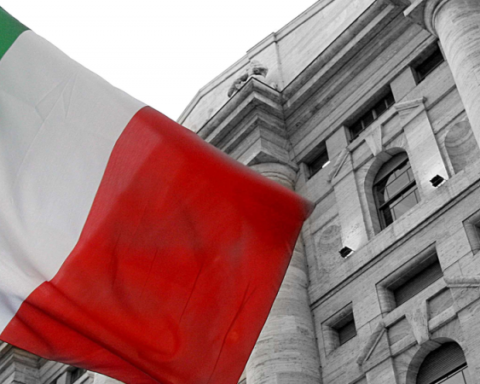Severissimo con la televisione già dalla fine del secolo scorso – con essa sarebbe scomparso l’«Homo sapiens» soppiantato dall’«Homo videns» – il professore Giovanni Sartori, uno dei più importanti fondatori della scienza politica nelle nostre università, aveva intravisto nell’affermazione dei talkshow un segnale confortante in grado di bypassare due strettoie: la sotto-informazione e la disinformazione. Una luce flebile – erano gli ultimi anni del passato millennio – nella notte incombente della video-politica, che da lì a qualche anno avrebbe generato la teledemocrazia e la conseguente fine delle idee chiare e distinte. I talk ai quali faceva riferimento Sartori spopolavano negli USA e in Inghilterra ed erano gestiti dai migliori giornalisti sul mercato. Tutti bravi e indipendenti: chi non ricorda Walter Cronkite, “l’uomo più creduto d’America”? A nessuna mezza tacca avrebbero mai affidato un confronto tra due leader popolari portatori di tesi contrapposte.
La qualità dei conduttori non era, però, il solo motivo alla base del moderato ottimismo critico mostrato dal severo studioso fiorentino. La sua considerazione di fondo era un’altra: l’immagine, da sola, mente (si pensi al montaggio, alle alterazioni cronologiche delle sequenze, alla decontestualizzazione), la parola invece no, o non del tutto, specie quando il contraddittorio potenzia la verosimiglianza dei concetti espressi.
 C’era, quindi, molto stile radio nella tv “tollerata” da Sartori. Un campione vasto (alcune decine di migliaia di intervistati), in quegli anni, fece scoprire al “Daily Telegraph” che le bugie sono scoperte facilmente dai radioascoltatori (73%), molto meno dai telespettatori (non più del 50%). La parola, dunque, surclassava l’immagine sul piano della verità. Un balsamo per la democrazia, in anni di iniziale progressivo indebolimento dei partiti politici. Mancava ancora più di un lustro al baluginare del terzo millennio quando Sartori argomentò la sua tesi su “televisione e post-pensiero” e già negli Usa il talk show politico, nato a rischio di adulterazione, fu considerato “scaduto”, proprio come un genere alimentare andato a male. Era accaduto che Ross Perot, un imprenditore ricchissimo di soldi e non di talenti, raccogliesse nelle elezioni presidenziali del 1993 un quinto del voto americano solo grazie alle apparizioni televisive lautamente pagate. Un presagio della fine dei partiti? No, non della fine, tant’è che i partiti erano e ancora sono presenti ovunque come spettri, ma la rappresentazione anticipata, quella sì, del passaggio dall’era del partito “pesante” all’altra della sua versione ultraleggera, incline cioè allo show televisivo e portatore di deboli e mediocri informazioni.
C’era, quindi, molto stile radio nella tv “tollerata” da Sartori. Un campione vasto (alcune decine di migliaia di intervistati), in quegli anni, fece scoprire al “Daily Telegraph” che le bugie sono scoperte facilmente dai radioascoltatori (73%), molto meno dai telespettatori (non più del 50%). La parola, dunque, surclassava l’immagine sul piano della verità. Un balsamo per la democrazia, in anni di iniziale progressivo indebolimento dei partiti politici. Mancava ancora più di un lustro al baluginare del terzo millennio quando Sartori argomentò la sua tesi su “televisione e post-pensiero” e già negli Usa il talk show politico, nato a rischio di adulterazione, fu considerato “scaduto”, proprio come un genere alimentare andato a male. Era accaduto che Ross Perot, un imprenditore ricchissimo di soldi e non di talenti, raccogliesse nelle elezioni presidenziali del 1993 un quinto del voto americano solo grazie alle apparizioni televisive lautamente pagate. Un presagio della fine dei partiti? No, non della fine, tant’è che i partiti erano e ancora sono presenti ovunque come spettri, ma la rappresentazione anticipata, quella sì, del passaggio dall’era del partito “pesante” all’altra della sua versione ultraleggera, incline cioè allo show televisivo e portatore di deboli e mediocri informazioni.
Sartori è scomparso circa sette anni fa e ha avuto tutto il tempo di assistere alla deformazione populistica di questo genere televisivo con i politici protagonisti: avrà assistito al “contratto con gli italiani” di Silvio Berlusconi, sottoscritto nel corso della trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa l’8 maggio 2001, cinque giorni prima del voto. Una banalizzazione dell’atto e del gesto politico attraverso la più strumentale operazione giornalistica che si ricordi. Sono seguite, da allora, tante altre proposte attraverso le quali le reti televisive sono diventate rivali in conformismo, sostituendosi di fatto a forze politiche ormai evanescenti. Segno del tramonto di un modello televisivo, appunto il talkshow, che pure vanta storia e titoli di nobiltà, in Italia sin dai tempi di “Bontà loro” (1977) e negli Usa con una nascita precoce e una vitalità straripante, sin dagli anni ‘50, quanto da noi la tv non era ancora nata.
Tanti i dubbi sul genere
Funzione democratica?
Il dato sensibile più rilevante del calo qualitativo di un genere lo si può rilevare dentro un luogo comune che si annida nella retorica televisiva: è considerazione diffusa che il messaggio inviato alle famiglie attraverso l’elettrodomestico più insostituibile della contemporaneità sia “democratico”, nel senso che diffonda in lungo e in largo informazioni, idee, progetti, sintesi ottenute dal confronto tra tesi anche aspramente contrapposte. Purtroppo, tale considerazione, in più circostanze, si rivela alla prova dei fatti ingannevole, tant’è che finiamo per attribuire eccessivo valore a un demo-potere mediatico inconsistente. Circola, attraverso il video, l’idea di un demos svilito e atrofizzato e l’illusione di una democrazia resa “diretta” dal video si trasforma in un messaggio simil-democratico manipolato dai media, in particolare dalla televisione che si è auto-conferita la doppia funzione di informare e di educare alla politica. Una sorta di illusorio dominio simbolico delle masse ottenuto attraverso una perniciosa e quotidiana “malnutrizione informativa”. Concordano, su questo punto, studiosi di sponde anche lontane, da Ionescu a Fisichella, vicini entrambi alle posizioni critiche di Giovanni Sartori.
Le prove della mutazione del campo giornalistico, anche a causa delle spudorate tecniche di mediatizzazione e spettacolarizzazione utilizzate nei talkshow, le verifichiamo ogni sera, sulle reti private o del cosiddetto servizio pubblico, ricavando l’impressione di una informazione vagante e casuale, finalizzata a diffondere più rumori di fondo che conoscenze. Gli ospiti sono in balia di conduttori straripanti e militanti, spesso inadeguati e pretenziosi, specie sul piano etico, intenti a pilotare le discussioni pro o contro il convitato di pietra che, da circa un anno, è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non c’è accadimento, area tematica, traccia d’inchiesta, indizio di responsabilità, presunta avvisaglia di combine che non venga riferita a lei: ma, al contrario di quanto vorrebbe certa opposizione, come ha evidenziato finanche Paolo Mieli, questi attacchi continui finiscono con il raggiungere il risultato contrario. Guai ad opporsi, invocando il beneficio del dubbio o respingendo il collegamento inconferente o incongruo. Si costituiscono così conglomerati mediali che, da una parte e dall’altra, riconducono a concentrazioni proprietarie o dirigenziali di quelle testate, a spazi occupati in sostituzione di partiti o aree politiche. La pervicacia non conosce limiti e, se proprio al convitato di pietra non è possibile attribuire una colpa grave, si recuperano filmati in cui il protagonista assente sosteneva anni prima cose diverse, fornendo la ulteriore prova della carente cultura del conduttore che, evidentemente, considera la politica un’immutabile statua di sale, una verità assoluta e pura, guarda caso dilatabile da un giornalismo impuro e indebitamente protagonista.
Demonizzazioni
o beatificazioni
In queste operazioni di demonizzazione o beatificazione si procede con la correità di direttori o editorialisti di testate sfinite o decotte che partecipano al crudele gioco dell’assassinio dell’informazione. Massimo Giannini, tra i volti più presenti, qualche giorno dopo la immane tragedia di Cutro, titolò sul quotidiano che gli avrebbero scippato da lì a poco “Strage di Stato”. Una sentenza emessa prima di un processo e di un’indagine, per il solo gusto di assaltare la diligenza dell’attuale pallido potere. Dei difensori mediatici di quest’ultimo, poi, difficile parlare senza riferirsi all’intrigo e alla satira da vaudeville. Si proclamano ideali e metodi liberaldemocratici ad ogni parola ma, di fatto, si costruisce, a sera, con l’apparente bonomia dei propositi proclamati (sono, in effetti, regressioni erratiche stranianti), un cordone di protezione intorno al governo, esasperando presunte contraddizioni di tutte le critiche, anche di quelle giuste, e dimenticando la destinazione sociale dei messaggi, gli statuti essenziali dell’informazione, soprattutto non separando, quasi mai, gli spot dalle notizie e dal quadrante dell’attualità. Anche in queste arene, imperversano direttori ed editorialisti di giornali che ormai non legge più nessuno. Un tempo chi dirigeva i quotidiani passava le notti a perfezionare i prodotti in tipografia e solo in qualche circostanza guadagnava lo schermo domestico, esclusivamente per pubblicizzare la propria testata. Oggi si è ospiti dei talkshow per altri motivi, se è vero che i quotidiani italiani vendono, rispetto a vent’anni fa, poco più di un decimo di quelle copie, e alla sonora bocciatura del mercato non si sottraggono nemmeno le due maggiori testate italiane. Tra l’altro, il ring pro o contro-governativo non produce alcun risultato. A circa un anno dalla formazione del governo, i sondaggi dimostrano che i dati di consenso restano gli stessi, segno che la metà degli italiani che ancora va al voto rimane dov’era: per il 30 per cento vicino alla Meloni e per il resto frastagliata in varie sigle nelle quali storicamente si divide la sinistra.
Tornando al talkshow decaduto a becera propaganda videopolitica, c’è chi obietta che alla fine potrebbe svilupparsi tra le reti una naturale concorrenza di mercato, con conseguente potere autocorrettivo dell’informazione. Purtroppo, non è così e non lo è nemmeno negli USA, dove non è mai esistita una televisione di Stato e si è preferito un giornalismo radicalmente autonomo e indipendente. Le proposte, soprattutto qui da noi, non si differenziano se non nell’obiettivo demolitorio o di supporto da raggiungere. Metodologicamente, invece, si sovrappongono, con svilimento del tratto identitario di ciascuna di essa.
Se la politica virtuale ha diluito (o sostituito) ciò che resisteva della realtà partitica di un tempo, anch’essa ora appare lontanissima da qualsiasi pretesa funzione surrogatoria. È una proposta sempre più fuori dal mondo. E così alla distruzione della politica si accompagna la decadenza della cultura della notizia. La rete, alla quale ci si accosta senza possedere i mezzi per individuare e selezionare i fatti del giorno e farli diventare notizie, è diventata così invasiva, iper-popolata, straniante. Forse anche per questo rimpiangiamo i tempi dei talkshow-evento, quando al timone c’erano i Walter Cronkite e nella società i partiti erano forti e, soprattutto, impermeabili al giornalismo che oggi ne fagocita anche le spoglie.