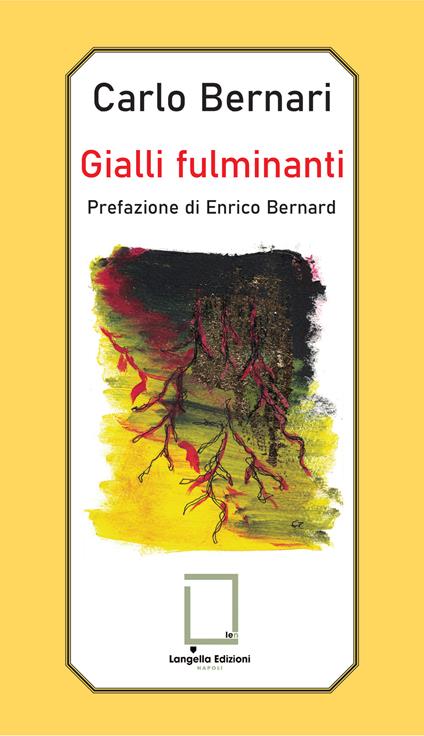Eccolo, dunque, il segreto che ero venuto a cercare in quella terra in mezzo al mare d’erba, ai deserti di cenere e di roccia, alle montagne sconosciute. Del grande impero di Gengis Khan non restava neanche una rovina, neanche una pietra che ne portasse il segno; soltanto una leggenda, nata da un vecchio sogno di dominio universale che il popolo mongolo porta da secoli nel cuore. Non saprei dire quanto mi turbasse una simile rivelazione, l’idea di un gruppo di uomini nascosti – al contempo sacerdoti e guerrieri, mistici e politici –, intenti a lavorare pazientemente per insinuarsi nei disegni che fanno avanzare il mondo, al fine di preparare una conquista prodigiosa. Non hanno né cannoni, né soldati, né tesoro, né Stato. Il loro unico potere è un potere mentale. Così come l’Occidente, per dominare, si serve di scienze e arti matematiche, fisiche, chimiche, Agartha si serve di scienze occulte, i saperi della Mente, così da forgiare armi mai viste, stabilire il proprio potere, portare a maturazione la propria impresa apocalittica. Peské Marty, Qui il sentiero si perde, Adelphi, pag. 446.
Esistono alcuni libri, è scritto nell’aletta di presentazione di quest’ennesimo singolarissimo e affascinante libro che Adelphi ci propone, che assomigliano alla felicità. L’asserzione è di Leonardo Sciascia che lo scrisse a proposito di titoli come L’isola del tesoro, Il conte di Montecristo. Michele Strogoff. Non ci sarebbe altro da aggiungere se questo libro, oltre alla piacevole sensazione di catapultarci in altri mondi, non ci riportasse inesorabilmente al nostro, com’è ovvio che sia quando la letteratura si dà nella sua essenza inattuale, ibrida di spazi incommensurabili, sconfinati, siderali come di luoghi familiari, confidenziali e segreti. In altre parole, si è al cospetto di un romanzo in un certo qual modo inclassificabile – com’è, d’altra parte, nella tradizione dei libri Adelphi – sebbene si possa parlare di un libro di avventure, di un romanzo d’amore, di un libro impregnato di una spiritualità ampia, attorta e tortuosa, sinuosa e ambigua e, per molti versi, sofferta, dolorosa e vertiginosa.
Un libro sensuale dove chi ha voglia di meravigliarsi può farlo anche senza l’ingenuità dovuta verso una narrazione che in apparenza si mostra come fantastica o irreale. Non è forse un’altra caratteristica di una buona letteratura? Non è forse una buona letteratura quella capace di farci vivere momenti di riflessione insieme a lampi di evasione, magari almanaccando di territori lontani e inaccessibili? O pensiamo che tutto sia già stato detto e riferito e visto, e per questo non possiamo far altro che attenerci al dato, al mero e cinico fatto di un reale che pare essere sempre più strettamente e minuziosamente controllato, standardizzato nella sua evidenza servile e inutile, per non dire banale e oltraggiosa? “Qui il sentiero si perde”, allora, diventa un viaggio nell’immediatezza di una crisi, nell’istantanea di una metafora di costruzione, di origine, di genesi. Lo stesso protagonista del romanzo che si divide nei tre racconti in cui è diviso il libro è lo stesso che senza un Nome si dà nei mutamenti dell’esistenza, negli amori come nei combattimenti feroci, nei fiotti di sangue che sgorgano dalle lacerazioni profonde, brutali e inumane di un Uomo che è sempre in fuga e sempre alla ricerca. Di un Uomo che è sempre mancante. Di un Uomo che è destinato all’insoddisfazione. Di che cosa l’uomo ha bisogno, allora? Di salvarsi? Di avere un Dio? Di essere sapiente? Di essere vivo, innanzitutto? Per inoltrarci ulteriormente in quest’Uomo che può essere addirittura lo zar Alessandro I, vincitore di Napoleone, che secondo la leggenda non sarebbe morto nel 1825, ma per altri quarant’anni avrebbe condotto una vita segreta di vagabondo, prima monaco, poi schiavo, cercatore d’oro, mendicante, discepolo di un Lama, possiamo riferire che questo viaggio vertiginoso e senza fine che si svolge dall’Ucraina al Caucaso, dagli splendori di Samarcanda e di Bukhara alle tende dei nomadi kirghisi, dai deserti della Persia alle pianure innevate della Siberia, è come ogni vero cammino saturo di avvenimenti e d’incontri. Di amicizie spietate e di sogni. Di esagerazioni e colpi di scena che nulla tolgono alle pagine dove l’amore è il protagonista assoluto e illimitato. Pagine intense, anche poco condivisibili ma che fanno di questo sentimento un incondizionato impulso, una passione irrefrenabile quanto instabile e menzognera. “Non era il piacere a unirci, ma il fatto di sentirci entrambi miserabili, e la paura. Una paura che durò fino allo spuntar del giorno…”. Tre donne ne affiorano, la schiava Sarasya, la zingara Maluzia e la possibile sposa Maša, figlia del patriarca Gleb Trofimovič. Tre storie d’amore simili eppure diverse. E pagine di estrema bellezza. Tuttavia ciò che s’incontra è il dolore e la solitudine. L’ascesi e la magia. O i demoni e altre figure simili. Oltre, ovviamente, e come si addice a un buon romanzo d’avventura, a una serie di personalità che indicano la più spregevole o straordinaria accozzaglia umana che si possa incontrare: saltimbanchi, cacciatori di orsi, mercanti di pelli, ladri di cavalli, bari, assassini, zingari, ubriaconi, puttane, pellegrini, spie, dervisci, sciamani, capi tribù, sapienti di ogni tradizione e cultura, individualità affabulatorie, eccelse, sacre, divine o profetiche. E, naturalmente, paesaggi di rara magnificenza. “Ai nostri piedi, fin giù nella valle, si estendeva l’immenso bosco trasformato dall’autunno in un giardino selvaggio e sontuoso. Che festa! Il popolo convulso degli alberi mescolava i suoi abiti fulvi, rossi, viola, porpora, cupole di seta, arpe d’argento, fiamme d’oro. Uno specchio d’acqua, nel profondo della valle, captava quello sfavillio col suo occhio blu. Ma sopra… sopra le gole, i crepacci vertiginosi, le rocce; sopra l’oscuro esercito di abeti, cedri, e larici su cui fluttuava un vapore verde – sopra a tutto ciò, le vette innevate si consumavano nella pure luce!”. Gli ultimi capitoli della terza parte del libro dal titolo “Il mendicante di Dio”, forse sono i più belli in senso mistico e sapienziale. Il protagonista che prima aveva incontrato Dio nella figura di Cristo ora incontra il Buddismo nel silenzio della Mongolia e del Lama che gli fa da guida spirituale. Capitoli da leggere attentamente, perché sono insieme un piccolo compendio di sapienza orientale e saggezza buddista. “Agli occidentali la figura del cerchio ha permesso di concepire il mondo come luogo finito e se stessi al suo interno. Ne hanno ricavato una geometria, una meccanica adatte ad affermare il loro potere su questo mondo. Per gli orientali il cerchio è il simbolo del mondo nella sua infinitezza, ovverosia nell’impossibilità in cui si trova l’uomo di concepirlo, di stabilirvisi, di sottometterlo. La vanità della nostra scienza, del nostro potere, della nostra esistenza, ecco il senso profondo della ruota.” Alla fine, dopo un lungo percorso fatto di prove dure da temere e da superare, la frase venerata “Om mani padme hum” è svelata. La via della consacrazione è ultimata. “Così mi misi in cammino. Ovunque io vada, lei mi precede. La luce nasce davanti ai nostri passi. Il sentiero perduto si rivela. Non erro più. Tutto è chiaro…”. Qui il sentiero si perde! La domanda chi sia quest’uomo protagonista di questo romanzo non smetterà di assillarci né tantomeno ci interesserà sapere se egli sia lo zar Alessandro I o altri, un decabrista, un fratellastro o il suo assassino. Forse, si tratta solo di una leggenda tramandata legata ai tanti sviluppi misteriosi della morte di chi aveva sconfitto Napoleone e aveva perso in giovane età la figlia Sof’ja Dmitrievna che aveva avuto da Marija Naryškina. Sta di fatto che Tolstoj aveva creduto che lo zar non fosse morto nel 1825, ma solo sostituito nella bara. Tuttavia, di là da questo pur seducente aspetto, il libro resta un viaggio vertiginoso dell’anima. O di chi, in cammino continuo, ambisce a possederne una.
[Peské Marty, Qui il sentiero si perde, Adelphi, pag. 446]
Antoinette Peské (1902-1985), figlia del pittore Jean Peské e discendente per parte di madre da una famiglia di principi mongoli, iniziò a scrivere poesie all’età di otto anni, attirando l’attenzione di Apollinaire. Fu autrice di vari romanzi, il più noto dei quali è La scatola d’osso, uscito nel 1941. Peské Marty è lo pseudonimo che fu scelto per firmare Qui il sentiero si perde (1955), scritto insieme a suo marito Pierre Marty _(1901-1957), giurista di formazione, appassionato di storia, letteratura e filosofie orientali.