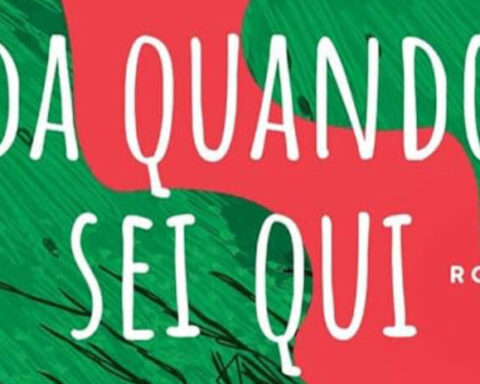Tre giorni di programmazione, mezzo milione di euro al box office italiano, più di cinquantamila presenze in sala da Nord a Sud, una replica extra a grandissima richiesta del pubblico. Sono piccoli flash di ciò che è accaduto tra aprile e la prima settimana di maggio, quando è finalmente sbarcato nelle sale italiane “Perfect Blue”, magistrale thriller del maestro dell’animazione giapponese d’autore Satoshi Kon, un film del 1997 uscito in home video e diventato cult grazie ad un nutrito e appassionato gruppo di cinefili internazionali che ne hanno riconosciuto il valore e hanno tenuto alta l’attenzione.
La trama
Di cosa parla “Perfect Blue”, con quei poster che ricordano i dischi della cantautrice islandese Björk e il tulle pesante degli abiti da idol che ingabbiano la protagonista? È la storia di Mima, una cantante pop, la più amata delle Cham, il terzetto di cui è praticamente la front-woman. Il trio fa musica allegra ed orecchiabile ed è acclamato da uno stuolo di fan, ma come per tutte le star che debuttano da giovani (e le idol giapponesi debuttano giovanissime) le lancette dell’orologio assomigliano sempre di più alla lama di una ghigliottina che inevitabilmente segnerà la fine di una brillante carriera, e l’imminente sostituzione con altre idol più giovani, più sorridenti e più disponibili. Mima, però, è una ragazza volenterosa che vorrebbe mettersi in gioco come attrice e ci riesce: recita in una serie drammatica che ottiene reazioni miste tra i suoi fan, così abituati ad averla incasellata nel ruolo della idol felice e sorridente.
Tutto crolla quando a Mima viene fatta girare una scena di stupro. In quel momento, il nuovo mondo che sta costruendo sembra farsi sempre più distorto: Mima è perseguitata da allucinazioni della sua personalità da idol, e in più ha scoperto l’esistenza di un sito, Mima’s Room, un diario online che racconta con dovizia di particolari le sue giornate. C’è solo un problema: Mima non ha idea di chi sia quel sito, né come quelle informazioni arrivino al misterioso autore.
Il film è un sogno psichedelico sospeso tra immaginazione, paranoia e realtà: quanto di ciò che lo spettatore vede attraverso il filtro della mente appesantita di Mima è reale? Chi si cela dietro la figura misteriosa dello stalker deforme? Perché il mondo non può accettare che Mima voglia semplicemente cambiare lavoro, pur restando nello stesso ambito, una volta scaduto un contratto? Satoshi Kon non pretende di dare una risposta unica alle domande-sfida che lancia allo spettatore, ma propone piuttosto una riflessione su un tema già di fondamentale importanza nel periodo in cui le popstar in stile idol erano sulla cresta dell’onda in Giappone: quanto di una persona famosa appartiene al fan?
Nel vortice delle relazioni parasociali
Nel 1956, i sociologi Donald Horton e Richard Wohl pubblicano il saggio “Mass Communication and Parasocial Interaction. Observations on intimacy at a distance”, un testo che introduce per la prima volta il concetto di “relazione parasociale”, ovvero la relazione illusoria che si forma tra un fan e il cosiddetto “oggetto di fandom”, una persona famosa ammirata che si percepisce come vicina. Naturalmente, lo stile di comunicazione di un artista o di un qualsiasi personaggio famoso porterà a creare la comoda illusione di un’intimità, una sorta di complicità unica per ciascun fan. Ciò può avvenire entro confini sani, nel senso che un fan può sentirsi compreso o confortato dalle opere di un artista, e può trovare un grado di affinità di ideali con il personaggio pubblico che ha senso di esistere nel momento in cui ci si può basare soltanto sulla “maschera” pubblica di un artista o un qualsiasi altro personaggio famoso.
La relazione parasociale si ha nel momento in cui si inizia a concepire l’artista o il personaggio famoso come una persona con cui si ha un rapporto profondo che va molto oltre la connessione con le opere o l’operato del tal personaggio: alcuni fan iniziano ad avvertire un senso di gelosia, arrivando perfino a fare del bullismo ad altri fan, o peggio ancora ai partner di vita di alcune celebrità. Un caso noto è quello di Benedict Cumberbatch, salito alla ribalta come attore protagonista della serie BBC Sherlock, che in un’intervista con Vanity Fair del 2016 ha ammonito alcuni fan che avevano dichiarato fasullo il suo matrimonio con la regista teatrale Sophie Hunter, episodio che si somma ad altro stalking e ad altre illazioni su una sua ipotetica relazione con il co-protagonista Martin Freeman. Esempio più recente il coming out forzato dell’attore Kit Connor, star della serie LGBTQ+ “Heartstopper”, costretto a uscire allo scoperto come bisessuale dopo aver ricevuto accuse di aver irretito fan LGBTQ+ con false promesse sulla sua identità per poi intraprendere una relazione con una donna.
Questi episodi, simili in tutto e per tutto alle lettere minatorie e agli insulti che Mima riceve nel film per aver cambiato carriera, nascono da una matrice che resta unica e invariata anche in culture molto diverse per storia e costumi: l’idea che una persona famosa sia una tela bianca sulla quale proiettare le proprie fantasie e le proprie speranze, e che il risultato di questa proiezione appartenga al fan. Nell’industria musicale giapponese e coreana, non è raro che alcune celebrità debbano scusarsi con i fan nel momento in cui intraprendono una relazione, e tali relazioni restano il più lontano possibile dai riflettori proprio per evitare ripercussioni sgradevoli come quelle rappresentate in “Perfect Blue”.
Per quanto una star possa condurre una vita oggettivamente privilegiata, con una disponibilità economica e un capitale sociale che rendono più semplice la navigazione di episodi di stalking, lo stress è un fattore che non discrimina in base alla classe o alle risorse finanziarie di qualcuno. Soprattutto nel caso di un artista, la discrepanza tra il personaggio percepito dai fan, il personaggio creato dalla persona stessa e la persona senza filtri può portare ad una distorsione che nel film viene rappresentata attraverso degli spettri reali e metaforici, ma che nella realtà ha un aspetto decisamente meno intrigante – ed ecco che compaiono i primi titoloni che parlano di quanto questa o quella star si sia lasciata andare.
Perché oggi il film riempie le sale?
Nell’epoca in cui ogni barriera su internet è collassata in favore della creazione di un marketplace dove persino un bambino è un potenziale cliente, appena dopo l’epoca in cui tutto il mondo è stato costretto a stare un po’ più online di quanto non fosse abituato e a cercare interazioni genuine attraverso lo schermo nero di Black Mirror, approcciare una celebrità è diventato un po’ più semplice.
Questa possibilità così a portata di tap crea l’illusione di una vicinanza rispetto ad una persona famosa, così reale da portare a credere che un commento gentile o una risposta ad un tag siano sintomo di qualcosa di più di una semplice transazione sociale. Una star che sorride e si comporta in modo amichevole durante un “meet and greet” farà sicuramente più piacere di quelle star un po’ scorbutiche che diventano incoerenti con il brand presentato al pubblico, ma resta pur sempre qualcuno che sta facendo il suo lavoro.
I social non fanno eccezione in questo: ogni interazione è parte di un’operazione di costruzione di un’immagine. Quanto la persona famosa ci creda o sia genuina è irrilevante: ciò che viene dato in pasto al pubblico finisce per scatenare una fame di attenzioni nel fan, che può portare ad interazioni pericolose.
In questo panorama inquietante del web, “Perfect Blue” si posiziona non solo come monito, ma anche come specchio per tutte le categorie coinvolte: fino a quando i manager continueranno a cercare di incastrare una persona in una singola definizione in nome del marketing? Fino a quando non si porrà più attenzione alle tecniche di linguaggio utilizzate dalle persone famose per creare un senso di vicinanza con il pubblico? Quand’è che il pubblico, con tutti gli strumenti teorici esistenti oggi a disposizione, inizierà a valutare in maniera critica il personaggio social prima di fare investimenti che potrebbero andare a gonfiare portafogli già straripanti?
La stanza di Mima, oggi, ha dimensioni sterminate. Si può scrollare finché non ci si sarà saziati di contenuti voyeuristici che dissezionano la vita di celebrità finché non resta più nulla di autentico. Ma è pur sempre una stanza finta, e sarà sempre in mano a terzi. E come per la stanza del film, c’è poco di vero – e c’è molta più pianificazione per far credere che i letti sfatti delle star siano sfatti davvero, e non frutto di una concezione estetica ben precisa.
Non si esce dalla sala, o non si guarda nello schermo nero a fine film con la risposta in tasca, per nessuna di queste domande. Ma se il cuore pesante che lascia “Perfect Blue” può voler dire qualcosa, forse bisogna ascoltarlo e staccare la spina.