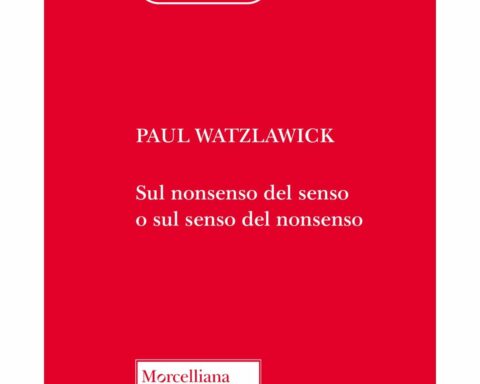Partendo da una affermazione che ha valore di indicazione metodologica, Franco Rotelli riporta un’indicazione di Basaglia come traccia preliminare di ciò che in seguito si è voluto qualificare come “salute mentale”: «Bisogna fare il contrario di ciò che accadeva in manicomio».
In questa condensazione programmatica risuona la sostanza di ciò che in seguito Basaglia qualificò come “processo di de-istituzionalizzazione”. Quella affermazione, netta e perentoria, ha fatto sì che si è potuto considerare il manicomio una “forma feticistica” di un tipo particolare di “lavoro del negativo”, seguendo l’analogia suggerita dalla definizione di perversione secondo Freud: la perversione come negativo della nevrosi. Il manicomio come “forma del negativo”, ovvero luogo dove si è condensata la totale “negativizzazione della condizione umana dei pazienti”, ci offrirebbe lo spunto per delineare la natura e gli scopi di ciò che, non volendo più essere psichiatria bensì “salute mentale”, susciterebbe una riflessione che ne riprenda gli spunti originari attraverso i quali Basaglia pose in stato di autointerrogazione l’intero costrutto psichiatrico. Negativizzazione successivamente rimodulata e rinnovata nella prosopopea teorica dell’odierno assetto della psichiatria coi suoi caratteri di “ateoreticità-statistico-probabilistica” che connota quella sorta di “lettore endocranico” che è il “DSM”, la cui più evidente caratteristica è la sterilizzazione di qualsiasi orientamento teorico, ma non estraneo a quella matrice riduzionista di cui si impregna il paradigma neurobiologico.
Occhio al neo-organicismo
neurobiologico orientato
Di fatto, benché non esplicitato, tale costrutto è riscontrabile nella prassi sotto forma di “neo-organicismo neurobiologicamente orientato”, caratterizzato dal metabolismo di un pattern di neuromediatori sulla cui supposta alterazione agirebbero, terapeuticamente, “psicomolecole” anti-qualcosa. In tal modo si “riattualizza”, in una rinnovata veste di scientificità, il sempiterno “dogma griesingeriano”, secondo il quale si svolge l’odierna liturgia mainstream : «Le malattie mentali sono malattie del cervello». Tale assetto teorico-prassico, colto nella sua evidente natura ideologica, è perfettamente funzionale al più generale contesto culturale odierno che informa tutta la postmodernità sotto l’insegna del “tutto è informazione” (“it from bit”).
In tal senso, la rivoluzione microelettronica e la conseguente espansione della connessione digitale, ha determinato una dimensione globale in cui, appunto, tutto è informazione e connessione. Se allora “tutto è informazione”, e per estensione lo diventa (come di fatto accade), l’uso e il fine di una diagnosi “DSM orientata” con pacchetto psico-farmacologico incluso, cosa diventa la cosiddetta malattia mentale endocranicamente supposta e farmacologicamente trattata? Diventa un “neo binomio neuro-informazionale” quale espressione contemporanea dell’altrettanto mai sopito “parallelismo psico-fisico” con cui si iniziò a configurare l’idolo dei frenologi tardo ottocenteschi: “l’homunculus”, quale rappresentazione e corrispondenza del neurologico come substrato del mentale.
“Di-agnosi” diventa allora un caso particolare di “acquisizione di informazioni neurobiologiche” su un soggetto, mentre ” Terapeia”, sotto forma di trattamento farmacologico applicato alla disfunzione di un pattern di neuromediatori, funziona come “evidenza empirica” (?) di quella “di-agnosi”, surrogando “la cura” che, orientata invece alla salute mentale come “altro dalla psichiatria”, resta tuttora in attesa di una adeguata teoria.
Dalla lesione organica
al paradigma demenzialistico
L’insieme di questi fatti, il cui impasto ideologico non deve sfuggire, sembra delineare una sorta di “eterno ritorno dell’uguale”, che sarebbe più pertinente caratterizzare come un caso particolare di un freudiano “ritorno del rimosso”. Quest’ultimo aspetto suggerirebbe una necessaria riflessione circa la persistenza di questa torsione concettuale che, lungo la sua diacronia storico-culturale, designa una regressione: dalla de-istituzionalizzazione basagliana a un rinnovato “organo dinamismo” con relativi attributi: pattern di neuromediatori correlati a gruppi di neuroni come parafrasi della “localizzazione dei centri nervosi che, in tal modo, richiamano le basi di una “neuropsichiatria” che si reggerebbe sull’idea di una “lesione organica originaria” quale elemento neuropatologico strutturante il “paradigma demenzialistico”. Sarebbe salutare, per una sorta di “igiene mentale ” ricordare che in tal modo fu inaugurato il modus operandi del fare psichiatrico protrattosi fino agli anni ’60/70 del XX secolo, epoca che identificava il paziente quale portatore della malattia e a quella mirare “indipendentemente da lui”. Un prezzo che i positivisti dell’epoca pagarono volentieri per riscattare “la scienza psichiatrica” dalle secche di una originaria povertà epistemologica, confidando nella certezza di avere di li a poco ragione della follia. Una “certezza” che non è mai stata raggiunta, rendendo insostenibile il prezzo di una neuropsichiatria, analogamente a come, alla fine degli anni ’90, la “propaganda scientista” quale avanguardia dell’apparato industriale-farmaceutico capeggiata dalla signora Nancy Andreasen, annunciò un analogo obiettivo nel corso del cosiddetto “decennio del cervello” i cui sviluppi, involuzioni e aporie odierne hanno ugualmente smentito.
Sicché l’odierna involuzione psichiatrica, risoltasi in conformismo da pensiero unico costruito con i materiali di risulta di derivazione “griesingeriana-kraepeliniana”, fa riemergere l’irrisolto impensato della psichiatria, che la dissoluzione della fase basagliana evidenzia nella sua fenomenica criticità.
L’opera innovativa
di Franco Basaglia
Dissoluzione che riapre la faglia tra un “supposto sapere-potere psichiatrico” e l’opera certamente innovativa iniziata con Basaglia i cui limiti, al di là di ogni monumentalizzazione dello stesso, vanno colti e rielaborati, sostenuti da un filone di pensiero che nel tempo si è raccolto intorno alle figure più significative della fenomenologia europea. Nella cosiddetta letteratura “cavalleresca” cinque-seicentesca, era diffuso il ricorso al cosiddetto “colpo di jarnac”, praticato nell’ambito delle dispute tra duellanti: esso consisteva nel portare il proprio attacco di sorpresa sul tendine di Achille che la spada di un contendente sezionava bruscamente riducendo l’avversario all’immobilità. Si potrebbe assimilare e sintetizzare in tal modo la messa in discussione che quell’altro gesto, “il diniego di Basaglia”, determinò sull’assetto complessivo del discorso psichiatrico della seconda metà del XX secolo, in Italia come in gran parte dell’Europa. “Immobilità ” tuttavia apparente col senno di oggi, considerando la pressoché totale inconsapevolezza del cosiddetto movimento per la salute mentale circa le radici profonde da cui emerge l’odierna metamorfosi restauratrice: la psichiatria del XXI secolo ha perfettamente assimilato il portato neurobiologico inquadrandolo in una rinnovata versione neo-positivista del fatto psichiatrico, la cui prassi si regge sulla cosiddetta “via breve farmacologicamente orientata”.
Mainstream psichiatrico
dai rischi incalcolabili
Sicché, rispetto a tali ordini di questioni, risulta particolarmente significativa la posizione di uno dei massimi esponenti del mainstream psichiatrico: Mario Maj, già “past president” della W.P.A, tentando una sorta di anamnesi dello stato dell’arte ha concluso nei termini di uno stato fallimentare del paradigma kraepeliniano, constatandone una sorta di “rigor mortis” dello stesso. Il “pregio” di tale outing, tanto più significativo perché proveniente dalla cittadella accademica, descriverebbe il profilo di una scienza psichiatrica ormai in “fase post-paradigmatica”; in attesa, si potrebbe aggiungere, che dall’altro versante, orientato alle pratiche della salute mentale, giungano notizie e riflessioni che, a partire dalla conclamata faglia, assolvono al compito della sua “risoluzione”, salvo avere preliminarmente bonificati i propri orizzonti di pensiero da fruste apologie e riformismi inconcludenti.
D’altra parte “risolvere” non sembra definire un vantaggio, osservando l’odierno stato di anarchismo metodologico cui si presta il ricorso all’ambigua formuletta del ” bio-psico-sociale” ormai svuotata di alcun senso la cui funzione è puramente ornamentale, buona per qualche insulso sermone domenicale infarcito di moralistiche buone intenzioni. Di fatto, lo spartiacque resta la grande e contraddittoria riforma del ’78: la legge 180, con le grandi controversie che avevano agitato la psichiatria del XIX secolo e il grande dibattito che aveva innescato, è stato il momento più alto di questa disciplina prima del ritorno di un pensiero sommario, velleitario e totalizzante, che ha tratto pretesto dalla scoperta dei chemioterapici per dispensare gli psichiatri dal dovere di pensare e di riflettere. Di fatto riuscendoci.
Necessita ripensare
un vero rinnovamento
Così come è tutto da “ripensare” un rinnovamento che sembra piuttosto relegato nel campo di una gloriosa inutilità alla luce della sua incapacità a generalizzarsi come “pratica e terapia”, lasciando il campo della prevalenza a un’involuta ortodossia che, riadattatasi sugli schemi del descrittivismo neurobiologico, e quindi in tal modo recuperando la salienza della “clinica del visibile” come specifico “biomedico”, indugia in un compiacimento di sé che la cronaca giornalistica (ma non solo) ne mostra il lato drammatico e grottesco cui conduce la scimmiottatura di una prassi che vorrebbe darsi “un ‘habitus biomedico”.
Tutto ciò ha condotto a una grave e colpevole deformazione dei fatti, fino alla “de-psicopatologizzazione” con cui si suppone di ribadire un sapere medico che, nella sua incongruenza, fallisce al cospetto della falla ontologica incarnata dal soggetto psichiatrico per eccellenza: il soggetto psicotico.
Questa “partitura teoretica” evoca la tragica icona dello storpio e del cieco di Brugel: trascinandosi l’un l’altro, presi in una fatalità irridemibile, la “cecità ” di un descrittivismo meramente formale si combina con un’epistemologia “storpia” nelle sue fondamenta, producendo un rachitismo di pensiero assimilabile alla deambulazione di qualcuno affetto da una frattura multipla ed esposta agli arti inferiori.
È attraverso questa meccanica, da cui si estrinseca l’odierno approccio al fatto psichiatrico, che Nemesi riguadagna la scena: un incongruo “recoverismo d’importazione” che presuppone un sociale idealizzato e salvifico, punteggiato da oasi ambulatoriali più simili a baraccopoli che ad effettive strutture sanitarie, delineano la cartografia di un paesaggio terapeutico desertificato nei presupposti stessi di una salute mentale che si propone come “il dopo psichiatria”, per avere troppo supposto l’esautorazione e la definitiva destituzione dai suoi fondamenti quel “paradigma biomedico” che Kraepelin aveva immaginato e costituito sulla base di un irriducibile prospettiva organicista.
Il concorso a tale condizione ha trovato solide basi nelle odierne tecniche di “brain imaging” determinando il definitivo collasso del pensare e riflettere, ormai decaduto a mero “proceduralismo burocratico-istituzionale”.
Sotto le maschere
dello specialismo
Una sorta di “cognitivismo rurale” si è ormai diffuso ovunque sotto le maschere degli specialismi più spregiudicati simili ad avanguardie esotiche che vanno a profilare una sorta di “terra di Babele” dove prevalgono idiomi, dialetti e slang fino alla cacofonia.
In tale contesto, la locuzione “salute mentale” suona perlopiù come un “amuleto linguistico” di cui si fanno pifferai i titolari di “competenze” che hanno completamente smarrito non solo la differenza tra “essenza e fenomeno”, ma fanno gli esecutori della loro ignoranza simile a quella virtù di cui già La Rochefaucaud diceva essere il prezzo della loro ipocrisia.