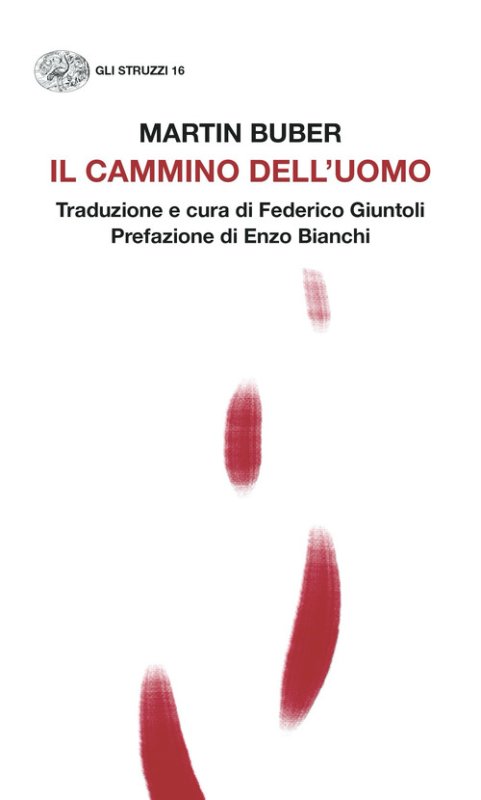Dopo molti anni di stenti, che peraltro non avevano scosso la sua fede in Dio, in sogno gli era stato ordinato di andare a cercare un tesoro a Praga, sotto il ponte che conduce al castello del re. Quando il sogno si ripresentò per la terza volta, rabbi Eisik, figlio di rabbi Yekel di Cracovia, si mise in cammino verso Praga. Il ponte, però, era sorvegliato giorno e notte dalle guardie, e lui non si arrischiava a mettersi a scavare. Tuttavia, andava fino al ponte ogni mattina e gli gironzolava intorno fino a sera. Alla fine, il capitano delle guardie, domandò se stesse cercando qualcosa o aspettando qualcuno. Rabbi Eisik, allora, raccontò del sogno. Il capitano si mise a ridere: “Sì, stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino, quando in sogno mi fu detto di andare fino a Cracovia e poi scavare in casa di un ebreo, il cui nome era Eisik, figlio di Yekel, per cercare un tesoro sotto la stufa!” E rise di nuovo. Rabbi Eisik salutò con un inchino, tornò a casa, disseppellì il tesoro e costruì la casa di preghiera che porta il nome di Rev Eisik, figlio di Rev Yekel.
Martin Buber, Il cammino dell’uomo, Einaudi, pagg. 64. Un piccolo libro di parabole e saggezza. Un libro che aveva attirato l’attenzione di Herman Hesse, il quale scriveva a Martin Buber: “Tra i suoi scritti, Il cammino dell’uomo resta probabilmente quanto di più bello io abbia letto. La ringrazio di vero cuore per questo dono così prezioso e inesauribile. Lascerò che mi parli ancora e molto spesso”. E così Enzo Bianchi, nella prefazione, a ripetere che questo libretto di Buber è uno scrigno di sapienza, da leggere e rileggere, da portare con sé lungo il cammino, nel viaggio della vita.
Martin Buber (Vienna 1878 – Gerusalemme 1965) è stato uno dei maggiori studiosi del Hasidismo, inteso come mezzo di rigenerazione del giudaismo attraverso un processo di avvicinamento sincero dell’essere umano a Dio. Il movimento, nato in Polonia nella metà del XVIII secolo, fu fondato da Yisrael ben Eli‘ezer (1700-1760). Il movimento si rivolse soprattutto alle persone semplici, di poca cultura, spesso soverchiate dalle difficoltà delle loro esistenze. Avvicinarsi a Dio, quindi, non è il persistere nello studio della Torah, né una condotta di vita improntata alla rinuncia o all’ascetismo, ma l’esistere autentico di un’esistenza viva, presente e interessata a sé come al mondo circostante. Una forma di vita reale, veritiera, sincera che si attua nelle forme del sé e del mondo. Che cosa chiede, allora, il rabbi Mendel di Kotzk: di non sbirciare fuori di sé, non sbirciare dentro gli altri, e non pensare a se stessi. Coscienza di sé e conseguente abbandono. Non il sé come finalità, ma come accesso, incontro con l’altro, e con il divino. La presenza del sacro, in breve, è sentita come dimensione terrena del qui e dell’ora. Varie religioni, scrive Buber, negano alla nostra permanenza sulla terra il carattere di vita autentica. Esse insegnano o che tutto ciò che qui ci si presenta è soltanto un’apparenza di là dalla quale siamo chiamati ad andare, oppure che è soltanto un’anticamera del mondo autentico, un’anticamera che siamo chiamati ad attraversare, senza prestarvi troppa attenzione. Due mondi separati e disgiunti che devono essere uno. Un’unità che si realizza, appunto, attraverso il contatto con Dio, ovvero una vita sensatamente condotta in relazione con il mondo in cui si è collocati e in cui ci si trova.
Una volta, ci dice Buber, al rabbi Pinhas di Korets’ fu raccontata la grande miseria in cui vivevano i bisognosi. Affranto dal dolore, egli ascoltava. Poi alzò la testa ed esclamò: “Spostiamo Dio nel mondo e tutto troverà appagamento”. Non una risposta arrogante, ascoltiamo, ma il mistero della nostra esistenza, la sovrumana opportunità del genere umano. La via del Hasidismo. Dove abita Dio? chiedeva il rabbi Mendel ad alcuni religiosi, suoi ospiti. Gli risero in faccia e gli dissero che il mondo è pieno della Sua gloria. Fu lui, però a rispondere che Dio abita dove lo si lascia entrare. È sorprendente qui l’affinità con il pensiero di Heidegger, quando il filosofo tedesco parla della filosofia come domanda sul chi è l’uomo. E lui risponde che l’uomo è chi si lascia attraversare dalla stessa domanda, chi persegue nell’interrogazione dell’essere del Dasein (esserci), e sperimenta la vita autentica in opposizione al mondo anonimo, all’indifferenza, e all’impersonale del “si dice”, cui sembra alludere anche Buber quando scrive che non bisogna per niente vivere per un mondo ultraterreno, ma che l’unica cosa che conta è la vita nel suo rapporto con il proprio essere autentico. Sembra a questo punto che il Divino sia da ricercare nello stadio più elevato di se stessi ma nello stesso tempo, quando si crede che questa condizione sia raggiunta, bisogna subito abbandonarla per non cadere nell’atto della superbia. La storiella che è qui raccontata di un hasid sopraffatto dalla sete è in tal caso efficace. L’uomo fa digiuno da un sabato al successivo. Il pomeriggio del venerdì è sopraffatto da una sete tremenda che crede di morire. Si accinge a bere ma resiste per non fallire la prova. Ma quando sente dentro l’orgoglio di avercela fatta, decide di bere. Fallimento o superbia si chiede Buber. E ancora: non è pretendere troppo dall’essere umano? Storielle quelle di Buber e dei suoi rabbini che ci fanno continuamente riflettere e interrogare. Tuttavia, la domanda fondamentale è quella che apre il libro e che Dio rivolge ad Adamo: “Dove sei?”. Per dire dove si sia cacciato l’uomo. Dove si sia nascosto. A questo punto, tutto dipende dal fatto che si voglia o no affrontare la domanda. Unica condizione che ci pone sul retto cammino da intraprendere. Un libro di poche pagine, semplice ma seducente. Un libro che invita alla meditazione. E, forse, ci lascia più vicini al divino. Che non sia proprio ciò a renderci più umani?
Martin Buber, Il cammino dell’uomo, Einaudi, pagg. 64