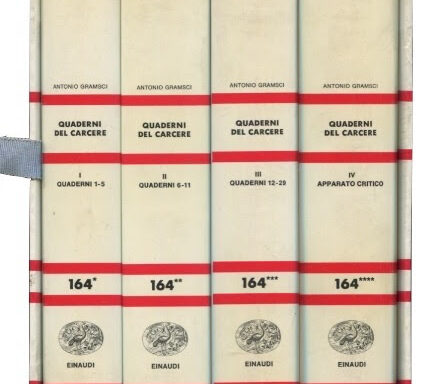Giuseppe Acocella, “garante del lettore” del nostro magazine, inizia con questo scritto la sua collaborazione con RQ (www.resistenzequotidiane.it). Acocella, filosofo del diritto, professore emerito dell’Università Federico II di Napoli e rettore magnifico dell’Università Giustino Fortunato, inaugura un percorso dedicato alla legalità che, specie in questo primo intervento che pubblichiamo in tre puntate, si rivolge particolarmente ai giovani. L’insigne studioso fa leva sulla letteratura classica, il teatro e le loro icone (il primo capitolo evoca e riattualizza Antigone), per allargare l’ambito della riflessione intorno al tema della legalità, confermando l’assunto che è utilissimo sostenere l’indagine scientifica con il grande patrimonio che proviene dalla nostra cultura classica.
Fu Flavio Lopez de Oñate a fissare con passione invincibile – in un libro sulla certezza del diritto, del 1942, mentre infuriava la guerra ed era ancora incombente il tragico delirio rappresentato dal nazismo – il problema spinoso della legalità, riprendendo il tema eterno della contrapposizione tra obbedienza alla norma positiva e legge morale allorché questa, sovrapponendosi nel giudizio del singolo, dissolve la garanzia che proprio la legge deve rappresentare, liquidando così, insieme con la esperienza giuridica e con la certezza, lo stesso principio ed il fondamento della vita sociale. Negli ultimi tempi – a proposito della imputazione del sindaco di Riace, o della rottura (da parte di un cardinale di Santa Romana Chiesa) dei sigilli che impedivano l’erogazione della corrente elettrica ad occupanti che non pagavano le bollette – si è giunti ad invocare la disobbedienza alla legge comune in nome dell’appello alla legge etica individuale non scritta, con un inatteso ritorno del pur vituperato (perché fino a poco tempo fa giudicato da molti arbitrario, moralistico e ancestrale) diritto naturale. Si è giunti infine su questa strada, negli aspri confronti di fazione spesso maturati nel dibattito politico – e sulla base della dichiarazione che i cittadini sono assaliti sempre più spesso dal dubbio sulla legittimità della legge – ad invocare appunto la disobbedienza alle norme, evocando lo spirito di Antigone (che rifiuta la legge di Creonte posta a tutela della polis, in nome di non meglio precisate “alte ed inconcusse leggi” che gli dei esprimono e che talvolta superano le leggi umane).
Rischia però così di essere vanificata la cultura stessa della legalità, e con essa la educazione alla legalità divenuta impegno talvolta assorbente di insegnanti, magistrati, rappresentanti della pubbliche istituzioni, con gran dispendio di tempo talvolta sottratto allo studio individuale dei giovani, fino al punto che si possa temere un ritorno di teorie miranti a giustificare senza accorgersene ogni devianza (anche quella mafiosa?) quando si rivaluti l’arbitrio sociale o di clan nei confronti dello Stato di diritto e del suo ordinamento giuridico,
Per chi coltiva l’obiettivo di indagare e diffondere una cultura del rispetto della legalità (cui si può resistere solo quando l’intero ordinamento sia esso stesso frutto della tirannia, come ricorda la formula Radbruch), uno spettro si aggira nei nostri tempi: che proprio alle generazioni più giovani sia precluso quel cammino di formazione che consente di distinguere legge ingiusta, obbedienza alle leggi democraticamente statuite, lineare rapporto tra diritto e morale. Su questi temi è cresciuta negli ultimi anni anche nell’Università – attraverso insegnamenti di Diritto e letteratura – l’esigenza di trovare innovative modalità di indagine, di discussione e di insegnamento sui temi sensibili della natura delle leggi e dello scopo del diritto, spesso col ricorso alla letteratura classica e alle sue icone. In questa sede di approfondimento di tutti i temi che riguardano la legalità è parso pertanto opportuno inserirsi in questo ambito di riflessione con un racconto scopertamente didascalico su quanto la letteratura – ed in specie quella forma di alta comunicazione che è la rappresentazione teatrale – propone con una sintesi ed una evidenza che spesso l’indagine scientifica non può, per sua collocazione, perseguire. Teatro e diritto vuole solo sondare un ulteriore terreno per argomentare intorno al delicato e complesso tema della legalità.
Capitolo I. Antigone
Tornò allo studio scontento. Quella giornata in Tribunale gli aveva messo addosso un senso fastidioso di insoddisfazione, lo aveva scosso nelle sue convinzioni, maturate fin dagli anni dell’Università, che alle controversie giudiziarie dovesse sempre applicarsi una ragione del diritto inoppugnabile, anche quando fosse incertamente dibattuta e frutto di confronto aspro. La certezza del diritto era l’àncora cui restare vincolati nel mare dell’incertezza contemporanea.
Gli atteggiamenti moralistici esibiti dal giudice con cui aveva avuto a che fare quel giorno, addirittura sprezzante verso l’argomentazione saldamente ancorata alla dottrina e alla stessa giurisprudenza, lo aveva irritato e demoralizzato. Quale fiducia – lui avvocato impegnato a mantenere sempre vigile la coscienza sui casi che accettava – poteva ancora nutrire in una amministrazione della giustizia imprevedibile perché assoggettata ad umori e opinioni sedicenti “morali” coltivate da un magistrato che si sentiva al di sopra delle leggi?
Salendo le scale, quasi a cercare un motivo di conforto, Flavio si ripromise di parlarne quella sera stessa, a cena, con Antigone, la ragazza greca che aveva incontrato qualche settimana prima in un incontro tra avvocati, la quale sembrava incline a condividere proprio gli atteggiamenti che gli incutevano i timori che quel giorno lo avevano lasciato insoddisfatto e nervoso. Tanto più che, considerò, nonostante la divergenza sulla funzione del diritto e la differenza di vedute, avrebbe voluto che lei fosse la sua ragazza, perché non aveva mai incontrato, fino ad ora, una ragazza così sensibile e delicata, dai sentimenti nobili e puri. Giunse finalmente davanti alla porta dello studio, dove faceva bella mostra di sé la targa bronzea con cornice lignea su cui spiccava la scritta «Studio legale Lopez-Porzia», ed entrò. A quell’ora non c’era nessuno. La segretaria a casa, il suo amico Avv. Porzia a Venezia per un caso assai intrigante, che il suo collega aveva voluto per sé come occasione ideale per provare che il diritto civile subiva sempre più decisamente l’influenza dei sistemi di common law. Il loro sodalizio durava sin dai tempi dell’Università e della frequenza delle lezioni della Facoltà di Giurisprudenza, ma questa era un’altra storia.
Mentre metteva a posto le carte che si trascinava dietro fin dal mattino, non riuscì a reprimere un moto di fastidio per i modi sbrigativi, per non dire altro, con i quali il giudice aveva creduto di liquidare le ragioni da lui esposte – con dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali – a difesa del suo cliente, attore in quella controversia per aver denunciato l’occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà, contro la pretesa della società elettrica di pretendere da lui, questa volta convenuto, il pagamento della corrente elettrica trafugata dall’occupante con un allaccio illegale e pericoloso. Il magistrato in questa prima udienza aveva chiaramente mostrato la sua insofferenza verso la richiesta di restituzione dell’immobile e la imposizione del pagamento delle spese
all’occupante, motivando che – prima di ogni acquisizione delle ragioni formali esibite – avrebbe prima dovuto valutare e tenere in considerazione l’aspetto sociale e morale che aveva indotto chi era privo di mezzi propri di sussistenza a compiere gli atti illegali, e se questo non costituisse un ostacolo a procedere, giungendo forse anche a dichiarare insussistenti le ragioni delle richieste avanzate dall’attore.
L’esibizione dei meriti
per il consenso pubblico
Quel giudice, Cust, era sul punto di subentrare in qualità di Presidente del Tribunale al Giudice Vanan, incappato in una singolare vicenda di sospetti alimentati da una dichiarazione resa in punto di morte dal suo rivale, Croz, autoincolpatosi del rapporto di corruzione intercorso con Ludvi-Pol. L’intreccio perverso che aveva legato Croz e Cust, riversatosi su Vanan, era solo un tassello dell’infinita trama che tesseva da sempre la corrente cui apparteneva e che muoveva la fila degli incarichi e delle designazioni ai più alti uffici, influenzando anche gli orientamenti – politici o anche soltanto tesi a rafforzare il potere delle consorterie giudiziarie – i quali, spianando la strada delle singole aspirazioni verso la conquista dell’agognato potere, finivano per perpetuare l’estrema liturgia di autoassoluzione della casta. Flavio conosceva questa purulenta realtà e sapeva che Cust voleva, con quei suoi atteggiamenti, vanitosamente progressisti e moralistici, soltanto fornire occasioni ai suoi sostenitori di esibire meriti utili ad acquisire consensi nella pubblica opinione, in grado di stendere un velo sulle effettive manovre che avrebbero portato Cust a sostituire Vanan.
Il tragico consistere – nella corporazione che si divideva e ipocritamente si rinsaldava nella nuova e comune convenienza plasticamente rappresentata nell’organo di autogoverno della categoria giudiziaria – di avversione e connivenza erano drammaticamente rappresentati nella torbida vicenda nata per la spasmodica ricerca dell’interesse personale e di clan dei personaggi del Palazzo. Si era trattato di una vicenda in cui Cust era riuscito a divincolarsi con abilità sospetta, e un giorno un magistrato, rivelatosi efficace drammaturgo, aveva avuto il coraggio di descrivere questo inganno, non esitando a dimettersi e cambiare mestiere.
Poi non volle più pensarci. Aveva quasi voglia di dormire, benché fosse solo pomeriggio e la luce filtrava dalle persiane del balcone dello studio, calate fin quasi a terra. Gli venne in mente che una ricerca australiana sosteneva che senza buio assoluto non fosse possibile un buon sonno. Meditò di ricordarsene da quella notte in poi. Aveva bisogno che il suo sonno fosse continuo e ristoratore. E subito si riscosse, pensò che doveva prepararsi per andare a cena con Antigone, Avrebbe parlato con lei, approfondito la sua conoscenza, augurandosi che il loro legame si rafforzasse fino a divenire stabile, non più una occasionale relazione, ma una occasione per la vita. Ma non era facile penetrare nelle barriere che Antigone aveva eretto a difesa della sua anima, certo tormentata.
Flavio sapeva quanto avesse inciso sulla ragazza la scomparsa inattesa e crudele del fratello, Polinice. Aveva saputo da lei, attraverso brevi confidenze, appena accennate, che il fratello, dopo una vita ai margini, da irregolare, nonostante la frequenza di studi regolari, e dopo aver sperimentato quanto dannosi fossero gli abusi di alcool e droga, sembrava aver trovato la sua vocazione di inquieto bohémienne in una ONG che sulle coste greche era impegnata ad accogliere migranti in fuga dal Nord-Africa e dalla Turchia. Si era spinto anche a partecipare a spedizioni navali che andavano a raccogliere i fuggitivi sulle co ste libiche, al di là delle acque internazionali, e a condurli in porti accessibili, dove per qualche anno la cosa era stata tollerata, benché da tempo – nelle condizioni difficili in cui si era trovata l’economia greca – l’opera delle ONG era sembrata non più tollerabile, fino a sembrare una aperta, inaccettabile pressione sulle leggi che regolavano l’ingresso nel paese.
Certezza del diritto sì
ma con norme legittime
Polinice era rimasto del tutto indifferente alle proibizioni e alle limitazioni delle leggi, e aveva continuato nelle sue azioni di salvataggio, anche dopo le diffide pervenutegli dalle autorità portuali prima, dagli ammonimenti e dalle procedure di infrazione avviate dalla polizia e istruite dalla procura ateniese poi. Antigone aveva cercato di dissuadere il fratello dal reiterare comportamenti illegittimi, in ragione anche della sua professione legale, consigliandogli di attenersi al rispetto delle leggi, per quanto condividesse le posizioni fraterne e ritenesse un dovere morale – cui le norme avrebbero dovuto uniformarsi – quello di preporre all’obbedienza delle disposizioni i richiami della coscienza. Antigone aveva confidato a Flavio che il buio periodo della dittatura dei colonnelli aveva lasciato in lei una convinzione profonda e radicata nella superiorità delle leggi etiche su quelle positive, per quanto fosse consapevole di quanto incerti e mutevoli potessero essere principi così invocati, con il rischio di favorire un arbitrio individuale senza remore, dettato dalla convenienza di seguire le proprie personali convinzioni invece che la regola comune. Peraltro aveva anche ben chiaro un criterio che Flavio spesso le ricordava, cioè che la certezza del diritto (e delle leggi) fosse sacrosanta quando le norme fossero legittimamente prodotte in un regime democratico, e quanto invece fossero difficilmente praticabili di fronte a norme perverse – come aveva mostrato il processo di Norimberga – se assecondassero l’autoritarismo del regime totalitario che le aveva prodotte.
Flavio finì di prepararsi nel bagno dello studio, attrezzato con camice pulite e ricambi pronti, si accarezzò il pizzetto che gli dava, insieme ai baffi ben curati, un nobile aspetto risorgimentale, e chiuse la porta dello studio. Discese la scalinata e, uscito in strada, cercò di ricordare dove avesse parcheggiato la sua auto, una vecchia berlina blu notte ben tenuta, la mattina, quando era giunto allo studio. Trovatala nel posteggio nel quale non sempre era fortunato a trovar posto, si avviò al ristorante da lei preferito, “L’Olimpo”, dove avrebbe atteso la non puntualissima Antigone. Giuntovi, andò al tavolo che gli era stato riservato, ed attese. Poiché l’attesa si prolungava, chiese un calice di prosecco che l’avrebbe aiutato a sentirsi meno osservato dagli altri commensali. Finalmente Antigone giunse, in un abito color pervinca con le spalline, che faceva risaltare la sua figura snella, e subito un cameriere si precipitò
a versare nel calice già pronto lo scintillante liquido dal cui fondo si sprigionavano infinite bollicine che giungevano in superfice e scoppiettavano silenziose. Lei bevve il fresco prosecco, e prima che Flavio potesse proferir parola,disse: «Mi trovo a mio agio nella dimora degli dei, perché so di poter colloquiare con loro». A Flavio si troncò in gola il saluto che gli stava venendo alle labbra prima di quella rivelazione sulla confidenza che Antigone vantava con i Celesti.
Dopo un succulento sauté di vongole e cozze servito come antipasto, e dopo aver bagnato le labbra con un fresco e aromatico Gewurtztraminer, che Flavio preferiva sopra ogni altro vino, Antigone ritenne fosse giunto il momento per confidarsi sulla storia che, ricordò, l’aveva spinta a lasciare la Grecia e a venire in Italia. Raccontò a Flavio che Polinice aveva spinto sempre più, fino a sfida
re le autorità, la sua opera benefica, ritenendo un delitto contro l’umanità non far di tutto – anche al di là e al disopra delle leggi – per soccorrere una umanità disperata e sfruttata. Dal momento che coloro che venivano soccorsi erano privi di alloggio, di vitto, di servizi, forzò insieme ad altri i portoni di un edificio adibito a foresteria per gli equipaggi delle navi da trasporto bisognosi di un ricovero per qualche pernottamento, riattivò le linee elettriche agganciandole, con cavi improvvisati, a quelle della vicina azienda di trasformazione del pesce, tolse i sigilli ai contatori per l’erogazione dell’acqua, fornì di generi alimentari che aveva sottratti, con quello che si chiamava allora esproprio proletario, ad un supermercato situato appena fuori del porto, riuscì persino a fornire di telefonini dotati di schede “usa e getta”, prelevati da casse stivate in un deposito in attesa di consegna, tutti coloro, o almeno gran parte, che ne necessitavano.
Al pubblico Ministero Creonte, che gli contestava di aver violato le leggi sulla proprietà privata, Antigone accoratamente mi spiegava che Polinice aveva opposto che ammetteva di aver infranto certo le leggi, ma con un nobile scopo che lo assolveva. Se le obiettavo che a questo punto chiunque – per una ragione che egli solo considerasse lodevole o soltanto conveniente, facendo del suo giudizio il criterio incontestabile di liceità – avrebbe potuto arrogarsi il diritto di violare le leggi e farsi beffe della legalità, Antigone mi obiettava a sua
volta che vi sono ragioni e ragioni, motivazioni e motivazioni, ma che soltanto a quelle nobili ed alte era consentito di giustificare le violazioni. Ed io allora le chiedevo: ma se io rivendico come alta e nobile anche una abietta motivazione soggettiva (ma che a me appare nobilissima e degna di lode) chi potrà negare o contestare la mia ragione, se a nessun criterio oggettivo potrebbe mai essere attribuita alcuna autorità? Sapendola non credente aggiungevo che ella non avrebbe potuto neppure appellarsi, come gli spiriti religiosi possono invece fare, ad una autorità spirituale superiore, come quel cardinale che aveva riallacciato i contatori della energia elettrica agli occupanti abusivi di un condominio in nome di un Dio e di una etica espressamente definita da valori riconoscibili, pubblici e certi, da difendere a costo di ogni sacrificio. Ed aggiungevo che perfino in questo caso quella religione riconosceva la necessità di «dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». A questo punto – certa che i suoi Dei dovessero assisterla anche senza conoscerne i criteri – Antigone taceva.
Le ambizioni di un giudice
e il diritto piegato al potere
Quanto erano distanti le miserie del giudice Cust, pensò però Flavio, nel momento in cui Antigone si era temporaneamente allontanata per suoi problemi, dalle nobili ragioni che rivendicava Antigone in nome del fratello, giacché il giudice Cust, perso nella sua ambizione sconfinata che gli faceva piegare le ragioni del diritto alla sua strategia di potere, agiva per motivi abietti e nel disprezzo della sua stessa professione. Eppure per Flavio ambedue le posizioni esprimevano, se non ostilità aperta, almeno incomprensione della rilevanza per lo Stato di diritto di tener la barra dritta sul principio di legalità, preferendo sostituire ad esso un singolaristico e perfino egocentrico appello ad una interpretazione giusnaturalistica, per Antigone in virtù delle alte leggi della morale, per Cust in ragione della sostituzione di valori supposti universali alla certezza della norma storicamente elaborata da organi legittimamente investiti dell’autorità di rappresentare la volontà generale.
Quando Antigone aveva chiesto di assentarsi dal tavolo per pochi momenti, Flavio considerò quanto quella svelta figura che si stava allontanando dal tavolo cominciasse ad essere importante nel suo cuore. In quel momento ricordò con sgomento quando, per uno scherzo del caso, il suo nome, Antigone, era stato invocato dal vecchio Presidente Vanan in un drammatico momento, allorché era
esploso il suo dramma, accentuato dalla tragica, volontaria fine della figlia Elena – sconvolta dalla rivelazione, artatamente trasmessale da Cust, sul marcio del l’intero sistema giudiziario di cui suo padre era forse complice, emblematica testimone della tragedia dei semplici di fronte alla rivelazione della corruzione che investe chi dovrebbe combatterla – mentre il giudice Croz, nell’ultimo impeto di complicità e di cinismo, l’aveva appellata «Pietosa Antigone, soave Cordelia, vostro padre si trova tra amici e non ha più bisogno di voi».
Se spunta la minaccia
del moralismo progressista
In una intercettazione che aveva travolto tutti gli equilibri e svelato quanto profonda fosse la corruzione a Palazzo di giustizia, si era potuto ascoltare che a Croz il ben più cinico e spietato Cust aveva chiarito il vero significato del potere esercitato da chi amministra la giustizia senza più legami con la sincera applicazione del diritto in nome della comunità: «Essi fanno giustizia! (…). Cioè essi esprimono il parere che certe azioni siano giuste e altre no. Come una salsiccia è appesa a un’altra salsiccia, così questo parere è appeso a dei codici … ben rilegati … e questi codici, via via, ad altri codici e leggi e tavole … sempre più antiche (…) l’inconveniente è che manca il gancio principale, l’uncino originale … mancando il quale … ecco tutta la fila di salsicce per terra! ma dove, ma come, ma quando! Chi è stato a stabilire che una cosa è giusta e l’altra no? Noi sappiamo benissimo che le cose … sono quel che sono, tutte eguali. Ecco perché noi giudici siamo tutti degli ipocriti, tutti pieni di salsicce irrancidite! Ecco quale è la vera corruzione di questo palazzo, ci puzza tremendamente». Eppure Cust era ancora lì, ad esercitare il suo falso progressismo moralista contro di lui e contro coloro che cercavano una lineare applicazione del diritto, mentre nell’intercettazione che tutti i giornali avevano riportato era evidente il suo disprezzo per la corretta interpretazione dei codici e delle norme, assoggettate ad una pulsione di onnipotenza che sembrava aver del tutto compromesso ogni equilibrio tra poteri dello Stato.
Quasi non si era accorto che Antigone era tornata al tavolo, e non nascose forse la sua sorpresa di vedersela lì, radiosa e sorridente ma con un velo cupo negli occhi. Quando si fu seduta, gli fu evidente che Antigone aveva pianto nel bagno, nonostante gli sforzi per ricomporsi, e allora osò, le prese la mano fra le sue. Sorridendo ancora, Antigone gli svelò il resto della storia. Polinice era stato incarcerato, e, nonostante le suppliche, le pressioni che le associazioni, cui Polinice era legato, avevano promosso, nonostante le preghiere che aveva rivolto al giudice Creonte lei stessa, quando aveva avuto con lui un teso colloquio, Creonte restò inamovibile in nome della legge eguale per tutti. Le disse: «in Grecia abbiamo finalmente riconquistato la democrazia dopo la parentesi buia dei colonnelli, e la legge è il nostro scudo e la nostra garanzia. Finché le istituzioni democraticamente elette non l’avranno cambiata, la legge va rispettata, altrimenti saremmo di nuovo nell’arbitrio che si fa beffe dell’illegalità». A quel punto Antigone pianse, e non finì il branzino in umido che aveva appena toccato. Flavio tacque, ma poi, presagli la mano, la pregò di riferirgli, a dispetto dell’emozione, del colloquio così come essa poteva ricordarlo a distanza di tempo.
Antigone taceva, e teneva sempre la testa bassa. Tra le lacrime gli rivelò che in quel periodo era promessa sposa del figlio di Creonte, Emone, e per questo aveva creduto di trovare maggiore comprensione nel suo futuro suocero, supplicandolo di trovare un modo, anche un sotterfugio, per sottrarre il fratello ad una più che probabile condanna. Creonte restò inflessibile, anzi mettendola sull’avviso che, proprio per il legame con suo figlio Emone, ella avrebbe dovuto astenersi da chiassate e manifestazioni, semmai insieme ad altri, a favore del fratello. Tra l’altro, le disse con severità, questi comportamenti incoraggiano anche una parte politica a stravolgere il significato dell’azione di solidarietà ed il senso stesso della applicazione della legge, originando una faziosità politica intollerabile per l’autonomia dell’azione giudiziaria. Fu a quel punto che Antigone gli rispose (e la frase era diventata un proclama da esibire in piazza, come confessò a Flavio, con un po’ di imbarazzo) che «Non Giove a me lanciò simile bando, né la Giustizia, che dimora insieme coi Démoni d’Averno, onde altre leggi furono imposte agli uomini; e i tuoi bandi io non credei che tanta forza avessero da far sì che le leggi dei Celesti, non scritte, ed incrollabili, potesse soverchiare un mortal: ché non adesso furono sancite, o ieri: eterne vivono esse».
La rinuncia alla laicità
di una convinta democratica
Flavio restò di sasso: l’invocazione alle leggi dei Celesti lo sorprese come un fulmine seguito da tuono in un cielo limpido e senza nuvole, in nome di leggi eterne che sovrastano quelle mortali. Mai avrebbe immaginato una simile rinuncia alla laicità in una convinta democratica come Antigone, che pur, si può comprendere, sentiva di avere, nel contrasto con Creonte, scelto senza paura di adottare la resistenza morale più inflessibile all’arbitrio del potere e alla crudezza giuspositivistica in nome del diritto naturale. Ad accrescere la sua convinzione di essere eroicamente nel giusto era giunta la risposta del giudice Creonte, fermo nel ritenere la regola priva di eccezioni: «Costei dié prova della sua protervia quando le leggi imposte violò: dopo la colpa, una seconda volta proterva ora si mostra, che dell’opera insuperbisce e ride», annunciandole «E chi, sorpreso nel delirio, vuole con bei detti esaltarlo, io l’aborrisco». Creonte aveva fermamente invocato una legge certa contro l’arbitrio individuale di Antigone, che pretendeva – contro la legge emanata per tutti – una vigenza della morale che sapesse distinguere e tutelare uno spazio extra-giuridico al quale la coscienza singola si può rivolgere. Flavio tentò di dirle che lo Stato di diritto, con le sue norme, non può rinunciare a regolare la convivenza interna alle comunità e le relazioni tra nazioni (altrimenti regolate dal solo diritto della forza), e lo deve fare con determinazione inflessibile, perché altrimenti si darebbe dovuto supporre vigente, ma senza verifiche, il diritto umanitario universale che ciascuno può tratteggiare a proprio uso. Antigone non voleva sentir ragioni, e dichiarava di voler seguire solo un sentimento del cuore che le sembrava anche un sentimento del diritto. Per Antigone doveva essere proclamato finalmente vigente quel diritto umanitario universale su cui Flavio ironizzava, obiettivo ed utopia che aveva attraversato l’intera storia umana.
Flavio aveva cercato di consolarla, svelandole che anche lui, fautore della certezza del diritto, non disconosceva questo impulso perché, le disse, «la legge positiva, espressione del comando e della forza, finisce certo per scontare la limitatezza intrinseca della norma codificata, ed è alla fine incapace – in questo, Antigone, hai ragione – di raccogliere tutte le diverse istanze morali che stanno sotto alla richiesta di diritto e di giustizia, cosicché, come nel tuo caso, alla fine si scontra con la richiesta di vigenza di una fonte individualizzata, e pretesa efficace, in nome di una non meglio precisata morale “universale”».
L’insidia della volontà tirannica
per la tutela della legalità
Ma, ripeteva a questo punto Flavio, occorreva ben tener presente che altro significa la disobbedienza alle leggi emanate da un potere illegittimo e dispotico, altro è l’inosservanza delle leggi emanate da un potere legittimo democraticamente eletto ed espressione della sovranità popolare. Come era accaduto anche nei giorni oscuri dei totalitarismi novecenteschi, la aspirazione ad una giustizia resa certa da leggi applicabili senza arbitrii interpretativi costituisce sempre tutela della legalità di fronte alla strumentalizzazione, a fini di potere o di parte, delle norme positive, quando siano frutto di volontà tirannica, fino a ritenerle le uniche corrispondenti alla verità della natura (il Volksgeist?), come avevano testimoniato le resistenze al regime giuridico nazista dei giuristi tedeschi fedeli alla Costituzione e alla scienza del diritto, rifletté Flavio.
A questo punto Antigone aveva reagito, dicendogli che egli non comprendeva che al di sopra del diritto scritto nelle leggi c’era un superiore diritto a cui ogni diritto parziale o territoriale dove inchinarsi. Senza più sperare di convincerla, Flavio obiettò stancamente: «Vuoi dire forse dire, Antigone, un nuovo ius gentium che fa scomparire la solida e faticosa storia di affermazione dello ius civile che ha fondato la nostra civiltà giuridica? Ma il diritto delle genti – se non intende restare sul terreno dell’arbitrio – deve assumere comunque le forme del diritto positivo».
(1 / continua)