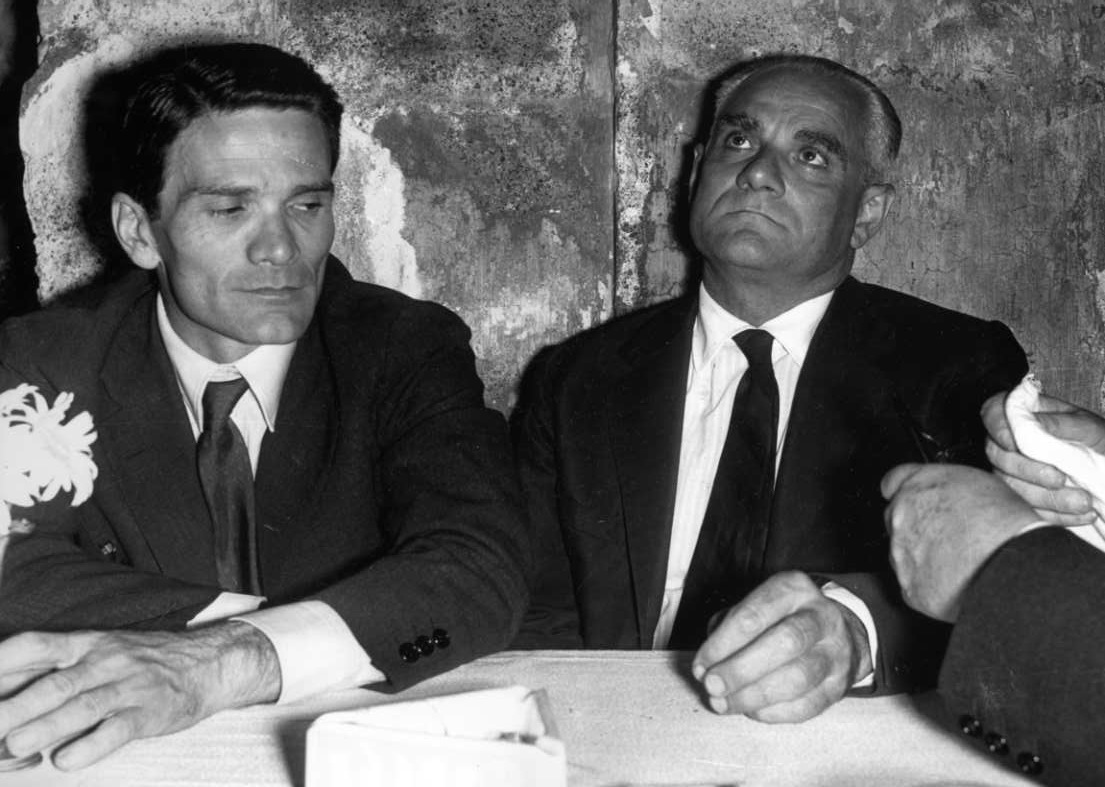L’allestimento scenico pensato e realizzato da Emilio Isgrò per la rappresentazione della sua Odissea cancellata– con la regia di Giorgio Sangati, durante le tre serate della settima edizione della rassegna “Pompei Theatrum Mundi” (13-15 giugno, nel cartellone del progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale) – è il primo indizio rivelatore di una cifra artistica ormai riconoscibilissima (sia per ciò che concerne le questioni di forma o per le gemellari ipotesi di contenuto) nel panorama dell’arte contemporanea italiana e internazionale. Nel cuore del parco archeologico pompeiano, cinque pannelli in legno inciso accolgono il pubblico: l’istallazione modulare ricrea passi dall’ Odissea omerica cancellata dall’artista mentre, tra le cancellature, si scorge la sagoma di una nave. Sono, dunque, questi cinque moduli ad offrire il primo testo – oppure un pretestuoso ‘pre-testo’ – non a caso sistemato in posizione baricentrica e in asse con gli accessi al portico, in sequenza corrispondente al colonnato antecedente il ‘locus’ scenico, il Teatro Grande. Qui giungono, alla fine di un percorso obbligato – in fila come formiche o in gruppi a sciame come api, per restare sempre nella ‘materia’ iconografica di Isgrò – gli spettatori trovandosi, di fronte, non il palco ma le gradinate che si sostituiscono al tradizionale spazio teatrale destinato alla rappresentazione. Anche il semicerchio della cavea si presenta al pubblico come un ulteriore nuovo ‘testo’: i gradoni diventano linee in successione sulle quali i versi in greco, durante il tempo dello spettacolo, si cancellano; definitivamente sostituiti, nell’epilogo della originalissima ‘versione di Isgrò – che, vale la pena ricordare, è pure poeta, romanziere e traduttore – dalla figura (già comparsa all’ingresso) della prua e della poppa di una barca. Costruita da Isgrò questa cornice, si completa la messa in scena dello ‘spazio-testo’ performativo che continua a svilupparsi – per oppositum – attraverso una narrazione marcatamente verbo-visiva. “In questo quadro complessivo”, scrive Martina Treu, “si comprende come l’Odissea cancellata sia un tassello importante nella produzione di Isgrò a far da raccordo tra due filoni solo in apparenza distinti in realtà contigui e complementari: da un lato quella della Cancellatura (inaugurato nel 1964), dall’altro quello teatrale che fruisce ininterrotto da decenni. Qui parola e immagine si uniscono inscindibilmente: proprio per questo adesso, a oltre venti anni dalla sua stesura, il poema in versi trova finalmente la sua piena realizzazione scenica. E rivela il suo valore senza tempo, capace di guardare al passato e insieme al futuro: sintesi di quel che precede e precursore di sviluppi successivi”. Pure la narrazione in versi dell’originale omerico sembra lentamente scomparire – nella prosa poetica dell’Odissea cancellata – di nuovo (o ancora) per il tramite necessario della cancellatura grafico-linguistica. Un processo che, però, non deve essere inteso nella misura riduttiva della ‘riscrittura’ o del pur rispettabilissimo esercizio artistico della ‘imitazione’. Ciò che, invece, Emilio Isgrò offre al suo pubblico di lettori-spettatori è un esempio – altrettanto classico e altrettanto rispettabile – di ‘ricreazione’ del modello originale; perfettamente in linea con quanto già realizzato dall’artista in altre sue opere precedenti: si pensi, in tal senso, alla drammaturgia dell’Orestea di Gibellina o di Didone Adonàis Domine; alla prosa romanzesca del Polifemo; e al rigoroso labor limae delle raccolte poetiche, soprattutto nella reiterata pratica della misura tradizionale del sonetto. Così giunta, infine, nella nostra contemporaneità la parola antica – visivamente cancellata e poeticamente riscritta e rappresentata attraverso il necessario medium della interpretazione di Isgrò – rivela felicemente e ancora una volta la sua eccezionale polisemia. Attraverso la cancellatura di Isgrò negli spazi del sito archeologico pompeiano ciò che è scritto e recitato guadagna adesso “una risonanza speciale” riuscendo, per Roberto Andò, a sovrapporsi e a contrapporsi con un “gesto liberatorio al gesto terribile e luttuoso che duemila anni fa ha travolto Pompei”. E, al contempo, il segno grafico diventa “parola umana”, capace di dar voce a un teatro che Gabriel Zuchtriegel riconosce come “lirico e politico che processa il passato per scoprirne i sedimenti nel presente e annunciarne le ipotesi di futuro. Una ‘drammaturgia’ soprattutto che, come auspicava il suo autore, ‘cancellasse il silenzio’”.