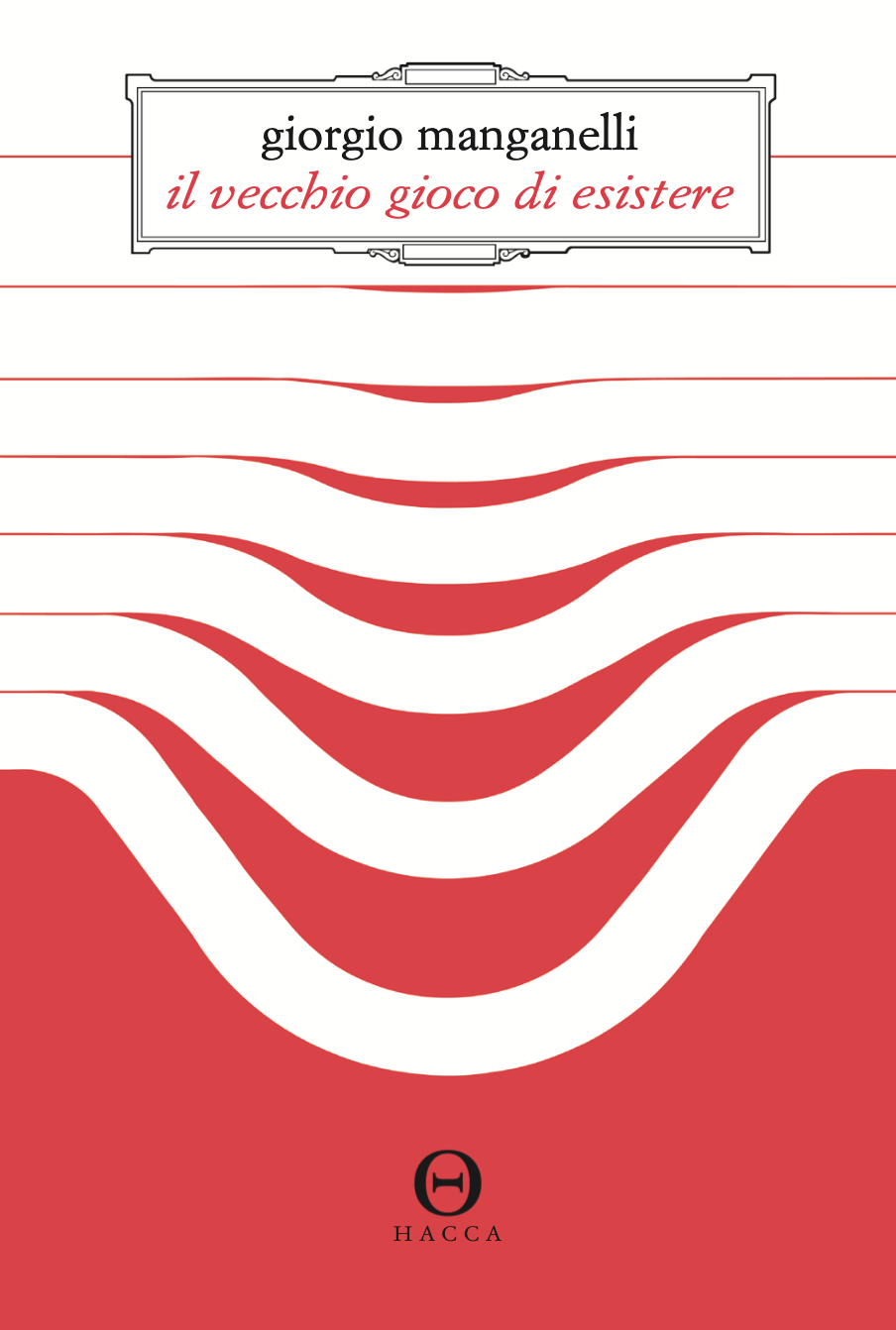Una menzogna presa alla lettera è inerte e intollerante come una qualsiasi verità; una menzogna può mentire su se stessa; può, una volatile scintilla di una pirotecnia, aprirsi in infiniti illusori disegni; inoltre, a differenza della “verità” che si esenta da ogni responsabilità e si finge statica, e che è sempre e solo contemporanea, la menzogna deve affrontare i secoli, l’eterno; dunque deve chiudere in sé tutte le vesti e tutte le parlate future; sa che verrà continuamente interrogata, e catturata, e denunciata, e che ogni volta dovrà fuggire. Per questo sarà così attenta a essere “fraintesa”, a non tradire la propria natura di parola, di verbo.
Giorgio Manganelli, Il vecchio gioco di esistere, Hacca, pagg. 60. Un piccolo libercolo, con un’introduzione della figlia Lietta, da non perdere. Poche pagine, che nell’assoluta tradizione degli “Obituaries”, – un genere giornalistico che impone asciuttezza, intelligenza, deferenza, rispetto, ma anche coscienza – ci regala un sempre eccellente Manganelli, scrittore in tutte le occasioni. E per tutte, consistente, compatto, eccentrico e incessantemente innovativo. E, a distanza di anni, suo malgrado, anche educativo. O ancor più, misteriosamente improbabile. Infine menzognero per amore della verità. Non a caso, si tratta del più autorevole e prolifico scrittore del secondo Novecento. Manganelli, in questi veloci ritratti “in morte di”, scrive Stefano Salis, e come non dargli ragione, non cessa di essere se stesso. Non se ne compiace: dà, a ciascuno dei suoi protagonisti, quel che spetta. Eccellenze e miserie, debolezze e vertigini. Da Borges a Eliade (“camminatore di labirinti”), da Melotti a Novelli: una rassegna di umani e umanità, all’insegna della verità della letteratura. E delle parole: da deliberare, in silenziosa ammirazione. Ne ha per i suoi amici, si pensi ad Augusto Frassineti, autore degli “indimenticabili” Misteri dei Ministeri e insuperato traduttore di Gargantua e Pantagruel di Rabelais. Manganelli lo descrive come uno scrittore sobrio e quieto, calligrafo ostinato e compulsatore accorto di vocabolari, incline a scrittori che hanno del canagliesco, o propenso ai parolai fantasmagorici, ai fabbricatori d’insulti e ai virtuosi del turpiloquio. E insomma lo annovera tra i classici. – Alcune settimane fa, l’8 agosto, moriva a Roma Giuliana Benzoni. Scrivo queste parole con dolore e letizia; allo stesso modo, quando mi dissero: “Giuliana è morta”, non provai in primo luogo dolore, ma una sorta di pace, di accettazione, e dissi a me stesso: “Una vita che ha avuto un significato, una buona, giusta vita”. – Di Giuliana Benzoni, antifascista e amica di Salvemini e Giorgio Amendola, Manganelli scrive che ha sfiorato la storia con dolce distrazione. Non era né modesta né altezzosa ma semplicemente distratta. Questo delizioso libretto, però, ci svela anche qualcosa di particolare, e di indissolubilmente legato, di un’amicizia e di un paziente, in altre parole del rapporto di Manganelli con il suo psicanalista junghiano Ernst Bernhard, del quale, Lietta ancora non si capacita di come abbia fatto a rendergli sopportabile la vita in un momento in cui Manganelli era ai minimi termini e inseguito da angosce e incubi e una gran voglia di farla finita. Costui, o Signori, scrive Manganelli, io ho intenzione di lodarlo a questo modo: per immagini… io dico questo, che egli è somigliantissimo a quei Sileni che si vedono nelle botteghe degli scultori, che gli artisti atteggiano con zampogne e flauti, e se tu l’apri, dentro vede i simulacri degli dèi. E poi dico che egli assomiglia al satiro Marsia. Bernhard scrive che il sintomo nevrotico ha ragione, la malattia non vuole essere guarita ma decifrata. Il “guaritore” è, dunque, dalla parte dell’ombra l’operoso alleato della malattia. Da un labirinto si esce solo per trapassare in un altro labirinto. Bernhard, scrive Manganelli, fu un alleato della naturale immoralità e illegalità del mondo, di ciò che egli chiamava “il buon Dio”; un raro discendente di quei Grandi Mentitori che smentiscono definitivamente il povero mondo della veridicità. Capiamo, in breve, che Bernhard era l’uomo che aveva insegnato a Manganelli a mentire, benché, pare, come racconta la figlia Lietta, non ce ne fosse bisogno. La letteratura come menzogna e artificio è stata il cardine del pensiero di Manganelli. La sua ossessione trasformata in metodo, regola, mestiere di una grande arte che è l’alterazione della parola: l’eterno e l’enorme lavoro della letteratura. Il libro ha un’appendice: Morte di un capodoglio. Si tratta di un resoconto, di una cronaca di un capodoglio spiaggiato. In pratica, l’ultimo necrologio è dedicato a un animale nella veste di un “vascello di argentea carne” o di mostro. Una figura sacra e abissale che da un mare avvelenato approda a una terra altrettanto mefitica. Una resa, una sfida?
Metafora o analogia che sia, il capodoglio ha ormai abdicato. “Visto accanto agli uomini, con le loro vesti allegre di vita, il nudo capodoglio è un animale antico, immutabile da millenni”. La morte continua, scrive un perentorio Manganelli. Noi diciamo che essa è Eterna e immobile. Ovvero che non esiste. Forse la morte è sovrastata dalla follia degli uomini, ma di tutto ciò è ancora più eminente, più sovrana la letteratura. E Manganelli ce ne dà sempre un esempio.
(Giorgio Manganelli, Il vecchio gioco di esistere, Hacca, pagg. 60)