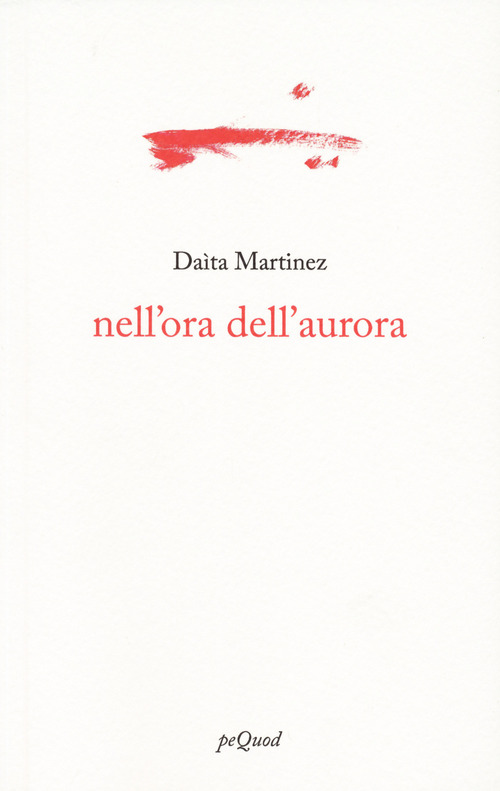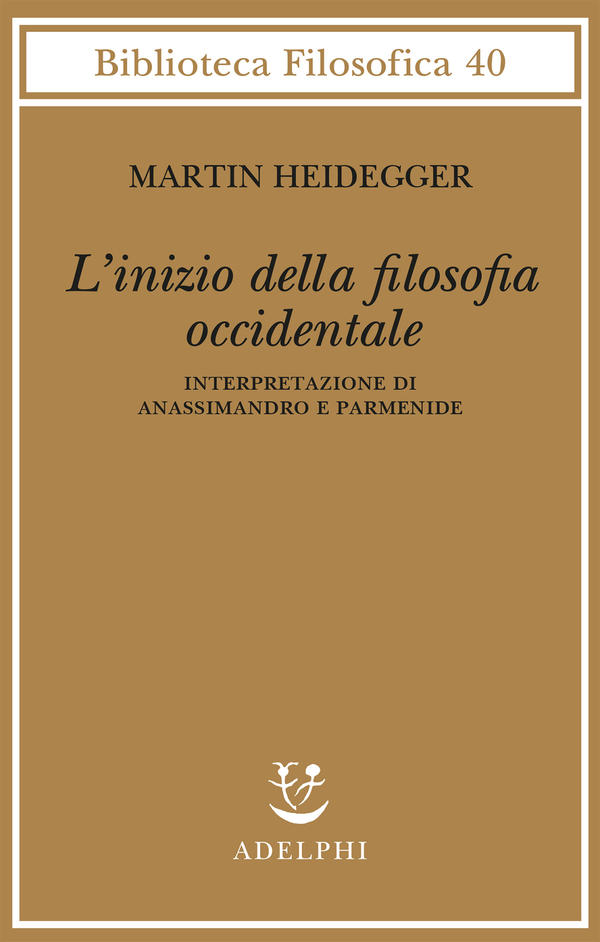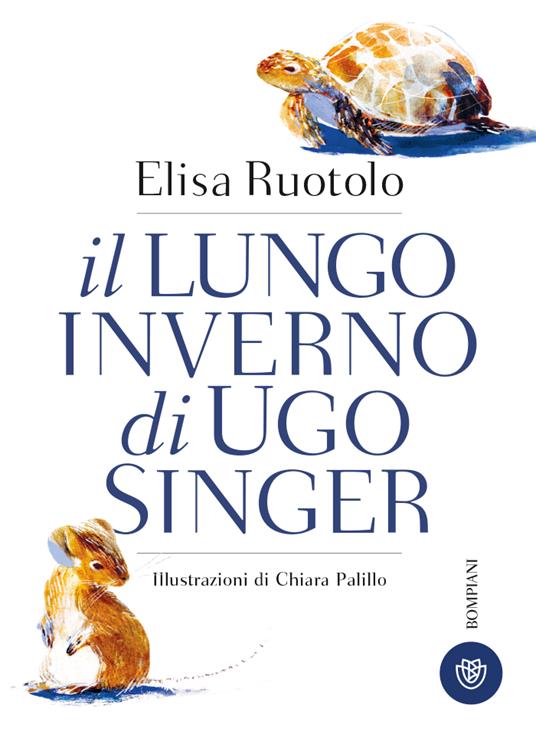né certezza che sia fame e sete poi fame e di nuovo sete nel segno del padre che regge il taglio sugli occhi decantati nel tempo battuto di un quasi dove la struttura del corpo perdonato e non voluto l’assoluto rimanerti e rimanermi fondale fondante la scheggia di carne bianchissima ricorrenza ai santi sul volto di quel volto che è tuo senza l’assenza e nondimeno la casa calma nella stanza una mimica timida irrisolta esattamente tolta al senno delle mani ché per ipotesi sono ad un angolo nascosto di luce e luce il soffio del nome… (Daìta Martinez, nell’ora dell’aurora, peQuod, pag. 57).
La Sicilia è terra fertile di tante meraviglie, non solo agrumi e uva dalla varietà incandescente come la lava del suo vulcano, o la sua flora che si fonde a epoche geologiche e mitiche di un Mediterraneo terra di giardini e di filosofi, ma anche di aedi e rapsodi, nella versione di poetesse magnifiche per equilibrio e sapienza, sperimentazione e ricerca tra le più avanzate in Italia. Penso a Franca Alaimo, a Maria Grazia Insinga e a Daìta Martinez, dove sopra leggiamo un passo tratto dalla sua ultima opera: esercizio in forma di versi e di prosa, condizione essenziale di un vincolo, di un legame con la scrittura che è diventato una forma di esistenza e d’interrogazione del mondo. Mondo è ciò che crediamo ci appartenga e che nell’attimo della presa ci sfugge. Mondo è l’Arché, è la terra e il cielo inseparabile, è il sole nella sua stupefacente oscurità. Mondo è nella sua essenza una fonte di mancanza cui con forza e abnegazione, dedizione, sacrificio si cerca di dare forma. Quella forma che si sa già informe e che pur tuttavia si aspira a modellare, a immaginare. Volto. Qui, in questa recente e intensa raccolta della poetessa palermitana, volto è figura di padre, che appare nel suo stesso dissolversi e separarsi, svanire, perché Padre è origine, fondo e fondamento della sua stessa sparizione e visione. Volto e visione, proiezione e memoria, ebrezza e seduzione interagiscono e s’intrigano a vicenda in una lingua, la scrittura della Martinez, che si fa processo della creazione poetica in una sorta di estasi che è la possibilità di unirsi a quel Kath’hautó, quell’essenza impossibile ma pur avvicinabile che sembra essere il punto “ultimo” ma non l’éschaton, o la stessa esperienza mistica, si pensi a Ildegarda di Bingen e alla sua visione dell’ombra come luce vivente. O quando la stessa scrive che la creazione guarda al suo Creatore come l’amato guarda all’amante. Nel caso della Martinez, allora, si affaccia l’istante di una congiunzione che è l’intensità e la bellezza delle sue pagine con la memoria del padre che si dà fluente e vitale come luce aurorale. Emerge un tempo, l’istante, caduco quanto eterno, di una con-presenza possibile di ciò che appare come sparito ma che in realtà è presente proprio a causa della sua sparizione, e di ciò che è, giacché è, nella sua immagine più perfetta e possente dell’aurora. Immagine che protrae, rimanda, dilaziona nel libro, il Volto (il Padre) e l’immagine del Volto (l’Arché) che a sua volta si dà come possibilità di luce, in altre parole, come chiarore (l’aurora) che si rinnova, si conferma in quel tempo che non è più l’istante Kairós ma l’Aion, la forza vitale, la durata, l’eternità. O il libro. Libro del Volto o del soffio caldo e vitale. Padre è anche alito, respiro, vento caldo, ciatu di sciroccu, profumo di essenze semplici quanto sofferte, bramate, desiderate. “cade lieve l’alba di maggio/e ha odore di pane il vento/che piano sale dai sogni e/tu padre che sogni sorridi/per un bacio sussurrato di/nascosto da una figlia che/crede farti cielo nella casa”.
L’abitare è dunque una casa. Una casa doppia (un libro?), dove chi vive, apre la porta del vuoto per farne un prodigio involontario: un suono, una radice, un ramo divino, una preghiera, la calma di due nudi amanti al centro della chiesa. Un amore verso il padre, quello cantato dalla Martinez in uno spazio che non ha precedenti, immensità familiare e ἄτοπος, non luogo o punto difforme, insolito, pudico. O insondabile nella sensibilità di una poesia che si offre anche come elegia radiosa ed esultante. “la donna senza testacuoretesta/infiora e s’infiora lui la infiora/mani dalle mani dentro il petto/sottotetto del vento ha silenzio/nudo la cicala il valzer la gioia”.
Quella di Daìta Martinez è altresì una scrittura musicale, ma di un suono oserei dire tattile. Un non suono che si percepisce per sfregamento e abbandono. Un doppio movimento, uno esterno e l’altro interno, ma una sola nota che rinuncia al rumore quasi spasmodico di essere previsti e difesi. Colpisce la sua intensità quasi da smemorata e, sebbene come rileva Elio Grasso, prefatore del libro, la sua sia una libertà espressiva complicata, emerge un presentarsi di una scrittura fertile come una terra antica circondata da mari azzurri. Una scrittura isolata da isola feconda e da corpi perdonati e pronti per l’umano cammino di un’arte, quella poetica, che riserva sempre sorprese e ritrovamenti. Chi non ricorda l’odore di suo padre? Chi non ha mai desiderato quel di più di una carezza, di un bacio, di un abbraccio paterno? Ecco, allora, che l’aurora si ratifica nell’ora di una luce primigenia (il riferimento alla Bachmann non è casuale), un’intesa serrata quanto intima e impalpabile di una figlia con il padre. La luce, il silenzio di un amore, dunque, si fa poesia, che nella grazia della Martinez diventa una premura del mattino, un firmamento universale di leggiadria e tenerezza, di attenzione e di cura. Di canto, soprattutto. E di chi arriva incolume all’inoperosa contemplazione del tempo.
[Daìta Martinez, nell’ora dell’aurora, peQuod, pag. 57]