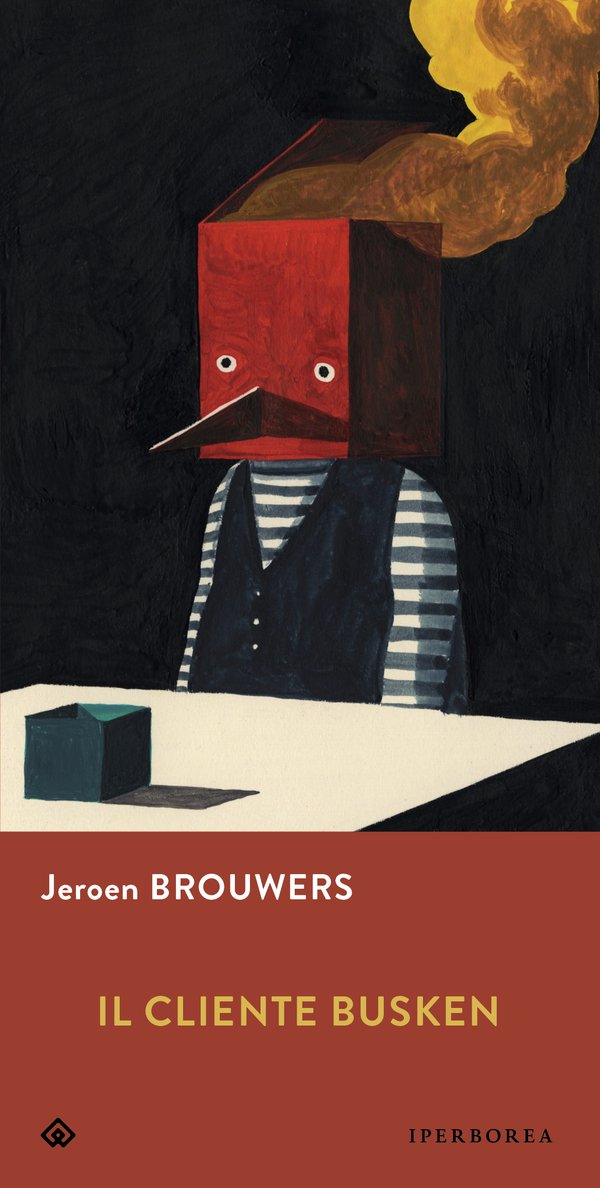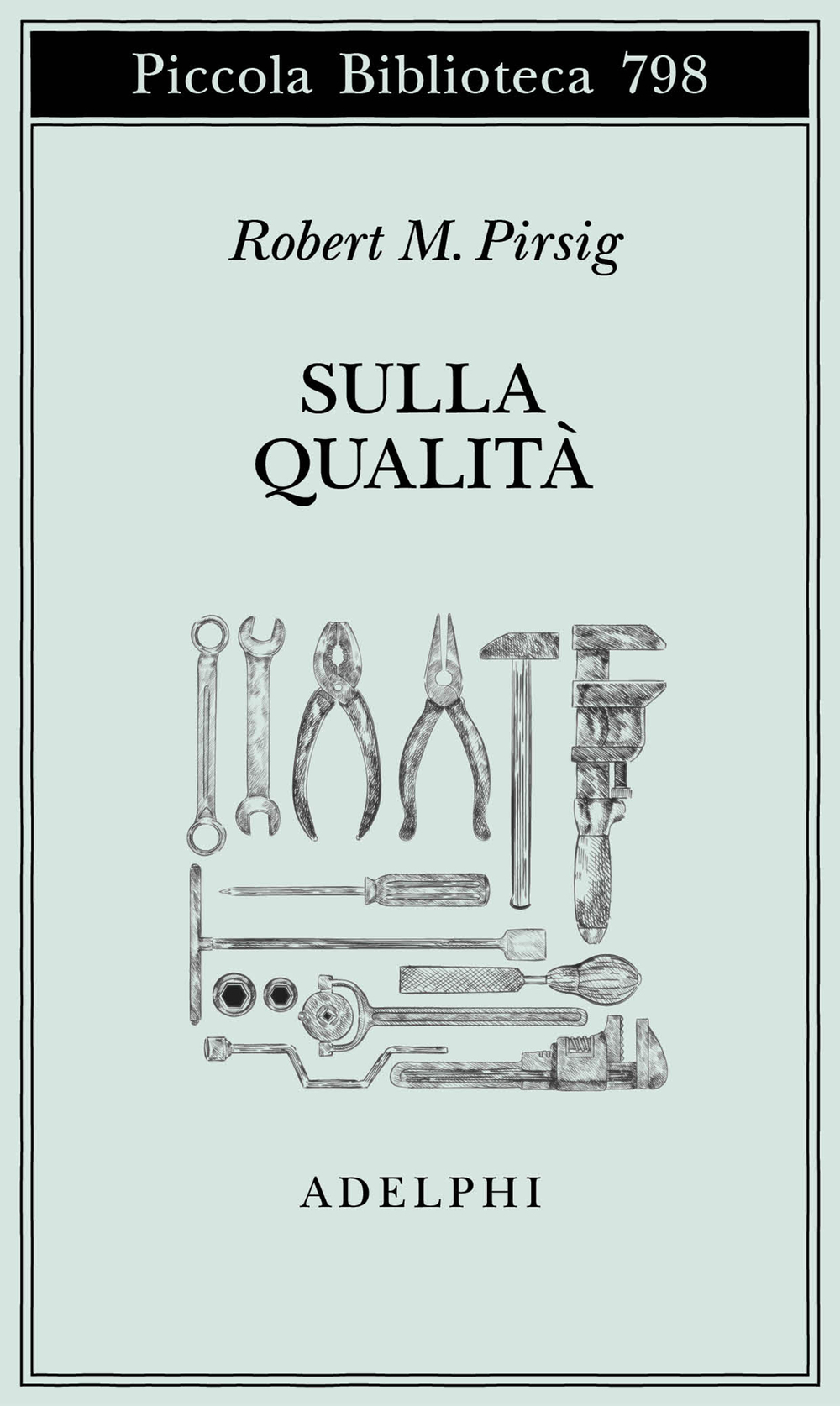è una vacanza lunghissima
qui, non so più da quando cammino/scalzo sull’arenile come adesso. Nessuno o quasi/nei paraggi, orizzonte senza nuvole. Ho perso memoria di come sia avvenuto: i miei/sforzi di ricostruire un passato si appiat/tiscono su una serie di giornate uguali a/questa. Deve esserci stato un trauma, un/incidente, che ha cancellato un passato di/verso, un’origine, un’infanzia, una vita inte/ra… mi guardo i piedi e non capisco da chi/siano mossi. Marco Balducci, Terzo repertorio, Anterem Pag. 67.
Il libro è diviso in sei parti, ognuna con un titolo: Quadrature, Condensazioni, Verticale, Piano inclinato, Da capo, Emergenze. Ogni sezione o capitolo contiene da cinque a sette testi. Sono poesie ma li ho introdotti come testi. Sarebbe stato ugualmente valido all’inverso. Prosa, o poesia, ormai non fa più differenza, vista la larghezza di una consuetudine a operare in quell’alterità del linguaggio che non ha limiti se non nella scrittura stessa. Siamo costantemente, quando si parla di linguaggio, sempre in attesa di un agguato o, per dirla con Blanchot, sempre di fronte a un disastro. E il disastro è qui! Qui, in questa lingua di Balducci dall’apparente calma e semplicità, ma che rivela quell’inquietudine tremenda e irreparabile del presente, quel tempo dall’apparenza naturale, ma così imprendibile e straniante. – Un disastro è anche un sentimento di neutralità, un impulso d’indifferenza apparente o di stupore senza meraviglia. – Il qui e ora della scrittura di Balducci, allora, non ha niente dell’ebbrezza o della potenza che, in ogni caso, sono sostanziali a una lingua, o a qualsiasi linguaggio che ha come mira un ordine superiore, tuttavia riesce a essere una lingua con una sua forza devastante e paralizzante. Poetica? La lingua di Balducci sembra senza angoscia, senza dramma o sventura. Nessuna caduta, insomma. Nessuna caricata flânerie. L’unica possibilità sembrerebbe, com’è suggerito nella quarta di copertina a cura di Silvia Comoglio, essere una distaccata lucida constatazione. Niente di niente. “Un pugno di mosche senza mosche”.
Il disastro, allora, – o potremmo dire la Poesia? – è proprio questa ebbrezza che scaturisce dalla sua stessa assenza. Nella poesia di Balducci si assiste a una sottrazione continua e a uno sdoppiamento che sembra essere, appunto, quel potere del linguaggio, di essere consapevolmente impotente. E, pertanto, più potente di qualsiasi altro linguaggio che fa della sua potenza (autorevolezza, ascendenza, prestigio) la base di un’ontologia spuria o trascendente. Se si è nella condizione, ormai verificata, di esseri effimeri, temporanei, fragili, o, addirittura, perennemente in fuga, chi potrebbe arrogarsi il diritto di un linguaggio definitivo? Dove il linguaggio fosse perfettamente compiuto, perfettamente delimitato, scrive Agamben, lì comincerebbe l’altro riso, l’altro pianto dell’umanità. Si assiste, allora, in Terzo repertorio, a un trascendere lieve che è lo scarto non tanto dell’inatteso o atteso che sia, – sembra che l’esistenza non lascia più margini di sorpresa, tanto che le cose possono farsi e smontarsi con la stessa disinvoltura imposta dal tempo – quanto dell’accaduto con ciò che realmente accade. Questo stato è l’orizzonte cui Balducci si muove, e come giustamente rileva Igor de Marchi nella postfazione al libro, si tratta di una scissione di ordine culturale. Di naturale sembra non esserci proprio nulla. Ciò che nella realtà accade è sempre immaginativamente ciò che avviene. Lo scollamento, non può che essere, dunque, né arginato né accentuato, ma soltanto disegnato. O, nella stessa maniera, cancellato. Né giorno né sera:/bevo un bicchiere d’acqua, traccio una riga/sul tavolo con un dito bagnato, dove sono/finiti i contorni delle cose? Mi siedo, forse è/meglio addormentarsi, confondersi, lasciarsi/assorbire. Non c’è nulla di fatalistico nell’atteggiamento di Balducci, solo un prendere atto di un presupposto di scollamento che lascia ampi margini a una possibilità di scrittura originale e incredibilmente stupefacente, quasi che ogni testo si prestasse a dei quadretti, dove un ordine figurativo si lascia soggiogare non da una disciplina contemplativa, ma da un’attesa che è anche il suo opposto. O da una dilatazione che è anche una riduzione, e perché no, da un effetto (nei fatti, indescrivibile) che affatto non separa né unisce. Non è il disastro totale? Come se il disastro potesse essere in qualche modo parziale, si avverte nella poesia di Balducci la consapevolezza di un’ontologia della messa in scena, sebbene non si capisca che cosa sia a essere narrato, declamato, rievocato. La domanda, allora, chi non ha mai tentato di vedersi rappresentato con i suoi stessi occhi, ha una sola risposta. Ed è un’altra domanda, anzi una serie di altre questioni. Chi guarda chi, nella poesia di Balducci? Che cosa si guarda? A che cosa si assiste? E che cosa accade, in realtà? Che sia la vita ad accadere, può sembrare deviante e vago, eppure la sensazione di qualcosa di tremendamente simile a essa succede, senza dubbio nella forma di un linguaggio che solo Balducci sa comporre e ricomporre in una maniera così accurata ed elegante. Che cosa sia il disastro (la poesia), alla fine di questa lettura, in breve, non si sa più. La sensazione è di aver attraversato a nuoto un fiume e di esserne usciti asciutti (illesi e feriti). Forse, quando il disastro ci tocca, ne siamo, fatalmente, anche parte.
Marco Balducci, Terzo repertorio, Anterem Pag. 67
Marco Balducci è nato a Pisa nel 1964 e vive a Bologna. Ha pubblicato sulle riviste di ricerca poetica Anterem (1992) e Passaggi (2003). Nel 2000 ha partecipato a una puntata della trasmissione L’Ombelico del Mondo per RAI 3, curata da Nanni Balestrini e Lello Voce con alcuni testi di poesia “Neo-tecnologica”, poi esposti in forma visuale in spazi commerciali a Parma e Bologna. È stato finalista al Premio InediTO di Torino 2021 e al Premio Lorenzo Montano 2022 con la silloge Terzo Repertorio, che esce nel 2023 per Anterem Edizioni.