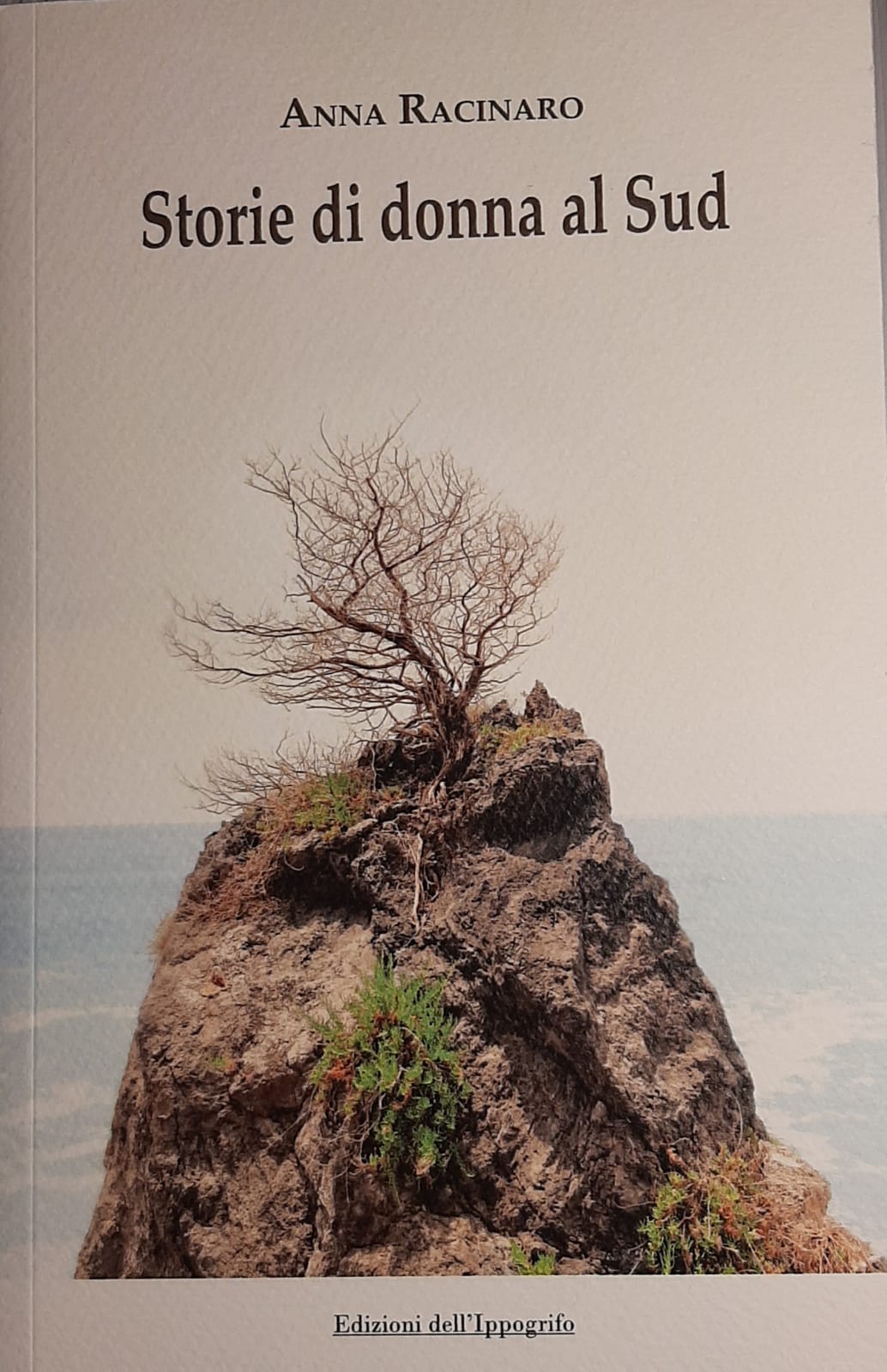Istruiti nell’amore/per diecimila libri/volti per il tramandarsi/di gesti immobili/e giuramenti stolti//ma solo qui/iniziati all’amore/quando la lava discese/e il suo alito ci colse/ai piedi del monte,/quando infine il cratere sfinito/più non trattenne la chiave/per questi corpi serrati//Entrammo in spazi incantati/e illuminammo il buio/con la punta delle dita.
(Ingeborg Bachmann, Invocazione all’Orsa Maggiore, Adelphi, pag. 362).
A corredo di questa edizione vi sono una nota di Hans Höller e un lungo e approfondito commento di Luigi Reitani che contribuisce magnificamente a una lettura più agevole di un’opera cardine della letteratura tedesca e non solo.
Nell’agosto del 1956, in vista della pubblicazione di quest’impresa poetica, destinata a diventare celebre, la giovane autrice austriaca così scriveva al redattore che si stava occupando del volume: “Sarei grata se nel risvolto non si desse la possibilità ai critici di “inchiodarmi” a un’interpretazione anticipata o simili”. Difatti, le ansie non erano per niente infondate. A distanza di un bel po’ di anni, e di commenti, o di tentativi di tradurne una sensibilità, dei valori, o dei significati, o ciò che si voglia, la poesia della Bachmann – che dire straordinaria è di una riduzione imbarazzante – resta del tutto irriducibile a qualsiasi critica che ne tentasse i confini o una definizione che ne bloccasse la ricchezza di aperture, di passaggi, di crepe.
Ingeborg Bachmann (1926 Klagenfurt am Wörthersee, Austria – 1973 Roma) è una potenza poetica che impone estremità ed esige acquiescenza. Remissività. Subordinazione. Obbedienza. Una musicalità frastornante e straziante che si espande e dirompe, dilaga, inonda mente e corpo. L’uso intenso di metafore devastanti, di una liricità emotiva, segreta, accennata, rievocata, celebrata che non ha eguali in nessun’altra poesia. Un lirismo mai statico, sempre in movimento, dove la storia è sia un pretesto evocativo, simbolico, sia un luogo reale, ma di una realtà più vera della stessa verità che si manipola da sé e si oscura. Tutta la forza della poesia della Bachmann è l’ostinato tentativo di dare luce, di porsi e di porci nella condizione di essere vedenti. Mettere in luce l’ente nella sua interezza e integrità con l’essere sembra pertanto una delle sue priorità. E per farlo non indugia nel confronto con una tradizione, con una storia, ma anche con una lingua di per sé già intimamente oscura e mancante: il linguaggio nella sua modulazione finale di poesia e di parola originaria. Quella parola ultima che la Bachmann non chiama Verità ma “quel che è vero”. Parola svelata e rivelata. Parola che si dà in presenza, prerogativa e virtù di un verso, di una rima, di un ritmo. La dovizia o la maestria con la quale la Bachmann padroneggia la varietà metrica dei testi è smisurata e commovente.
Chi legge il tedesco, di sicuro, potrà apprezzare di più gli screziati acumi di cura di una lingua e di un’abilità senza pari. E questo nonostante l’ottima resa di una trasposizione non facile. Schiavo del mondo, tu sei gravato di catene,/ma quel ch’è vero nel muro apre le crepe./Vegli e nel buio vai scrutando intorno,/a ignota via d’uscita tu sei volto. Il rimando platonico è piuttosto evidente. A prova di un impianto dell’opera essenzialmente filosofico. Ciò, però, che non debba sminuire quella policromia e quella leggerezza (chiarezza), acutezza e semplicità di un percorso poetico interrogante e scosso, quanto margine di ogni naturale sopportazione e originalità. Dov’è legge, ordine? Dove ci appaiono/comprensibili foglio albero e pietra?/Presenti sono nella bella lingua,/nel puro essere…/.
La Bachmann si era laureata con una tesi su Essere e tempo di Heidegger. Senz’altro la poetessa aveva letto del filosofo di Messkirch, l’interpretazione del mito platonico della caverna. E, tuttavia, a uno spirito così assorbente e sensibile, com’è accertato che fosse, di tutto ciò che erano le riflessioni e le necessità più innovative del secolo, non erano certo sfuggiti né Musil né Wittgenstein. Né un’intera sfilza di visionari come Hofmannsthal, Hölderlin, Trackl, Rilke. Per me, dichiara la poetessa in un’intervista del 22 marzo del 1971 concessa a Dieter Zillingen, non ci sono citazioni, ma alcuni passi che mi hanno sempre emozionato e che per me sono la vita. L’autrice attinge da dove può. E dove più le ritorna utile un tentativo di respingere quell’oscurità e quel male che la attraversa e di cui è partecipe il mondo. È responsabile il mondo. A questo proposito, il rapporto con Paul Celan è indicativo di un impegno etico e di una responsabilità della scrittura che la poetessa vede nella possibilità di una nuova lingua. Scrivere poesie diviene, quindi, il non tacere il dolore e il male della Storia. In pratica, un altro centro essenziale e nevralgico che si va ad aggiungere ai tanti, che insieme vanno a formare quell’intensa e complessa poetica che la Bachmann svilupperà in modo esemplare e duraturo. Il suo, in altre parole, è il tentativo più ampio e riuscito che sia mai stato compiuto di sovvertire i cliché di un repertorio poetico e letterario ormai logoro. La costellazione dell’orsa non è solo invocata, come suggerisce Luigi Reitani, ma contemplata con scetticismo nella sua dimensione minacciosa e ferina. All’immagine simbolica di antica tradizione, quella di una potenza celeste regnante, si affianca qui la sua parodia.
La Bachmann fa lo stesso con il topos del sud come luogo mitico, solare e iniziale. Nel mio paese primogenito, nel sud/mi assalì la vipera/e nella luce l’orrore. Emergono, nondimeno, una forza, una speranza. La neve non mi ha ancora/bendato gli occhi. Ed eccelle una vitalità non sempre esacerbata, o inasprita, ma attesa o richiesta. Implorata. In tal senso, ci indica Reitani, le poesie possono essere annoverate nel genere epidittico. La poesia è sempre rivolta a un Tu, diversamente dalla poetica di un Gottfried Benn che celebra “una poesia assoluta, senza fede, senza speranza, la poesia non diretta ad alcuno”.
Con la Bachmann, invece, si ha a che fare con un agire del linguaggio che benché aspro, inquieto, a tratti urticante, sappia essere di una dolcezza e di una forza poetica e invocante inaudita. O chiudi/gli occhi chiudi!/Sul morso premi la bocca! Dire della bellezza di quest’opera, così della precedente, “Il tempo dilazionato”, pubblicata nel 1953, potrebbe rivelarsi, a questo punto, superfluo. Versi che sono entrati nell’immaginario d’intere generazioni poetiche e che hanno reso altresì possibile un’esplorazione così profonda del linguaggio poetico che ha dato e continua a formare e far emergere poeti e risultati strabilianti possono e devono essere soltanto letti e riletti.
Intanto, grazie ad Adelphi per questo corposo volume, nella consapevolezza che ci sono poesie che non vogliono essere decifrate, ma che, tuttavia, continuano a “dire”. Forse, la poesia ha assunto definitivamente un linguaggio profetico. Se sì, come sembra, vista l’attualità di una tale risorsa, non potremo che darle la giusta attenzione. E in cambio ricevere la beatitudine della sua parola come della sua arte intransigente e complessa. E, per la Bachmann, innegabilmente salvifica. Forse che la vita sia altro da una difficoltà di vivere? Forse che la poesia non sia un tentativo di traduzione? O di contesa? O di gioia e di dolore? Di origine e di futuro? Vieni e non ti negare,/poiché noi siamo in lotta con tanto male./Prima che sangue di drago protegga il nemico/cadrà questa mano nel fuoco./Mia parola, salvami.
[Ingeborg Bachmann, Invocazione all’Orsa Maggiore, Adelphi, pag. 362]