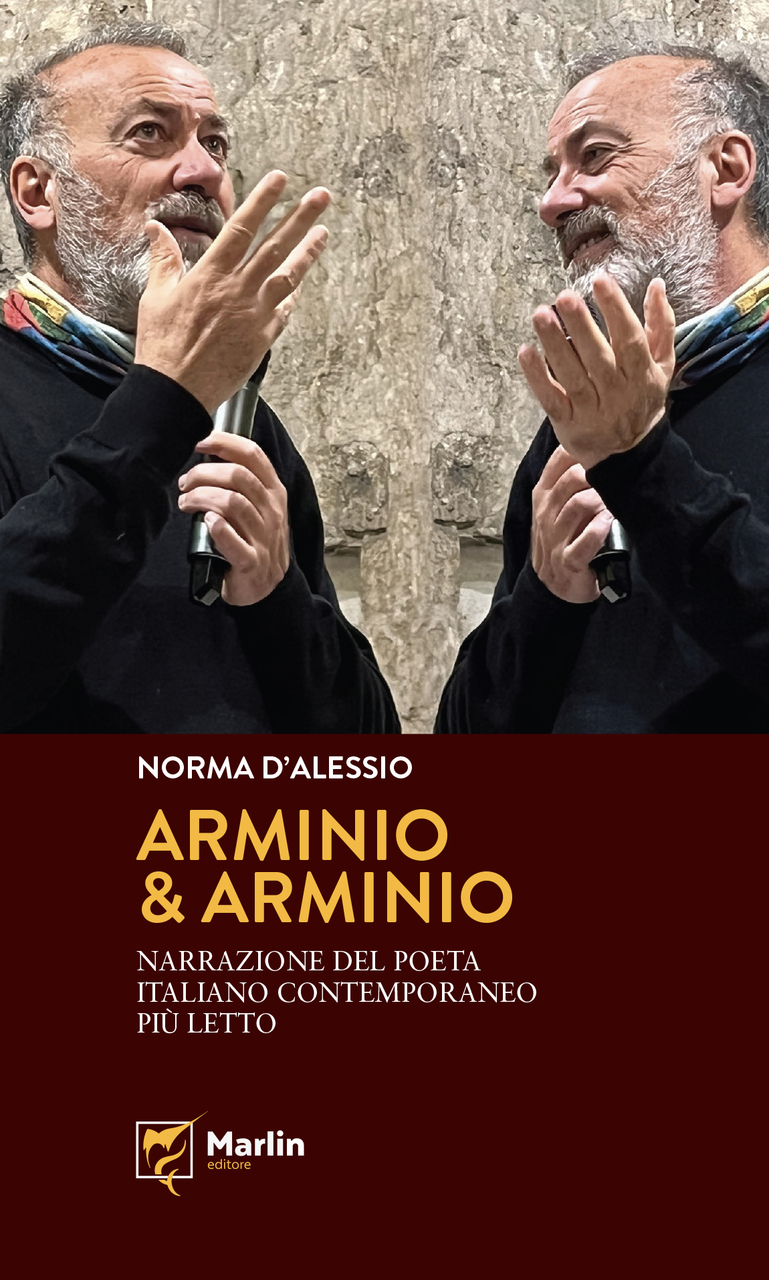Questo silenzio tornato dopo vent’anni non ha né il tepore, né la densità, né la luminosità del primo. Se in passato faceva pensare al silenzio che precede la nascita, ora assomiglia di più a quello che segue la morte. Mentre all’epoca osservava il mondo da sotto il tremolante luccichio dell’acqua, adesso ha l’impressione di essere diventata un’ombra che striscia sulla superficie rugosa dei muri e del suolo, e sbircia da fuori la vita contenuta in un enorme acquario. È in grado di udire e leggere in modo distinto ogni singola parola, ma non riesce a schiudere le labbra ed emettere alcun suono. È un silenzio freddo e rarefatto, come un’ombra privata del proprio corpo, come il tronco cavo di un albero morto, come lo spazio oscuro tra una meteora e l’altra. Han Kang, L’ora di greco, Adelphi, pag. 163.
Romanzo della scrittrice coreana de La vegetariana, altro libro limite tra principio di realtà e la sua dissoluzione, che interroga in una sorta di continuità speculativa con il libro citato, quell’assurdo indimostrabile che è la ragione o il sogno di esistere in un incomparabile dialogo tra due protagonisti, uno nell’atto di perdere l’uso della parola e l’altro di avvicinarsi lentamente e inesorabilmente alla cecità assoluta. In una Seoul torrida e mossa, una donna cerca di recuperare la parola che ha perso, forse, per una serie di traumi. Le era già accaduto una prima volta, da adolescente, e allora era stato l’insolito suono di una parola francese a scardinare il silenzio. Ora, di fronte al riaffiorare di quel mutismo, si aggrappa alla radicale estraneità del greco di Platone nella speranza di riappropriarsi della sua voce. Nell’aula semideserta di un’accademia privata, il suo silenzio incontra lo sguardo velato dell’insegnante di greco, che sta perdendo la sua vista e che, emigrato in Germania da ragazzo e tornato a Seoul da qualche anno, sembra occupare uno spazio liminare fra le due lingue. Si stabilisce così un racconto di nostalgia, di passato e di scelte che non hanno più possibilità di essere mutate né rimosse. Riemerge così in maniera spietata un tutto, una realtà, un’intangibilità, capace di costruire una trama di eventi intessuta di un presente fatto di penombre, di sfumature lievi come il procedere di una scrittura semplice ma ammaliante. Una scrittura, muta, ovattata. Orientale? E che la traduzione di Lia Iovenitti rende in maniera efficace. Una scrittura che sembra emergere più da un vibrare dell’aria che dai segni scuri, seppur armonici di una lingua o di un linguaggio che vuole essere interrogato e svelato: il greco in analogia formale con il coreano. O con qualsiasi altra lingua o idioma. O voce! Questo è un luogo da cui è difficile/avanzare in qualunque direzione./Dove regna un’oscurità impenetrabile/ed è difficile trovare alcunché. Che cosa resta allora di un vedere che non può più guardare? O di una parola che non può più essere pronunciata? Che cosa forma, allora, la realtà? E che cosa sono i sogni se il sangue scorre, e le lacrime brucianti sgorgano? Le lezioni di greco, nello sviluppo della narrazione, di conseguenza, non sono soltanto il luogo di un incontro tra un uomo e una donna che si riaffacciano ai sentimenti o alla ricomprensione della vita, ma sono l’estensione di un’interrogazione della ragione platonica nella dimensione di Logòs e Theoría. Uno dei dottorandi del corso: “Volevo chiedere qual è la differenza tra il divino τό δαίμων tó daimonión e il sacro τό θεῖον (tó theîon). La volta scorsa ci ha detto che θεωρία (theoría) indica “l’atto di vedere”. Anche il sacro, tó theîon. È legato al verbo vedere? E se è così, allora la divinità è un essere che vede? O è lo sguardo in sé?” Ci s’immerge così all’istante in una riflessione che interroga la vita in un percorso che non è solo filosofico, poetico e letterario ma intimo. Il richiamo a Borges – la cecità che colpisce lo scrittore argentino nei suoi ultimi anni – non solo introduce il romanzo ma ne dà una chiave di lettura privata che si fa via via assoluta e interrogante. L’offuscamento è intralcio, freno, blocco che va a impedire il mondo? O lo avvia? Lo diminuisce o lo accresce? Si finirà per vedere solo nei sogni? A un primo sguardo sembra che la perdita della vista e della parola diventano incomprensione e insensibilità di una ragione che non ottiene nessuna benevolenza anche da un Dio che si sforza di essere tale. Se Dio non è né buono né onnipotente, non possiamo chiamarlo Dio. Di conseguenza, parlare di un Dio buono e onnipotente è un assurdo indimostrabile. Dunque, si fa palese un’altra entità: il tempo. Sono sempre più sopraffatto dalla sensazione che il tempo attraversa costantemente il mio corpo come il lento, inesorabile fluire di un’enorme massa di materia. Spazio e tempo non sono più le determinazioni della realtà, ne diventano attributi di una sollecitazione emotiva e spirituale. Ciò che rende il libro toccante e pervaso di una limpidezza straniante. Libro dolce, delicato, bello, nel senso di nobile e difficile come nelle possibili traduzioni chalepà tà kalà: le cose belle sono belle, sono difficili sono nobili. Libro anche che non è un libro, ma un dolore! Un dolore che incalza come lo scorrere di un fiume placido. Un dolore asperso, venato, intriso di malinconia e forse di rassegnazione. È possibile che ci siano cose con le quali, a prescindere da cosa esse siano e dove esse accadono, non ci si possa riconciliare. Senza il minimo rumore, in lontananza, le macchie solari esplodono. I cuori e le labbra che si toccano, uniti ed eternamente separati.
[Han Kang, L’ora di greco, Adelphi, pag. 163]
Han Kang è nata nel 1970 in Corea del sud, a Gwangju, la città del massacro seguito alla rivolta popolare del maggio 1980. Pochi mesi prima, nel 1979, la sua famiglia si trasferì a Seoul. Di lei Adelphi ha pubblicato la vegetariana (2016), Atti umani (2017 e Convalescenza (2019). L’ora di greco è apparso per la prima volta nel 2011.