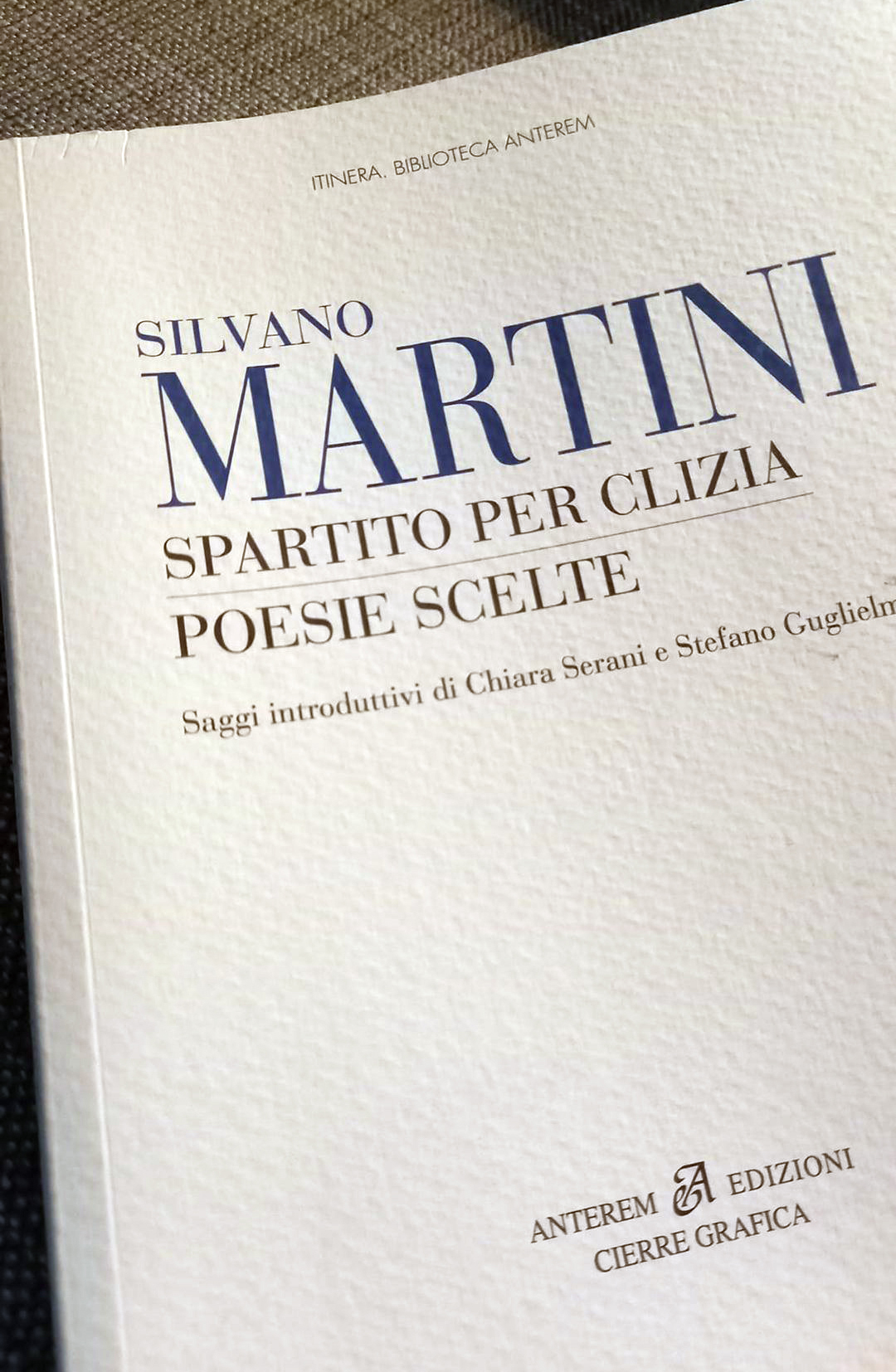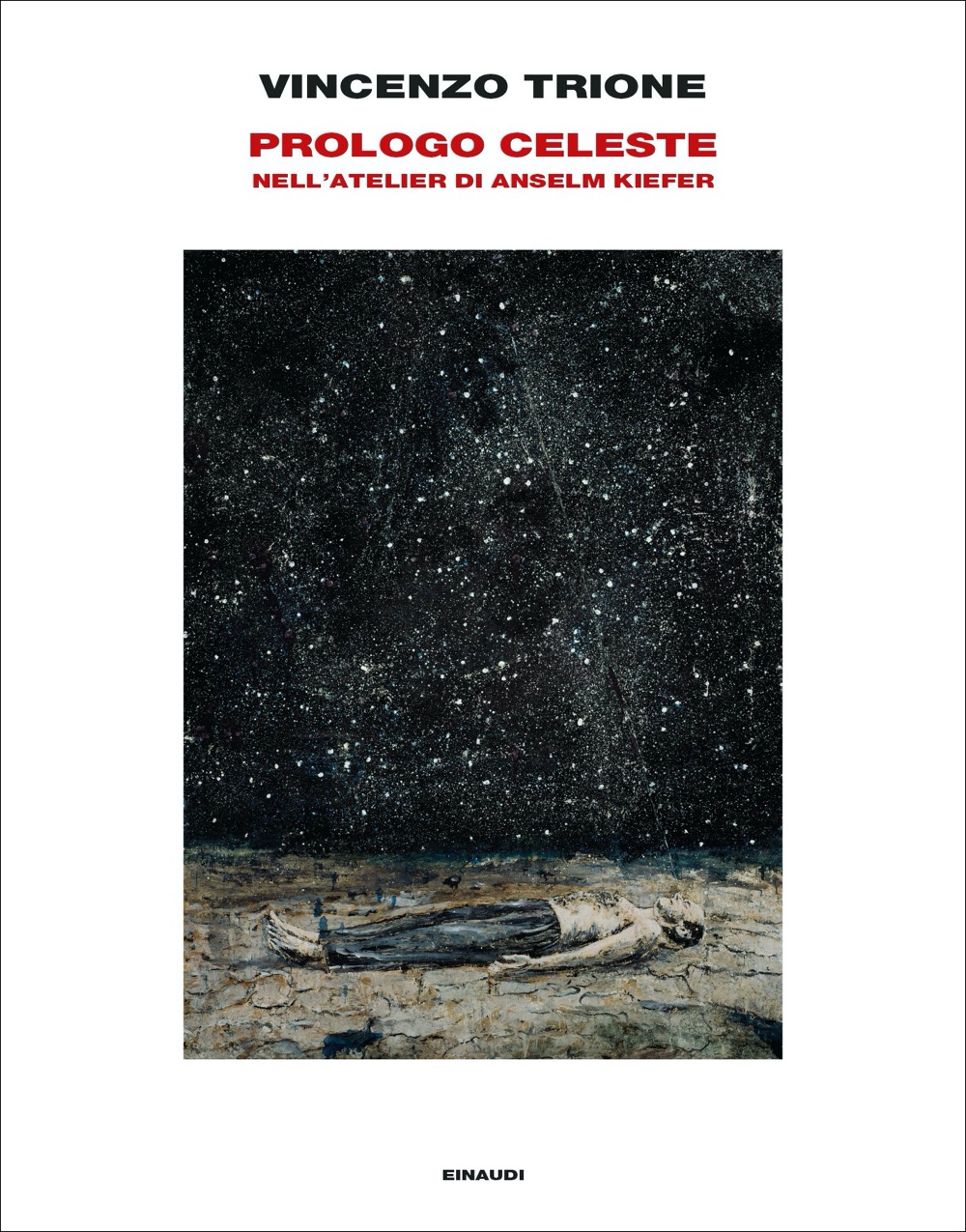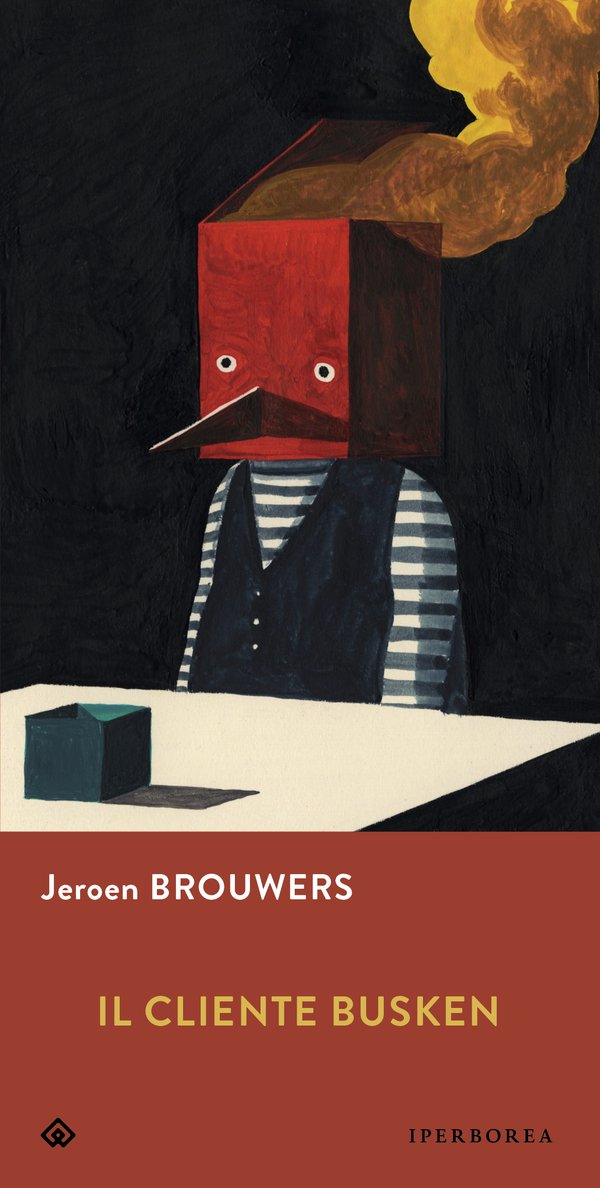Sciogliendole addosso onde su onde, nella sillabazione della bocca chiusa, e il viso bianco, con quell’onda che dà maggior spavento, nella sua stanza ferma, il lenzuolo sollevato dal naso e dal mento, una casa deposta e rimasta in quel luogo, niente dovendo passare in quel momento, attraverso una nitidezza rimasta tale, mentre ascolta cose che se ne stanno molto sotto, ordinando alla mente, nella sua elasticità per l’intero tronco, per un orecchio, finché quelle due cose si toccano appena, finché cominciano a mettersi arsura, lo spazio, il sale, ciascuno tenendo troppo a se stesso, ciascuno non avendo attenzione per il territorio più occulto di sé, e lampade, a filamenti senza protezione, bruciati subito dall’aria fredda, in lei in lei in lei, e molto più dentro e ancora su lei per fermarsi dentro fino a dimenticarsene… Silvano Martini, Spartito per Clizia, Poesie scelte, Anterem, pag. 159.
Nel centenario della nascita di Silvano Martini (1923-1992, cofondatore e condirettore della rivista “Anterem”) Anterem, ora anche casa editrice, ripubblica in anastatica – comprendente la postfazione originaria di Frediano Sessi – la sua prima opera in prosa, Spartito per Clizia del 1986, con l’aggiunta di una scelta di poesie tratte da Mareale (1985), Esecuzione (1991) e Coronaride (1992). A chiarirci un po’ “Spartito per Clizia”, se di chiarezza (accessibilità) si può parlare a proposito di un testo dalla straordinaria ebbrezza della parola e del desiderio, sono due note, una è la già riferita postfazione di Sessi, l’altra, non meno complessa e straordinariamente vasta e articolata, è l’introduzione di Chiara Serani.
Due note che meriterebbero un approfondimento a parte e una non meno esegesi della critica spiccatamente a una tradizione letteraria che la vede riducibile al testo e non al suo aumento, rinforzo o, addirittura compimento, se lo comprendiamo (sentiamo) nella sua prerogativa incoativa. In altre parole, come testo che inizia il romanzo, “lo scritto”, dentro quel movimento che è la sua naturale immobilità. Dentro quel solo movimento a ruota, con quell’intera ruota dentro, scrive Martini già nel primo capitolo di uno dei testi più ardui e meglio organizzati della sperimentazione neoavanguardista di fine Novecento. E che Chiara Serani introduce magistralmente con una lettura se non esaustiva, densa. O, almeno, concentrata nel tentativo di una definizione di un’opera che sfugge con autorevolezza (competenza) a qualsiasi tentativo di determinazione e di collocabilità. Non romanzo? Romanzo assente? Romanzo liquido? Mi sovviene, scrive la Serani, che “definire” è fermare, fissare, circo-scrivere, ovvero l’esatto contrario di quel vagare e aprirsi rizomatico tanto auspicato dal nostro autore. Allora, non resta che l’estro della parola per rendere omaggio alla genialità di un testo con un altro testo, quello che ci indica la Serani, di Gianni Toti dal titolo Cliopeopea.
Ma veniamo al testo (quale?), perché di testi ce ne sono vari, sebbene con nomi diversi. Poesie sono così nominati i testi scelti e introdotti da un altro testo, o nota, questa volta di Stefano Guglielmini, che meriterebbe altrettanta attenzione similmente ai testi citati finora. Si capisce che si ha a che fare con testi e autori che celebrano sì Silvano Martini, ma soprattutto il linguaggio. Una lingua. O piuttosto l’idea di una lingua, di un idioma che come suggerisce Agamben, per chi medita sull’indicibile, è un’osservazione istruttiva che ciò di cui non può parlare, il linguaggio può, tuttavia, perfettamente nominarlo. Onoma e logos, allora. Piano del nome e piano del discorso. Clizia è il nome di ciò che è indicibile, lo spartito è il discorso, il testo che si stratifica in un dire testimoniato dal linguaggio e (come spartito) dai suoi esecutori (lettori e testimoni). Il testo di Martini, quindi, si penetra, o ci s’illude di farlo, per gradi, con piccoli passi, attraversando rimandi e suggestioni che il testo offre come segni su cui soffermarsi, che siano essi di natura grafica o metaforica. O provocatori di un mondo mitico, o tutto da rifare. Clizia rimanda, ab origine, alla ninfa di Ovidio e al suo tragico amore per il dio del sole e di come si fosse trasformata in girasole dopo essere stata abbandonata da Apollo per la più bella Leucòtoe: in preda a una furiosa gelosia, Clizia aveva rivelato al padre della rivale, poi sepolta viva per punizione, del suo amplesso con il dio, e si era quindi lasciata andare a un’invincibile prostrazione sino a mettere radici nel terreno e a consumare i propri giorni seguendo con lo sguardo il carro solare e il suo guidatore, oggetto di struggimento e ossessione libidica. Chiara Serani suggerisce a proposito una fissità circolare, modello e ipostasi di un’ossessione amorosa e di un’inappagabile sete di desiderio sessuale.
Martini lo dice chiaramente: Clizia si pone in un largo e sbrigliato gioco dei sensi e del sesso. Tuttavia, lo scarto che il linguaggio offre, come pura la divisione del testo (spartito) che richiama una musicalità dodecafonica, ci permette di poter considerare il testo come una forma assoluta di amplesso. Amplesso nella forma più assoluta di quell’indicibile che solo il linguaggio può attestare attraverso le sue forme che qui si manifestano a vari livelli di “unione” e di “desiderio”. Nome e logos. Poesia e prosa. O anche verità e discorso. Martini in “La fossilizzazione del linguaggio”, scrive di una pressione, di una necessità, di un bisogno a unificare per rendere l’immagine cercata intelligibile. Si può dire, senza acuire troppo il discorso, chi volesse ha l’opportunità dei preziosi testi critici che introducono l’autore, che la lingua di Martini è soltanto apparentemente inafferrabile, anzi essa è accuratamente una lingua avveduta e smaniosa di poter essere letta e compresa. Nient’affatto un linguaggio refrattario, allora, quello di Martini ma seducente e pervasivo, perché ogni buon linguaggio è sempre detestato oltre a essere un irrefrenabile desiderio di scrittura e di sincerità. E ancora, perché lascia spazi enormi davanti a sé, distanze terrene o celesti assolutamente da percorrere sia per perdersi sia per ritrovarsi. In ogni caso, in nome di quella libertà espressiva che sola rende la parola, una vertigine degna di essere attraversata. Non ci si fermi, allora, alle prime difficoltà di comprensione di questa meraviglia che è Spartito per Clizia o che sono le poesie qui raccolte, ma ci si lasci andare in quel magma acquatico che è la scrittura di uno sperimentatore e di un filosofo che vuole dire nella maniera più incondizionata e piena la verità di un desiderio, di un’aspirazione, di un atto. E lo fa proprio nella maniera di una lingua che viene a esistere nel suo elemento sorgivo, cioè un portare all’aperto quel suono che è il levarsi, il salire del senso dal suo inabissamento, per portarlo in quell’oscurità totale che è la luce. Luce e oscurità qui si contemplano e contendono il significato del nostro esistere in una scrittura di pensiero e di luogo perfettamente sognante, dove ogni essere può tornare a splendere nella sua essenzialità di vuoto e di pieno. Eros e thanatos, come suggeriva Bataille. Clizia che esiste non esistendo. E il linguaggio che si ravviva come una brace quando essa è assolutamente opaca, o sembra spenta; perché il fuoco sta sotto, nascosto per poter all’inatteso declamare la sua fiamma, il suo testo, la sua dischiusa realtà. Uno, che come rifletteva Damascio, non è soltanto Uno ma tutto-uno, e Uno davanti a tutto, non Uno di un tutto.
Silvano Martini (1923 – 1992), poeta, narratore, critico letterario e d’arte, ha fondato e diretto con Flavio Ermini la rivista di ricerca letteraria “Anterem”. Ha collaborato a riviste italiane e straniere. È compendiato in varie antologie poetiche. Ha collaborato con vari giornali e con il quotidiano L’Arena per molti anni, con articoli di letteratura e di arte. Fu il primo in Italia, nel 1976, a recensire Rhizome di Deleuze e Guattari.