Questo romanzo sarebbe piaciuto molto a Carlo Mosca, prefetto e consigliere di Stato che ha sempre tenuto al centro della sua riflessione la relazione tra diritto e misericordia, e di cui rimpiango la densa conversazione, giacché, se è vero che il diritto, per essere strumento di giustizia e di democrazia, deve sempre essere certo, è ancor più vero che, concluso l’esercizio dell’amministrazione della giustizia positiva, rimane uno spazio insoddisfatto e ansimante che reclama la giustizia giusta.
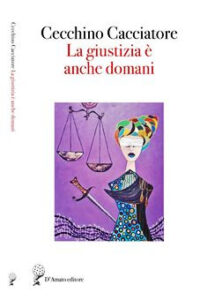
L’autore, Cecchino Cacciatore, esplicitamente esprime la sua preferenza, come gli ricorda il vecchio avvocato dilaniato dai sentimenti contrastanti per il figlio violento, per una «giustizia scrutabile da un altro punto di vista, quello della solidarietà di cui tante volte ti ho sentito parlare quando ti veniva chiesto cosa fosse per te il garantismo» (p. 16), al contempo manifestando la condanna per il perverso populismo giudiziario che ha sconvolto (con il plauso di incoscienti formazioni politiche) l’equilibrio dei poteri costituzionali: «Erano appena trascorsi – lasciando segni di ignominia – gli anni del populismo politico e giudiziario più accesi. Gli anni in cui si pensò di mondare l’illegalità con la legge bendata, e meglio se nella lotta tra i copri delle persone e il potere la spada mieta i vinti sopraffatti e raggiunti indifesi nel sonno della ragione i più deboli» (p. 17).
Ma la idea della vita come principio fondativo del diritto riguarda la vita come esistenza storica, cui non basta l’effettività stessa del diritto, come espressione della libertà e dunque della dignità umana, la sua realizzazione, la sua attività nel mondo, basandosi sulle convinzioni profonde e dei sentimenti che hanno reso l’umanità più umana. L’esperienza giudiziaria ha travolto invece troppo spesso queste radici essenziali dell’esperienza giuridica (come la insegnò a tutti Giuseppe Capograssi), fino a legittimare aberranti valutazioni di priorità da applicare anche attraverso la norma giuridica e gli atti del diritto pubblico alla vita delle persone, considerate più o meno meritevoli di diritto alla esistenza. Questa mi sembra la più radicale delle modificazioni che l’esperienza dell’applicazione del diritto ha subito e che questo romanzo affronta, con tutte le conseguenze immaginabili sull’ordinamento giuridico, le quali inevitabilmente ripropongono gli interrogativi che da sempre intrigano la scienza giuridica sul rapporto che intercorre tra diritto e morale, sul diritto positivo, sui suoi criteri fondativi. In questo caso la centralità della figura del figlio, non certamente irreprensibile moralmente, finisce per complicare ulteriormente il quadro entro il quale il giudizio può svolgersi.
L’eguaglianza
valore decisivo
Cacciatore sostanzialmente dimostra, mi sembra, che nell’applicazione della norma generale (perché sia imparziale) al caso particolare la misericordia è stata chiamata a cooperare nella definizione degli atti giuridici. Il principio di eguaglianza – posto a fondamento dell’età contemporanea nella politica e nel diritto al di là del suo senso formale, ma come sostanziale ripristino di sostegno ed occasioni per quelli che ne risultano privi (i disabili, le vedove e gli orfani evocati già dal profeta Isaia) – assicura condizioni eguali per tutti, ed invece esso risulta scardinato quando si utilizzino, di fatto, criteri discutibili che giungono fino alla limitazione delle libertà vitali, alla alterazione del percorso della vita.
L‘idea della vita deve dunque costituire un orientamento necessario, in una società non più omogenea culturalmente, per guidare la legislazione su materie che coinvolgono i diritti fondamentali nelle moderne società. Rischia infatti l’inconcludenza ogni soluzione che comporti alla fine il rifiuto della legge etica rassodata dall’esperienza storica, portatrice proprio di una idea della vita che la civiltà giuridica ha progressivamente e lentamente consolidato, custodendone i principi e traducendoli in norme. Si può così tentare di circoscrivere l’arbitrio derivante tanto da un astratto “naturalismo”, falsamente universalistico, quanto dall’accettazione dei “particolarismi” culturali che contrastino con i diritti umani fondamentali. Proprio questa prospettiva, dunque, richiede necessariamente che “si facciano i conti” con il significato che nella modernità assume il giusnaturalismo, tanto più nell’epoca oggi definita «era della globalizzazione», segnata dalla crisi degli stessi ordinamenti giuridici positivi e della loro fonte contrattualistica o statuale, in nome e a vantaggio di una nuova lex mercatoria in grado di sostituire le volontà e le prassi commerciali e finanziarie dei grandi centri economici ai poteri pubblici e alla dialettica democratica.
Norma positiva
e diritto giusto
Hans Jonas ha ripreso con autorevolezza il tema del rapporto tra norma positiva e diritto “giusto”: «possiamo sicuramente, di fronte a ogni diritto vigente, porre in generale la questione se esso sia anche “giusto”; e ogni singolo soggetto giuridico può eventualmente opporre a esso i suoi diritti, in quanto trascurati dal diritto generale. (Questo diritto a ciò – almeno interiore – è una sorta di metadiritto rispetto a tutto il diritto posto). In entrambi i casi viene evidentemente evocato un diritto al di là di quello vigente, di fronte al quale quello vigente si deve giustificare e sul quale può fondarsi la contestazione di diritti trascurati», e pertanto, «benché non vogliamo erigere lo stato a censore e nemmeno a guardiano dei costumi non vogliamo neppure farlo diventare d’altro lato complice protettore di ciò che è immorale. Poiché non può ricorrere ad alcun diritto passato per i nuovi conflitti di desideri e valori qui emergenti, allo stato non resta dunque questa volta altro che ricorrere all’istanza della morale per essere creatore di diritto in questa materia se non vuole seguire semplicemente la tendenza dei momentanei desideri della maggioranza»[1]. Il diritto è chiamato a regolare la convivenza con diritti e doveri, sul piano di eguaglianza che esso assicura.
La sfida che la modernità ha ingaggiato con il giusnaturalismo ha liquidato ogni riferimento ad una natura dai tratti immutabili, e, come si diceva, il positivismo giuridico ha potuto così contrassegnare il diritto moderno; eppure l’istanza giusnaturalistica è continuamente rifiorita (fino alle rivendicazioni di un “diritto naturale vigente” nelle epoche di crisi seguite alle esperienze drammatiche che imponevano una concezione del diritto come espressione della pura forza, come nel periodo successivo alla caduta dei totalitarismi e al processo di Norimberga) nel senso di una rivendicazione morale della legge quale sentinella della giustizia, come nella argomentazione di Jonas prima ricordata. La discussione si è così spostata sul cosiddetto relativismo, che rappresenta la premessa per la diffusione di un atteggiamento che, specie in certi ambiti culturali e sociali, comporta soprattutto una sottovalutazione degli atteggiamenti relazionali rispetto a quelli individualistico-utilitaristici. Ciò comporta una crisi di autorità (intesa nel senso capograssiano di realizzazione della libertà che si autocircoscrive), la quale viene sostituita dalla legittimazione della “opinione dei più numerosi” o dalla convinzione che acquistino validità i comportamenti più diffusi per il solo fatto che lo siano, elidendo ogni considerazione valoriale (e universalistica), optando per un politeismo dei valori in grado di legittimare la produzione individuale o di gruppo degli ordinamenti giuridici.
Valore formale
della regola
La nostalgia per l’unità del diritto – che sembra attraversare il pensiero giuridico proprio quando esso sconsolatamente è impegnato da un lato a constatare la fine degli ordinamenti giuridici nazionali e a celebrare d’altronde la inattingibilità del diritto universale – riemerge imprevista quando, paradossalmente, viene affermata l’esigenza imperiosa di riconoscere la vitalità del diritto reale attraverso l’esaltazione del nuovo diritto enucleato nell’azione dei banchieri, dei giudici ed arbitri privati, dai capitani di ventura della nuova impresa globale. Occorre peraltro ricordare come la definizione degli stessi diritti umani sia il frutto di un lungo processo di acquisizione storica che ha selezionato i diritti ritenuti inderogabili e fondamentali per la persona, e che costantemente si rinnova e si ridefinisce. In questo risiede quella esigenza di misericordia verso cui manifestiamo profonda nostalgia quando l’applicazione del diritto positivo ci sembra incompleto o insoddisfacente per il senso stesso della giustizia come la sentiamo, individualmente o partecipando di opinioni collettive. Per questa ragione vanno distinte le richieste di gruppi o culture che siano valutate solo tollerabili, da quelle che invece concorrono ad una progressiva e costante integrazione fino a che siano condivise dall’intera comunità per assumere valore formale di regola o norma comune. Ma non scambiamo mai i due piani: Giuseppe Capograssi ammoniva che l’imperativo giuridico «salva l’azione», mentre l’imperativo morale «salva l’agente».
L’avvocato penalista (e scrittore) Cecchino CacciatoreInsomma Cacciatore col suo romanzo incrocia i più delicati momenti della transizione epocale che vive all’alba del terzo millennio la civiltà giuridica, la quale appare scossa anche nelle sue fondamentali convinzioni saldate sulla roccia dello Stato di diritto. Quante volte la piazza insoddisfatta dell’esercizio della legalità invoca – in nome dei più alti principi corrispondenti al criterio che in quel momento appare più idoneo a fare giustizia e ad esercitare la misericordia – un criterio extragiuridico (che superi l’eguaglianza formale), appellandosi sempre alla individua coscienza, il cui contenuto è affidato all’arbitrio individuale, che valuta imperfetta la norma giuridica, ed ingiusta la sua applicazione (che però spesso arriva proprio quando l’interprete si discosta dalla legge stessa), rivendicando il dominio della propria opinione, preferita all’oggettività della legge e alla certezza del diritto. Hobbes, del resto, ha richiamato la necessità del diritto proprio perché intravedeva il lato dell’ombra nel cuore dell’uomo, lupo per i suoi simili, e la malvagità delle sue azioni segnate dall’oscurità originale, che invece nella legalità perseguita dal rito del processo [2] cerca il suo rimedio. L’illusione della giuridificazione – spesso, troppo spesso invasiva in materia che dovrebbero restare dominio della morale e della misericordia – non può far dimenticare pertanto che le misure giuridiche intervengono a disciplinare gli atti formali (il foro esterno descritto dagli antichi giuristi), ma non il foro interno della coscienza e della solidarietà (e della responsabilità).
In realtà, se una chiave si può rintracciare nel racconto, è proprio quella della sparizione del peso della responsabilità, sradicando la quale si può lasciare libero campo ai sentimenti paterni, al perdono (non disinteressato, però, come più volte il romanzo rende evidente quando indugia sul sentimento di autocondanna e di autocolpevolezza esibito dal padre per attenuare la realtà stessa del comportamento filiale). Si legga in questo senso lo strappo che registra il sentimento di impunità chiaramente avvertito dal figlio : «L’imputato, che a quel punto, diede la chiara sensazione di non sentirsi affatto tale (colpevole), anzi, certamente vittima incolpevole di un assurdo tenore comportamentale altrui» (p. 53), fino al valore (invocato dallo stesso padre accusatore) della comprensione come ingrediente essenziale per giustificare ogni eccesso del figlio, che finisce per liquidare l’esperienza stessa della amministrazione della giustizia, affermando addirittura «l’indisponibilità di un concetto definitivo di giustizia entro il quale serrare un qualsiasi caso concreto» (p. 47). Viene così evocata – a risarcimento di una vicenda capovolta – invece che l’azione irresponsabile del figlio, la trascuratezza colpevole del padre, trascurando però il fatto che si tratta di atti di differente rilevanza giuridica.
Quei diktat
della storia
La responsabilità è ineliminabile dalla storia e dall’esperienza del diritto, che sarebbe invece monca senza di quella al punto da non poter fondare alcuna civiltà giuridica sottratta alle convenienze e alle insidie provenienti dai più, minando dunque in modo inesorabile il principio di eguaglianza. Il capovolgimento (fino allo stravolgimento) è manifesto: «Lui non era, né si riteneva responsabile di quelle azioni, in quanto la sola presenza del padre – sempre inutile nella crescita prima adolescenziale, dopo nella fase dell’età più matura – era disturbante ed una provocazione in sé» (p. 43). La misericordia non può essere antitetica, ma piuttosto correttiva del diritto e della legge, nel rispetto del principio di eguaglianza.
Ove la misericordia sostituisse la certezza (ed il rigore) della prescrizione giuridica invece di integrarne efficacemente il cammino, sarebbe capovolto il principio di tutela che il diritto deve assicurare ai più deboli. Rischierebbe di sparire d’un tratto la stessa civiltà del diritto.
Cacciatore, La giustizia è anche domani, Salerno, D’Amato Editore, 2023
[1] H. JONAS, Rechte, Recht un Ethik, in DÄUBLER-GMELIN e ADLERSTEIN (a cura di), Menscherenrecht. Arbeitswelt-Genforschung-Neue Technik-Lebensformen-Staatsgewalt, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1986; tr. it. Diritti, diritto ed etica: come rispondono all’offerta delle più recenti tecniche di riproduzione, Sesto Congresso giuspolitico della SPD, Essen, 20-22 giugno 1986, ora in Tecnica,medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Torino, Einaudi, 1997, p. 223.
[2] Cfr. G. Acocella, Principio di legalità ed esperienza giuridica nel processo di G. Capograssi. In Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. Acocella, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 175-185.








