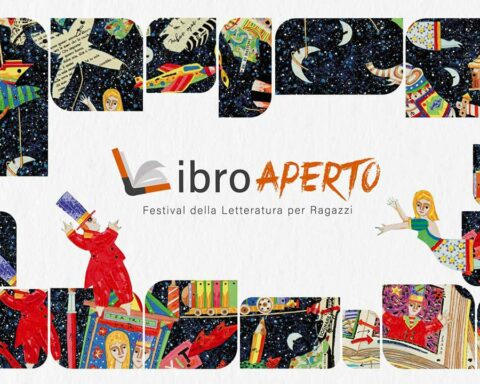Sabato 16 dicembre, alle ore 19, sarà inaugurata al Museo-FRaC Baronissi la mostra AFRICAN CONTEMPORARY ART. Miti, simboli e altri segni. Opere dalla collezione di Mino Sorvillo.
La mostra, curata da Massimo Bignardi propone cinquantaquattro opere, disegnando un percorso che si snoda su due tracce parallele: da un lato le opere di artisti contemporanei, dall’altro gli oggetti, gli idoli, le maschere provenienti dalla stessa collezione che tessono una sorta di trama comune, di dialogo tra il mondo dei miti, dei simboli posti a contatto con i segni della contemporaneità. In mostra le opere di: Mandu Mmatambwe Adeusi (1914-1984), Edward Saidi Tingatinga (1932-1972), Kasper Henrik Tedo (1921), Simon George Mpata (1942-1984),Omari Amonde (noto come JaJamonde 1940), Pierre Camille BODO (1953), Paulo Kapela (1947-2000), Jak Katarikawe (1940), George Lilanga (1934-2005), Esther Mahlangu (1936), Kivuthi Mbuno (1947), Hashim MRuta (1942), Cyprien Tokoudagba (1939-2012), Mohamed Charinda (1947-2021) e Twin Seven Seven (1944-2011). Si affiancano, in alcuni casi anche come continuità stilistica, figure di artisti più giovani, quali Cheri Samba (1956), Stephen Kasumba (1960), Roumauld Hazoumé (1962), Maurus Michael Malikita (1967), Meek Gichugu (1969) e Didier Ahadsi (1970).
La mostra resterà aperta fino a domenica 25 febbraio 2024.
Chiede un tempo prolungato e presenta maggiori difficoltà la ricerca e lo studio di culture delle quali abbiamo una conoscenza scolastica e, soprattutto, culture avvolte ancora oggi da diffidenze, da falsi criteri di analisi storico critiche, persistenti nella cultura occidentale.

Tracciare le linee di una mostra dedicata all’arte contemporanea africana, richiede, quindi, un tempo prolungato se si vuole evitare il ruolo del verbalizzatore di attualità celebrate dal così detto mercato internazionale dell’arte. Un tempo maggiore che non è solo quello dedicato ad alimentare la conoscenza, ossia intrecciare i fili di letture, di saggi, di articoli, letti nel corso degli anni senza un preciso ordine, quanto riflettere sulle immagini, sugli oggetti, assunti come corpi reali di lontane creatività, insomma allungare lo sguardo in un mondo sconosciuto. Così è stato per il progetto di questa mostra, nato da diversi anni, delineatosi nel tempo come riflessione ancora aperta e carica di dubbi. “Devo immergermi sempre di nuovo nelle acque del dubbio”, scrive Wittgenstein, in apertura delle sue osservazioni sul Ramo d’oro dell’antropologo James George Frazer, primo interesse per l’antropologia del filosofo tedesco.

Il dubbio mi ha accompagnato in questi ultimi anni, quando con Mino Sorvillo abbiamo tracciato le linee di una esposizione che tenesse insieme i molteplici aspetti della sua collezione di dipinti e sculture di artisti contemporanei africani, unitamente al vasto repertorio di oggetti, maschere, feticci dell’Africa subsahariana. Una collezione vasta, in particolare di quelle opere che, solitamente, nelle aste sono indicate come oggetti d’antiquariato, accogliendo datazioni che vanno dalla fine del XIX alla metà del XX secolo. Degli artisti contemporanei, nell’accezione di un contemporaneo che va dal secondo dopoguerra alla fine del secolo e, quindi, non di una stringente attualità, abbiamo volutamente insistito sui maestri, i primi comparsi sulla scena internazionale e acquisiti da istituzioni museali di significativo rilievo. Tra questi: il Museo Nazionale dell’Arte Africana, Smithsonian; il Museo di Houston; la celebre collezione Jean Pigozzi; la Fondazione Gulbenkian. Il dubbio era, in parte persiste, se il nostro punto di vista non fosse abbastanza chiaro, cioè fosse opportuno tenere fuori le ultimissime generazioni, quelle formatesi, soprattutto, nelle grandi capitali dell’arte attuale, New York, Londra e in parte Parigi. Tra gli esempi si possono citare due artisti che il “Time” indica tra le personalità influenti nel mondo dell’arte, Julie Mehretu (etiope-americana, nata a Addis Abeba nel 1970), autrice di Conversion, inchiostro e acrilico su tela, del 2019-20, oppure il kenyano-britannico Micael Armitage, nato a Nairobi nel 1984, autore di Necklacing, una tela del 2016, opere che, di recente, ho avuto modo di vedere al MoMA. La prima riprende una gestualità che, se pur nell’evanescenza del segno, declina una gestualità propria dell’action painting, mentre per Armitage è il linguaggio figurale neo-espressionista a segnare la traccia. Il nostro desiderio era ed è quello di tenere insieme, anche misurando arbitrarie vicinanze, linguaggi estetici formali che dalla tradizione rituale, ovvero dal repertorio di oggetti, di maschere, di feticci, presi dal mondo magico, dal simbolico, fossero transitati nell’immaginario creativo di tanti artisti che, dagli anni Quaranta, hanno dato vita a una nuova stagione dell’arte africana. La necessità, in primis, era di sfuggire alle mode che ora imperversano nel mercato dell’arte contemporanea con i fari puntati su esperienze creative, grandi dipinti, fotografie manipolate al digitale, sculture e installazioni, che palesano una formazione culturale di matrice occidentale di estrema attualità, e attrattive del nuovo collezionismo. Certamente, questo non è da tenere in secondo piano, anzi ci offre un quadro aggiornato di quanto i processi della globalizzazione abbiamo segnato e segnano la sfera della creatività. Un panorama che è in continuo aggiornamento e che è sostenuto da una forte attenzione della stampa specialistica, ma anche dall’editoria: soffermandoci solo alla scena italiana, diverse sono le pubblicazioni, monografie, cataloghi di mostra, riviste apparse negli ultimi decenni. La base della mia riflessione, ma anche dei dubbi che la avvolgono, è stato riprendere quanto scrive Federico Zeri, nella chiusa della prefazione all’edizione italiana del libro di Sally Price, I primitivi traditi, letto nei primi anni Novanta, quando insegnavo presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino.

Zeri concludeva che Price “ci insegna a tener conto della cautela con cui dobbiamo accostarci a quanto ci perviene dal passato e da altri mondi culturali e mentali”.
Le citate note di Wittgenstein e questo di Price hanno fatto da battistrada al mio interesse per il mondo dei “primitivi”, negli anni lievitato senza nessuna finalità: successivamente, con la finalità se non quella di acquisire la conoscenza di aspetti formali, stilistici, estetici. Tali aspetti, li ho ritrovati nel volume, Arte primitiva. Forme Simboli Stili Tecniche, di Franz Boas (la prima edizione, Oslo 1927), apparso in prima edizione italiana per i tipi di Bollati Boringhieri, Torino, 1981, ristampato nel 1999. Di seguito, la lettura de La via delle maschere di Claude Lévi-Strauss (Il Saggiatore, Milano, 2016), a mio avviso fondamentale per la conoscenza di una spiritualità primigenia e Il Dio oggetto, di Marc Augé, curato da Nicola Gasbarro (Mimesis, Sesto San Giovanni, 2016).
Letture che mi hanno aperto un nuovo orizzonte, su realtà creative, direi su mondi che si palesano nelle forme, negli stili, nei dettati delle tecniche che, in fondo, richiamano valori estetici, che si legano al senso del sovrannaturale pulsante nei miti, negli archetipi, nella sfera creativa magico-rituale. L’osservazione di Zeri richiama il tema dell’estetica, della bellezza, suggerendoci di rivedere i nostri abusati metri di “interpretazione e di lettura”, quelli che definisce i “falsi criteri di atemporalità e di anonimato applicati generalmente ai primitivi”. In sostanza, è quanto sosteneva Boas, proprio negli anni di affermazione del surrealismo e dell’astrattismo concretista. “Non c’è popolo a noi noto – osserva quest’ultimo nelle prime righe dell’introduzione – per quanto dure possano essere le condizioni di vita, che dedichi tutto il suo tempo e tutte le sue energie alla ricerca di cibo e alloggio; e anche coloro che, vivendo in condizioni più favorevoli, sono liberi di dedicare ad altre occupazioni il tempo non più necessario alla lotta per la sopravvivenza, non si limitano a produrre lavori esclusivamente utilitaristici né passano i giorni in oziosa indolenza. Anche le più povere fra le tribù hanno prodotto lavori che sono per loro fonte di godimento estetico; e coloro cui una natura generosa o una maggiore ricchezza di invenzioni ha elargito la libertà dal bisogno, dedicano gran parte delle loro energie alla creazione di cose belle”. Cose belle che la cultura occidentale ha ‘chiuso’ nei vetri di teche allineate nei musei di storia naturale e che, come auspicava Lévi-Strauss in un articolo pubblicato nel 1943, un giorno queste collezioni “lasceranno i musei etnografici per trovar posto, nei musei d’arte, fra l’Egitto o la Persia antichi ed il Medioevo europeo”, perché si “tratta d’un’arte non inferiore alle più illustri” e perché “ha dimostrato una varietà superiore alla loro, ed ha messo in luce una capacità di rinnovamento che sembra inesauribile”.

“La difesa della decontestualizzazione – rileva Price – si presenta ogni volta che il valore dell’Arte Primitiva viene gonfiato da interessi esterni”. È stata questa la preoccupazione che, Mino Sorvillo ed io, abbiamo cercato di tenere nell’alveolo del nostro progetto, evitando, di fatto, qualsiasi influenza proveniente dall’esterno, particolarmente da perpetrate errate analisi storico critiche che hanno fatto leva sul diffuso interesse per la ‘negritudine’, risalendo a Picasso e agli artisti delle avanguardie dei primi decenni del secolo XX. La riflessione, come sempre accade nella stesura dei progetti di ricerca, parte dal contesto, cioè allargando il campo d’indagine per poi, pian piano, stringere il focus e arrivare all’essenza rappresentata dall’opera. Nel caso di questa mostra è stato il ‘territorio’ di realtà, offerto dall’album che raccoglie le fotografie realizzate da Émile Muller, medico belga dipendente dalle Société international forestière et minière du Congo, tra il 1923 e il 1938, pubblicato nel 2007.
Cosa hanno offerto le immagini con le quali il dottor Muller ha, con attenzione propria di un etnografo, ha documentato la vita quotidiana di popoli che, a quella data, vivevano immersi nella natura, ove quest’ultima era madre, casa, luogo dello spirito? I rituali, la forza di una natura primigenia, il re e “les danseurs masqués”, le maschere Bwoom, tipiche di BaKuba – regione dei fiumi Sankuru e West Kasai, nella Repubblica Democratica del Congo – Ngandi, Mwaasch, Mwashamboy, una maschera integrale anch’essa di BaKuba, sono i principali soggetti che l’obbiettivo di Muller inquadra. Un gruppo di fotografie mi ha particolarmente colpito: la prima coglie in primo piano il “maestro dell’iniziazione”, con in mano dei piccoli archi e sullo sfondo dei giovani iniziati con il corpo dipinto.

Le altre tre ritraggono: l’esterno di casa Djilatendo, con pitture murali che lasciano pensare alla raffigurazione del dottor Muller, con i suoi assistenti africani nella mac – china e “à droite un commerçant métis sur le dos d’un bœuf”; la parete di una casa con un graffito bianco, che raffigura un soldato della forza pubblica e un’altra pittura, forse sulla stessa parete, resa con un tratto schematico, direi geometrizzato, con al centro un uomo armato di una mazza “aussi qu’un fusil et un volatile”.
Due gli aspetti che balzano agli occhi: la prima fotografia offre l’immagine del contesto nel quale la magia ha la sua determinazione, in quanto amalgama della comunità, quindi la sostanziale necessità di iterazione del rito, come segno di appartenenza e di condivisione, con la figura del “maître de l’initiation”’, l’artefice del contatto tra la natura e gli dei che in essa vi abitano. Le altre confermano in maniera inequivocabile l’eredità alla quale hanno attinto le esperienze di quegli artisti che hanno disegnato la prima effettiva traccia di un’arte africana contemporanea, una sorta di “moderno classico”, cioè separata dall’esperienze contemporanee, ossia l’attualità, così come Hans Belting, per l’arte occidentale, ridefinisce il modernismo. Da queste fotografie ha preso avvio la riflessione che mi ha portato ad ipotizzare un percorso espositivo che si muove su due linee parallele: l’arte primitiva, quella che oggi in molti definiscono, con oscillazione di visione tra arte tribale e oggetti di artigianato (in più casi troviamo la definizione “oggetti d’antiquariato”) e le esperienze di artisti nati e formatisi nel corso del Novecento e, in parte oggi scomparsi, ai quali si vanno ad affiancare i più giovani, una generazione nata tra i decenni Cinquanta e il 1970. Indubbiamente, gli oggetti delle cerimonie magico-rituali, dalle statuette alle maschere, agli idoli, all’akvada (bambola), alla zappa, hanno un loro valore simbolico; anzi, precisa Augé “il supporto del simbolo e del feticcio è l’oggetto, la cosa”, aggiungendo, altresì, che “l’oggetto può essere diverso: oggetto naturale – pietra, pezzo di legno – o elemento della natura dotato di una vita propria che ne facilita la personalizzazione […].

Non è inverosimile la possibilità di tessere una linea di continuità tra questi oggetti, espressioni anche di un valore estetico e poietico e i segni, le figurazioni, l’elementare sintassi compositiva di artisti che si sono formati da autodidatti o che hanno studiato nelle scuole messe su dai programmi dei colonizzatori nel corso del XX secolo.