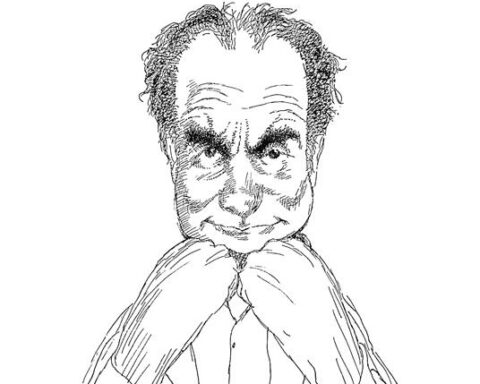La città fa da sfondo alle prospettive che l’arte disegna al suo futuro; una città ambiente, dunque non solo architettura, quanto misura – come ho osservato in uno dei capitoli di Autoritratto urbano (Mimesis, 2017) – di relazioni che s’intrecciano come trame del vissuto quotidiano, intercettando nuovi spazi all’esistenza, nuovi luoghi all’immaginazione sociale. La città è un unicum dal quale difficilmente possiamo staccare delle parti, in pratica circoscrivere o, peggio ancora, isolare tra loro i segni del tempo, della sua metamorfosi che la consegna al presente. «Le nostre strade – scrive Colson Whitehead narrando della sua New York – sono calendari che contengono ciò che siamo stati e ciò che saremo domani». Un unicum la cui identità oggi, però, rischia di perdere definitivamente la sua riconoscibilità, il suo tempo immaginativo; non parlo solo delle metropoli, bensì e maggiormente delle città ancora ‘provincia’, vittime sacrificali della vocazione alla cementificazione, dal dopoguerra cavallo di battaglia della politica.
L’ambiente al centro della mia attenzione è il territorio sociale dell’uomo, miscela tra natura e artificio, tra idea e gesto, cioè delle relazioni, degli scambi, dei piani di riqualificazione, di quelli urbanistici, del pensiero che, testimoniando il presente, guarda al futuro. Un luogo al quale James Hillman riconosce «un’intima, peculiare qualità», un’interiorità che definisce «anima del luogo». Quello scelto è la città; piccolo, grande, immenso schermo della società e delle sue relazioni, abitata dalle contraddizioni che la stringono nell’angolo del ring quotidiano, a parare i colpi di un avversario, il tempo, che lascia poche occasioni.
Nel corso di questi anni ho provato a ripercorrere contestualmente sia le città della mia fantasia sia quelle reali che ho attraversato, avvertendo sempre la presenza di un’anima. Difficile a definirla, perché, non possedendo una dimensione fisica, essa può esistere solo nella densità dello spirito e nelle figurazioni della mente.

Infatti si è mostrata ora negli umori di Marrakech che di sera soffocano l’immensa piazza Jamaâ El Fna rimasta quella di Canetti, nelle ombre colorate della casba o nei gesti dei tuareg, gli uomini blu delle oasi d’Atlante, ora nell’accecante luminosità di Merida, città andina del Venezuela, che al mattino ravviva di una pennellata fauve i colori delle vesti indossate dalle donne al mercato. Un’anima che cerca il suo corpo spandendo il rosso del tramonto sui tufi corrosi delle chiese barocche del Salento, che avvolge di vuoto la notte delle strade intorno al Ground zero a Manhattan, allungandosi sino a spargere il silenzio nelle case del Bowling Green. Oppure le vertiginose discese che, dal Barrio alto, portano al cuore della Lisbona novecentesca che mi hanno restituito la malinconia del fado e la millenaria dolcezza del Tago. Infine, il ritmo frenetico di una nouvelle Parigi che si stempera nei tempi tecnologici della Défense, lasciandomi alle spalle il mito della Ville Lumière. Sono incontri certamente diversi da quelli che scrittori del novecento e dell’attualità propongono nei racconti, nei romanzi ove la protagonista, anche se non palese, resta pur sempre la città moderna dalla camaleontica pelle.
Dai racconti ho appreso modi diversi di ‘praticarla’, in senso proprio di relazione, dunque di curiosità e di conoscenze, di esperienze, di come entrare nei tempi di una comunità o, meglio ancora, di come avvertirne l’identità: informazioni che, man mano, hanno accresciuto in me, avrebbe detto Borges, la consapevolezza di conoscere ben poco. La lettura sollecita l’immaginifico che, inevitabilmente, è stato ed è un ulteriore modo di praticare la città; essa mi offre punti di vista che l’autore ha pazientemente ordinato come possibili aspetti da elencare ai tantissimi che la fantasia – l’esempio è Italo Calvino con le Città invisibili – riesce poi ad elaborare. Ecco così che, riattraversando con la memoria le città ‘lette’, ritorno in quelle delle quali riesco, per un artificio che mi è sconosciuto, ad annusare i profumi, ad ascoltare i rumori, a sentire le voci, il fremito di un corpo sociale vivo che la grandezza della scrittura da secoli continua a regalarci. È così che incontro la Marseille di Walter Benjamin, nei luoghi ove i rumori si annidano «nelle strade deserte – scrive Benjamin nell’aprile del 1929 – della zona del porto, grevi e sfibrati, come farfalle in torride aiuole. Ogni passo fa lievitare un canto, un alterco, uno sbattere di lenzuola bagnate, fragore di assi, lamento di neonato, tintinnare di secchi. Ma bisogna smarrirsi per questi posti da soli, per correr dietro a questo sfarfallare di rumori quando svariano ebbri nel silenzio». E forse, sostando davanti al silenzio che imprigiona i logements collectifs dei quartieri popolari della “Bricarde” o “La Castellane”, anch’io porrei la stessa domanda: «Ché in questi angoli abbandonati ogni suono e ogni cosa hanno il proprio silenzio, come sulle alture a mezzogiorno c’è un silenzio dei galli, un silenzio dell’accetta, un silenzio dei grilli». Provando a scivolare in direzione delle ‘porte’ di Gibilterra, oltre le quali Omero non consigliava di andare, la fantasia inquadra le prospettive «fra echi fantastici» delle case bianche dell’Albayzín a Granada. «La danza delle casupole intorno al monte è dolce – così Garcia Lorca descrive il quartiere –. A volte fra il bianco e il rosso della costruzione, ci sono macchie dure e verdi scuri dei fichi d’India. Intorno alle grandi torri delle chiese appaiono i campanili dei conventi facendo brillare le campane imprigionate tra le gelosie, che cantano nelle albe divine di Granata (sic), rispondendo al miele profondo della Vela. Nei giorni chiari e meravigliosi di questa città magnifica e gloriosa l’Albayzín si staglia sull’azzurro unico del cielo e regala grazia agreste incantevole. Sono le strade strette, drammatiche, scale stranissime e disgiunte, tentacoli ondeggianti che si piegano in modo capriccioso e faticoso per portare a piccole mete da dove si scorgono le tremende pareti nevose della sierra o l’accordo splendido e definitivo della pianura. […] Le case sono poste come se un vento di burrasca le avesse lasciate così. Montano una sull’altra con strani ritmi di linee. Si appoggiano con i muri in un’originale maniera diabolica».

Oltre, allungando lo sguardo verso l’Atlantico, è possibile ancora oggi incontrare l’orologio posto in alto alla torre dell’elettrico, collegato – spiega Pessoa nella sua guida di Lisbona del 1925 – «con quelli all’interno della stazione», aggiungendo che in questo luogo il «turista, sia quello arrivato via mare, sia quello uscito dalla stazione ferroviaria, è nel posto giusto per scegliere il suo hotel, sempre che non voglia ripartire lo stesso giorno. Infatti i principali alberghi stanno al Rossio o nei pressi. Una volta prenotata la stanza, il turista ovviamente uscirà per vedere la città». Una città, Lisbona, per il colore che il Tago riflette sulle case, ricorda, nei toni, l’atmosfera delle stradine intorno alla cattedrale di Strasburgo, città che nel 1934 appariva ad Ernst Bloch «con le sue viuzze e le case sghembe, nelle quali ancora poco tempo fa ci si immedesimava tanto facilmente». Il viaggio potrebbe continuare senza tempo, facendomi condurre dal racconto, spinto ora dalla bramosa curiosità dell’incontro con l’habitat, ora dal desiderio di concedermi ad una ritrovata flânerie, con lo stesso passo con il quale Franz Hessel ripercorre la sua Berlino in Spazieren in Berlin, apparso nel 1929. Un passo che, osserva Benjamin, faceva della città un «sussidio mnemotecnico per il passeggiatore solitario, [che] non evoca soltanto la sua infanzia e giovinezza, non evoca soltanto la sua storia personale». Il libro di Hessel apre ad un «paesaggio fatto di pura vita» perché, aggiunge Benjamin, «tale diventa effettivamente la città per il flâneur. O, più esattamente, la città si scinde nei suoi poli dialettici. Si schiude davanti a lui come paesaggio, lo circonda come una stanza».
La scrittura, non sempre, obbliga alla realtà perché, lo ricordava Hillman, la città è occupata dai «fantasmi della civilizzazione»; lo è per la sua forma di accumulo di patrimoni culturali e, al tempo stesso, per il progressivo trasformarsi in macerie del suo corpo moderno. Il realismo, qualunque sia il linguaggio, esprime un modo di rapportarsi al mondo e, nel caso della scrittura si fa testimonianza, dichiarazione palese e sofferta di un disagio, di un’inquietudine, di un profondo malessere come quello che pervade, per esempio, le pagine che Sartre dedica a Napoli, in occasione del “viaggio italiano” degli anni Cinquanta.
«Queste città stringono il cuore – annota –. Ogni casa è fatta per essere abbandonata, per inabissarsi al passaggio della corriera, e c’è gente che le abita. La strada passa attraverso le costruzioni, le case, tutto è pubblico, una corrente che va da Roma a Napoli le solca, la velocità e il sole sono tutt’uno, si mescolano in una sorta di scirocco che lascia ovunque una accecante polvere bianca che devasta ogni cosa. […] È l’immagine arida dell’uomo. Napoli si avvicina. Come mi capita ogni volta, prima di arrivarci, sento una stretta al cuore. […] È una città in putrefazione. La amo e ne ho orrore. E mi vergogno di andare a vederla. Si va a Napoli come gli adolescenti vanno all’obitorio, come si va a una dissezione. Con l’orrore di essere testimone. E sempre, lungo le strade, si preannuncia con questo ossame scarnificato dipinto di rosa».
Diverso, invece, il tono della realtà scoperta attraverso il mirino della macchina fotografica. «Cuba è l’isola del piacere partita alla deriva – è Cartier-Bresson che scrive –, ma resta un paese latino, un paese tropicale, con il ritmo africano nel cuore. Le persone vivono con disinvoltura, sono piene di ironia, di gentilezza e di grazia, ma ne hanno viste di tutti i colori e sono smaliziate». Oppure, quando la materia delle cose si fa impalpabile realtà che sostiene la visione, ecco Venezia distesa nello specchio della sua laguna, ove di «tanto in tanto qualche battello appena illuminato s’[intromette] a disturbare con le eliche il riflesso di un grande “Cinzano” al neon che [tenta] di assestarsi sulla nera incerata dell’acqua». Sembra, aggiunge Brodskij, «di arrivare in un paese di provincia, in qualche posto sconosciuto, insignificante – forse al paese natale, dopo anni di assenza».

Città percepite con gli occhi, città guardate con la mente che si sovrappongono una sull’altra negli strati ‘zippati’ dei ricordi, comprimendo figure, suoni, sentimenti che riportano, nei contorni di una immagine, persone che ci hanno lasciato, angoli di case, piazze, spiagge nascoste sotto spianate di cemento.
Alla fine di questo personale atlante di città narrate, trova posto quella della mia vita: un archetipo cristallizzatosi nel profondo che mi consente di vedere l’assente. Dalla finestra della casa della mia infanzia e della mia giovinezza la città mi appare ancora allungata sul mare come una stretta fascia di sabbia posta a riparo sotto il monte Bonadies. Dalla finestra della memoria il ricordo s’impone sulla realtà e lo sguardo scende a mare saltando di tetto in tetto, da terrazza a terrazza, da giardino a giardino. Un tratto di strada, direi di cielo, che da lungo tempo ripercorro nel racconto del signor Palomar: «[…] La forma vera della città è in questo sali e scendi di tetti, tegole vecchie e nuove, coppi ed embrici, comignoli esili o tarchiati, pergole di cannucce e tettoie d’eternit ondulata, ringhiere, balaustre, pilastrini che reggono vasi, serbatoi d’acqua in lamiera, abbaini, lucernari di vetro, e su ogni cosa s’innalza l’alberatura delle antenne televisive, dritte o storte, smaltate o arrugginite, in modelli di generazioni successive, variamente ramificate e cornute e schermate, ma tutte magre come scheletri e inquietanti come totem».
Il ricordo percorre gli scivoli della fantasia, una realtà che sfugge al vedere, ma che rende ancora possibile il mio incontro con le cose. Il signor Palomar conclude: «Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose […] ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile».
La lettura offre piani di analisi e di conoscenza diversi, la storiografia critica è certamente un aspetto dal quale non si può prescindere. Lo è maggiormente quando il progetto entra nel vivo del suo farsi concreta realtà. Non sfugge al lettore quindi di porre l’attenzione su alcune significative pagine della storia dell’arte contemporanea che, a metà degli anni Settanta nel pieno di un’ onda democratica che pervade l’Europa investendo altre realtà, hanno registrato una favorevole congiuntura nella quale gli artisti, gli architetti riscoprono il senso di una ‘materia’ comune: la città intesa come civitas.
Una stagione entusiasmante, straordinaria sul piano del dibattito, della progettazione e delle prospettive che lasciavano presagire una nuova coesione tra arte e vita, ohimè rapidamente scomparse con gli anni Ottanta nel trionfo del postmoderno, all’insegna del reaganismo e di un’economia della quale oggi paghiamo le colpe. La cifra ideologica preminente in quegli anni, rileva Giandomenico Amendola in La città postmoderna, fonda sulla strategia degli ‘occhi’, vale a dire «quella consueta barocca della formazione del consenso agendo sulla meraviglia e sullo scarto tra il piccolo (cittadino, azionista o altro) e il grande (la mole del palazzo e il potere della corporazione)». È la ricerca «del grandioso, dell’insolito, della vertigine…». Saranno soprattutto gli artisti che, a metà del decennio Settanta, mirarono alla esemplificazione dell’equivalenza duchampiana arte=vita, operando, in alcuni casi a fianco agli architetti, nella pratica del progetto. Esso non ipotizza più una città ideale – negli ideali trovavano spazio anche quelli ideologici, fondati sul dare risposte alle necessità, e in loro nome i partiti politici, anche quelli di sinistra o progressisti, hanno motivato le scelte di urbanizzazioni scellerate –, bensì afferma quella terrena quale luogo di formazione effettiva della coscienza civile.