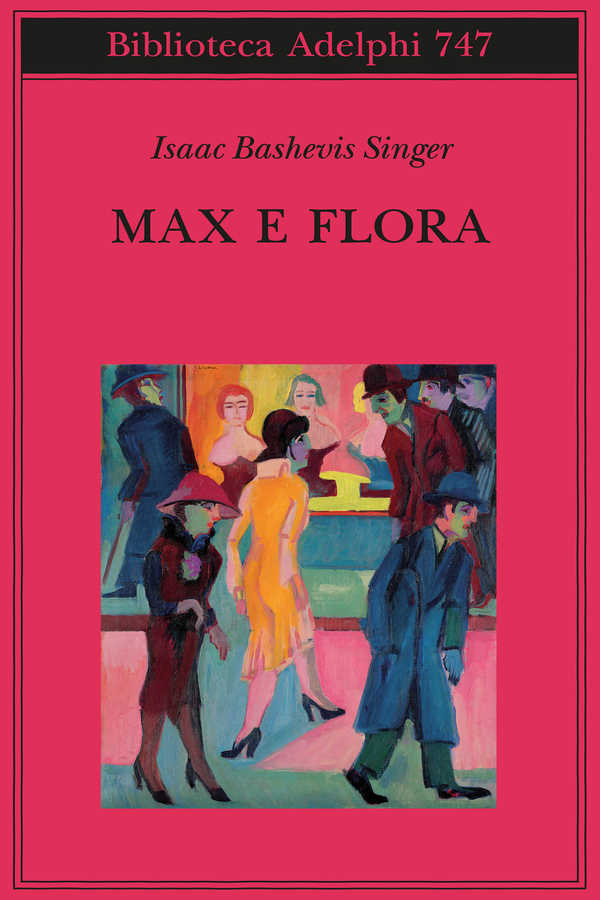Quando non corre intorno a se stesso, Eher Sugarno si gratta: ha il corpo, infatti, fittamente coperto di parassiti, che vivono tra gli aculei, e tre braccia non gli bastano per grattarsi. Dicono che sia appunto il prurito a indurlo a quella ricerca di evasione che è la poesia. Eher Sugarno scrive poesie alla maniera di Montale o di Ungaretti ma pare che non gli si possano non attribuire, come nota illegalmente – qui il termine non è da intendersi nella sua vocazione giuridica, austera o inflessibile, ma nella sua straordinarietà lirica, pressoria, oppure omeostatica (si legga a tal proposito “La fonte nascosta” di Mark Solms, opera appena pubblicata da Adelphi) – J. R. Wilcock, una copiosità e una velocità di scrittura da vertigine. Una velocità che pare abbia contagiato le migliaia di case editrici che pubblicano poesie come se il mondo non richiedesse altro insieme al pane e alla scienza. Ciò non lo scrive il noto argentino naturalizzato in Italia, – dissimilmente da Zaki, senza nessun passaggio in parlamento – ma una voce (inesistente) che pensa di esistere solitaria e che in maniera insolente si chiede se esistere fino alla fine biologica o continuare a essere perpetua, infinita e immorale. Come senz’altro è una voce quando è oratrice plurima. O scrittura. Oppure suono, corpo tondo, parmenideo. Pare, suggerisce Wilcock, che Sugarno ami il moto circolare, sebbene preferisca la stabilità. D’altra parte, nessuno ha ancora trovato cosa sia più stabile della poesia. Evidentemente il processo omeostatico (Solms) serve alla coscienza per riequilibrarsi quando il mondo, in maniera impulsiva e ineducata, ci smentisce sulla sua essenza dilatoria e irridente.
Nelle nostre visioni la coscienza, questa terribile e sconosciuta, e puerile parte di noi – ma non è detto che faccia parte di noi, o noi di essa – è divenuta così un elemento consolidato da apparire quasi come un organo, come il cuore oppure il cervello. Che esista la coscienza si dà per scontato, come pure si presenta ovvia l’esistenza e la necessità della poesia. Che sia la poesia, questa infame e prolifica forma d’arte, una manifestazione della coscienza? Sugarno, in maniera affatto speculare o inversamente accorta, è corrotto in origine. È depravato o deprivato dalla nascita. Non vive di queste paradossalità. Che senso avrebbe se si chiedesse della coscienza. O della mente. O, in maniera del tutto teologale, dell’anima. Che se ne occupassero i filosofi che di tempo da perdere ne hanno. Sugarno ha un corpo e questo gli basta. Un corpo con una testa. Un corpo in eccesso.
Wilcock così lo descrive: “La testa del poeta Eher Sugarno ricorda da vicino la capsula del papavero, quando è matura e si piega verso la terra per versarci dei semi; il corpo è invece difficile da descrivere”. È naturale, si pensa, che Sugarno, lo immagini senza il prurito, ma è abbastanza intelligente da eludere la domanda. Che ne sarebbe della sua poesia se a mancargli fosse quella provvidenziale e icastica imperfezione?
La poesia, allora, è una condizione. Non che Sugarno ne sia cosciente, ma dissimilmente da tanti altri poeti, per lo più emeriti sconosciuti, accusati come Brodskij di parassitismo, il suo è un vincolo, quasi un attributo di poetica, una clausola di fondamento. Ciò gli permette una poesia nient’affatto delirante o impoetica, ma precisa. Esatta nella declinazione di uno sguardo che si fa natura e corroborante mimesi di un presupposto di scrittura. Si allinea, in altre parole, il linguaggio con la lingua. Il corpo con l’alfabeto. C’è in Sugarno una sghemba corrispondenza tra un corpo, non mancante ma eccedente, e una compilazione che diventa nota di stile, forma di quel linguaggio universale che si disegna come apparente forma di mimetismo ma che in realtà traduce una trascendenza al margine di un’epochè, di una sospensione orgogliosa e infinita, dove la descrizione, sofisticamente si altera da veritiera a fantastica. Ambra gialla. È una resina fossile/derivata da antiche/conifere dell’oligocene,/che racchiude talvolta/piccoli insetti, aracnidi e miriapodi./Si trova specialmente/sulle coste del Mar Baltico/e in Italia/nella valle del Simeto (Catania). In questo modo, non ci aspettiamo di raggiungere la certezza della poesia; aspiriamo solo a una minore perplessità. E la potenza che motiva, la pulsione direbbe un Freud alla ribalta, allora, deve essere per forza attribuita al corpo.
 Scopriamo con Solms, un neuropsichiatra, che riscopre i sentimenti e Freud che il prosencefalo controlla e regola i bisogni corporei e in secondo luogo, questi bisogni sono la forza trainante della vita mentale, la molla del meccanismo psichico. Ci sarebbe da chiedere come, a questo punto, il prurito possa diventare un’energia mentale e quindi declamarsi poesia. Qui non possiamo far altro che limitarci ai margini della scienza. Dopotutto capire un meccanismo non significa spiegarne anche la necessità. E ulteriormente perché quest’azione del grattarsi non basti alle esigenze fisiologiche del corpo. E debba aggiungersi, allora, la scrittura, quest’attrito del corpo con la parola.
Scopriamo con Solms, un neuropsichiatra, che riscopre i sentimenti e Freud che il prosencefalo controlla e regola i bisogni corporei e in secondo luogo, questi bisogni sono la forza trainante della vita mentale, la molla del meccanismo psichico. Ci sarebbe da chiedere come, a questo punto, il prurito possa diventare un’energia mentale e quindi declamarsi poesia. Qui non possiamo far altro che limitarci ai margini della scienza. Dopotutto capire un meccanismo non significa spiegarne anche la necessità. E ulteriormente perché quest’azione del grattarsi non basti alle esigenze fisiologiche del corpo. E debba aggiungersi, allora, la scrittura, quest’attrito del corpo con la parola.
Senza dilungarci in altre suggestioni si può dire con certezza che la poesia di Eher Sugarno convinca a un’indipendenza del linguaggio e a un potenziamento del corpo. Sembra, data l’estrema riservatezza del poeta, e fidandoci delle brevi e caute descrizioni di Wilcock che il poeta di dubbia origine geografica, ma pare scriva in Italiano, sia di consistenza trina. Non come Dio, uno e trino con riferimento al mistero della trinità, ma tre mani, tre gambe, tre nasi e così via. Che ciò abbia indotto a un’emancipazione della parola “poetica” è fuor di dubbio.
Chiunque ormai ha nel suo curriculum un libro di poesia. Gli editori, belve fameliche, se ne sono accorti anzitempo. E così, milioni di libri prosperano da altrettanti pruriti. Senza essere tacciati di estremismo conservatore, la dico con Goffredo Fofi, bruciare qualche libro non farebbe male alla letteratura. E chissà, magari, torneremo a grattarci ad libitum, ma con meno preoccupazione.
J. R. Wilcock, Il libro dei mostri, Adelphi, Pagg. 143
Mark Solms, La fonte nascosta, Un viaggio alle origini della coscienza, Adelphi, pagg. 504