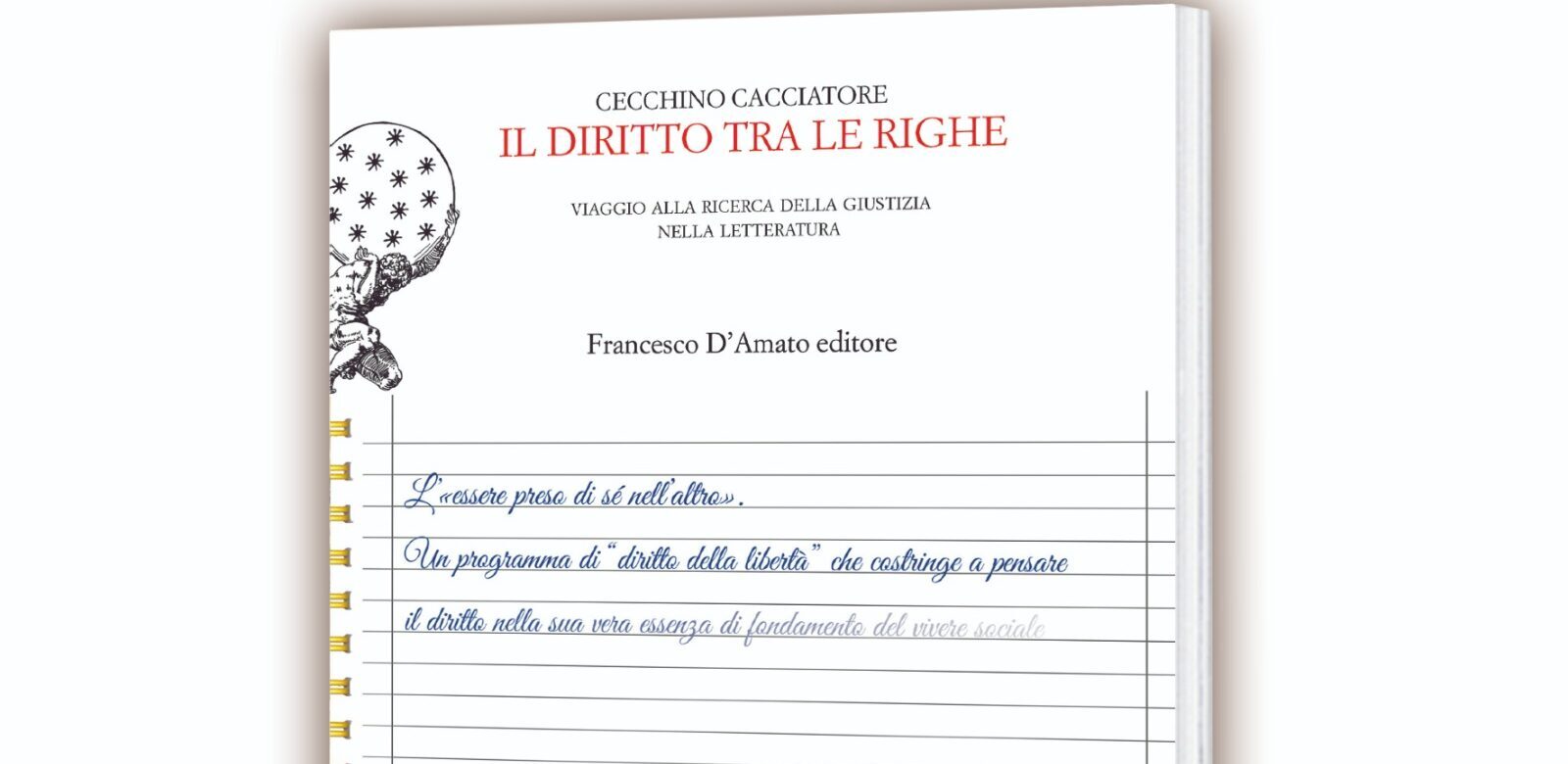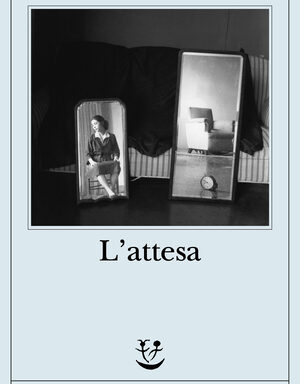“Il diritto tra le righe” è un viaggio appassionante teso alla scoperta di tracce e di orme della giustizia nella letteratura. Una sorta di esplorazione orientata dal diritto di libertà, cioè dalla vera essenza delle regole che dovrebbero presiedere alla convivenza civile in una società democratica e liberale. L’autore di questa navigazione coraggiosa è Cecchino Cacciatore, tra i più illustri penalisti campani, erede di una nobile tradizione familiare – giuridica, filosofica e politica – entro la quale egli si muove, coniugando la rigorosa pratica professionale con gli ideali e l’impegno morale che umanizzano e rendono viva e partecipe l’amministrazione della giustizia. Nell’interessante libro, che è un tassello decisivo nella dialettica riferita ai nuovi ruoli e alle moderne responsabilità dell’avvocato penalista, si ritrova e si condensa la ricerca dell’umano che riporta finalmente il diritto nell’area della cultura antica e contemporanea. Un diritto che Cecchino Cacciatore svincola dall’aridità di vecchi confini e dagli angusti orizzonti dei pregiudizi arcaici. Un approccio umanistico, il suo, del quale si ha bisogno mai come oggi, per poter restituire smalto alla funzione giurisdizionale, nel momento in cui essa viene messa da più parti in discussione o finisce sotto sterili attacchi. Pubblichiamo l’introduzione al libro (D’Amato Editore), uno scritto di notevole interesse, che apre un propizio dibattito intorno al diritto, andando finanche a scovarlo fin nei suoi nascondigli inesplorati, appunto “tra le righe”, cioè nelle pagine della grande letteratura di ogni tempo.

L’«essere preso di sé nell’altro».
Un programma di “diritto della libertà” che, a partire dalla formula hegeliana – come sostiene Axel Honneth -, costringe a pensare il diritto nella sua vera essenza di fondamento del vivere sociale in due traguardi.
Il primo. La reciprocità del riconoscimento del sé nell’altro è misura della libertà in espansione “a condizione” che l’altro sia amico e dunque, in un percorso di progresso dei diritti, proceda sulla stessa via per il raggiungimento di obiettivi comuni, eguali e solidali.
Il secondo. Il sé nell’altro è “caratteristica dell’istituzione” che così intenda il diritto, il quale è reso non in funzione repressiva, ma per promuovere le libertà. Dirà ancora Honneth: in funzione di garanzia della tendenza alla relazione e alla simbiosi per la costruzione e non per la distruzione dei legami sociali.
Un diritto della libertà, quale connotato essenziale della giustizia, che è a sua volta il risultato di un contesto sociale in cui la verifica della “stabilizzazione” delle libertà medesime e della loro “riproducibilità”, anche a condizioni diverse date (prescindendo cioè dalla selezione della “qualità” dei destinatari beneficiari), sia costantemente a saldo positivo dell’assicurazione delle esigenze vitali e di sviluppo e promozione dei talenti, delle predisposizioni, delle aspirazioni.
E quale è l’istituzione idonea?
La democrazia liberale valore
insopprimibile della modernità
La “democrazia liberale”, valore imbattuto della modernità.
D’altra parte, è bene non dimenticare la lezione di Aldo Schiavone, secondo cui il diritto “inventato” nell’antichità dai Romani non fu mai il diritto di tutti.
Anzi, esso non riguardava gli schiavi, non riguardava i più poveri, gli esclusi, coloro che non avevano accesso alla vita amministrativa dei centri urbani disseminati nell’Impero. Addirittura, era discriminatorio: nei confronti delle donne e di chi non fosse nobile.
Sarebbe successivamente intervenuto lo stato moderno a scoprire le potenzialità unificatrici del diritto, in modo da renderlo inclusivo.
Ma ciò non può essere inteso come una tappa definitiva.
Pensiamo al rapporto tra sicurezza e libertà individuale, logorato proprio dalle stesse conquiste della modernità. Rapporto che impone una di quelle verifiche di cui appena si è detto, per esempio con riferimento all’evidente declino del diritto penale liberale, il quale soccombe sotto la diversa idea di libertà “della paura”.
La libertà della paura è quella che costringe il diritto penale e di procedura penale a superare di gran lunga gittata il principio di precauzione che ogni ordinamento democratico pure si dà per la difesa verso pericoli e rischi criminali.
Il punto è che le istituzioni democratiche dovrebbero rispondere ai valori, non soltanto alle soluzioni da dare al crimine. In tal modo, è facile raggiungere il punto di crisi della democrazia che è rappresentato dal populismo che, tra l’altro, ha in sé la capacità di un elevato grado di isolamento e di scollamento proprio dal principio di reciprocità del riconoscimento dell’altro: se ho paura, diffido. È quell’insidioso strumento di potere estremamente versatile, che può funzionare – come sostiene Moisès Naìm – nei contesti più diversi ed essere compatibile con ogni ideologia ed anche con nessuna ideologia e, perciò solo, nuovo ed implacabile nemico di tutte le società libere.
L’insidia del populismo non in linea
coi valori della democrazia partecipativa
Pupulismo come ulteriore espressione di egemonia, secondo la definizione di Ernesto Laclau (le cui ricerche da poco sono state curate, non senza piglio critico, da Fortunato Maria Cacciatore), una pratica sociale, un modo di costruire lo spazio politico nel tentativo di creazione di un popolo portatore di insoddisfazioni che lo collocherà fuori dal consenso per le autorità che reggono la società. O, come dice Giovanni Fiandaca, una strumentalizzazione politica in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e allarmi indotti; peggio ancora, secondo le conclusioni di Ennio Amodio, una supremazia punitiva.
È ovvio, allora, che bisogna soffermarsi sulle differenze, affinché il populismo non attecchisca, dicendo in modo chiaro che è incompatibile con una democrazia partecipativa e aperta. Prevedendo esso lo sbilanciamento a danno delle garanzie, ma anche per il significato vero di queste ultime che, se interpretate nel giusto modo, si vede come non siano antinomiche alla sicurezza, individuale e collettiva.

In tale prospettiva, come afferma viceversa Jürgen Habermas, il processo democratico, che è guidato da norme di legge, si compie attraverso l’uso pubblico della ragione la quale rappresenta la chiave di volta per cercare di affermare progetti improntati alla giustizia, alla libertà e all’uguaglianza.
Ma vi è di più. In un pensiero così illustrato diventa, al contrario, difficile considerare libero un individuo a spese della libertà di un altro. «La libertà di un individuo resta legata a quella degli altri non soltanto in maniera negativa, ossia attraverso reciproche demarcazioni, ma attraverso frontiere che sono il risultato di un’autolegislazione esercitata in comune».
Di conseguenza, Habermas, propone un’immagine della costituzione della società, e dello Stato, generata intorno ad una “ragione procedurale” capace di “procedere in giudizio contro se stessa”; cioè di una ragione capace di esercitare la critica di sé medesima e che, in uno Stato di diritto, promuova progetti di solidarietà.
Non solo. Il ricorso alla razionalità ribadisce innanzitutto che ogni problema ha per centro la ragione, dal momento che le soluzioni vengono date e valutate esclusivamente in termini razionali. Parlare di razionalità significa analizzare la struttura che sostanzia l’agire, ed è solo grazie all’esatta conoscenza di questa che è possibile stabilire i criteri di valutazione e i livelli di valutabilità delle azioni.
Dunque, diverse grammatiche della libertà!
Da un lato, quella della “supersocietà”, dalle risposte semplificatorie e rassicuranti del “paternalismo libertario”, che scarica il concetto di colpa su tutto ciò che non funziona e individua nella sanzione e nella repressione il tema centrale di un’agenda politica che ha il compito di “ammansire il popolo.”
La macchina punitiva dell’apparato penale
affievolisce la qualità della democrazia
Dall’altro, quella del garantismo ragionato, che guarda alla centralità del riconoscimento nella formazione dell’identità individuale e nelle dinamiche sociali, necessariamente ancorate entro specifiche istituzioni dello Stato, in cui, beninteso, è l’idea stessa di libertà la fonte di legittimazione del loro operare. Diga di correzione al flusso impetuoso e disordinato di nozioni dominanti ed unilaterali della funzione e dello scopo del diritto penale e del processo, che ne individuino, al contrario, la validità solo nel consenso sociale ad arte preparato e nella rappresentata- quale unica e risolutiva- formula della necessità non altrimenti aggirabile della coercizione.
Se così è, non si può, dunque, non prendere atto della sempre più potente e penetrante macchina punitiva del nostro “apparato” penale, in cui evidente emerge il tradimento del ”penale” liberale, quello che in genere si pone come cifra della qualità della democrazia.
Tenere a mente la distinzione, consente di fare un’analisi priva di infingimenti sulla crescente domanda di controllo e di sanzione penale.
Bisogna, infatti, dire che l’ondata securitaria ha prodotto scelte politico-normative ispirate al principio della massima severità penale che, accompagnate dall’aggravamento delle pene di reati già esistenti e all’ampliamento degli illeciti penali produttori di incarcerazione hanno rappresentato innanzitutto il motivo fondamentale della crescita della popolazione detenuta, ma anche il mutamento di percezione stessa dell’istituto di clemenza che, da strumento di ordinaria amministrazione del sistema penitenziario, è adesso inteso – nella classificazione definitoria di Stefano Anastasia – come luogo dove assicurare “la funzione di ecologia della politica” per dar luogo allo “scopo” della colpa e della pena come catalizzatrici delle domande di cambiamento a livello di massa.
E il discorso affonda le sue radici in un passato oramai assai remoto, il quale se non si rinnova sempre ciclicamente (gli esempi di come la democrazia e il penale liberale si siano fatti strada attraverso varie temperie sono molteplici), in ogni caso è bene comprenderlo anche attraverso le lenti di coloro che – non giuristi, ma letterati, filosofi, poeti e registi o anche cantanti – hanno saputo cogliere, con la loro sensibilità, il senso profondo dell’impatto del diritto sulla vita degli uomini, parlandoci con le loro opere.
Quindi, ora la giustizia è dikaiosyne, “rettitudine,” ora è antidikein, “ingiustizia del contraccambio”, ora amynesthai, la “violenza di difesa con cui si reagisce all’aggressione”, come dicevano i greci.

Ma, come si vede, nel mezzo del cammino, da quel lontano mondo (che ha ancora l’abilità di darci spunti di riflessione e coordinate di orientamento) di un’antica idea di giustizia, lo sforzo degli uomini è stato sempre proteso alla ricerca di punti di contatto tra metron e peras, la “misura” e il “confine”.
Perimetro, ad esempio, già chiaro nell’Aiace di Sofocle, con cui si inaugura la virtù della giustizia fondata sulla compassione dialettica della complessità degli esseri umani che, capaci di prendere le distanze da se stessi, senza rinnegarsi, inventano nuove forme di istituzioni per non cedere alle passioni della forza.
Confine tra diritto e violenza; confine sottile ed incerto.
Confine, che tra le ombre del The dark side of the law. When discrimination, exclusion and oppression are by law (interessantissimo filone speculativo dei ricercatori dell’Università degli Studi di Salerno), tiene di qua il “dominio”, come potenza ed affermazione, quale carattere regressivo dello “scopo” dell’azione sociale; di là, la forza emancipatrice della norma, quale diga contro il disumano, oscillando tra inclusione ed esclusione.
Il sottile confine tra diritto e violenza
e i limiti valoriali della “forza di legge”
Grazie agli studi di Francesco Mancuso intorno alle teorie di Christoph Menke, diventa, ad esempio, chiaro quanto la funzione prima del diritto, organizzazione della forza, possa facilmente trasformarsi in violenza, giuridicamente qualificata e “destinata” a mero diritto della coazione, riprodotto in se stesso per il mezzo della vendetta.
Al bivio, insomma, tra emancipazione e dominio, appunto.
In quello spazio critico Kantiano in cui Jacques Deridda pone la sua Force de loi, chiedendosi a quali “condizioni di possibilità” la violenza è espressione legittima di una autorità; ancora più precisamente, domandandosi se sia possibile una giustizia che non si legittimi esclusivamente attraverso l’utilizzo della “forza di legge”, che non debba necessariamente ricorrere alla violenza per affermarsi.
Nella ricerca della direzione giusta, la sola tecnica (le mere tecnicalità) non è mai stata sufficiente e, credo, anzi ne sono convinto, non lo è soprattutto oggi. Pena, da parte del giurista – dell’avvocato in particolare (del penalista, in special guisa) – la perdita dell’umano.
Condivido, infatti, ciò che di recente ha detto Adolfo Scalfati, a proposito de La mutazione dell’avvocato penalista: «L’avvocato penalista rivela una mutazione genetica negli ultimi trent’anni, più di quanto sia accaduto in due millenni. Da arguto dominatore del patrimonio letterario egli ora ha subito le angherie della tecnica, affogando nel mare dell’informatica. Anche le regole giudiziarie richiedono tale padronanza che si trasferisce sul linguaggio e sulla persuasione. Una progressiva perdita dell’umano, delle spinte emotive, degli interrogativi sociali; un prodotto freddo, che annuncia l’avvento dell’automazione decisoria e dell’intelligenza artificiale. Il definitivo tramonto di un’era, dove l’arringa invitava alle pulsioni dello spirito».
È nostalgia?
Doveroso chiederselo.
Ancora più essenziale dare una risposta argomentata.
Magari partendo da un altro interrogativo.
Siamo chiamati anche noi avvocati all’”applicazione della legge” o, viceversa, ne promuoviamo la direzione verso la verifica della tenuta delle garanzie?
Qui, si apre lo scenario di un altro tema. Quello della deontologia.
Dice Remo Danovi, che quando il sistema diritto sarà chiamato procedimento (o rito), nel quale le colpe addebitate saranno mediate da un soggetto invitato a dirimere i conflitti tra le parti, l’accusato – cui nel frattempo era stata tolta la personale possibilità di ribellione, essendosi trasformata la sua protesta indisciplinata in una ordinata rappresentazione della propria versione dei fatti – potè giovarsi di colui il quale, con la ragione e la parola fu chiamato (ad- vocatus) a difendere dalla sopraffazione imperativa e dal sopruso.
Si passa, così, a mano a mano, dal logografo, che si limitava a scrivere i discorsi, al sinègoro, figura ancora ibrida che suggeriva parole ed argomenti, all’oratore.
Costui interveniva nei processi in modo da, secondo Iperide (Difesa per Licofrone e Orazione per Eussenippo, 330- 324 a.C.), nobilitare la democrazia con l’assistenza e la difesa che permette a chi ne sia capace di parlare di venire in aiuto ai cittadini in pericolo, salendo sulla tribuna.
Anche avvicinando le differenze; infatti, tra nobili e plebei, quando i primi difendono i secondi, l’attività prende il nome di patronato, tendendosi per tale via a smussare quantomeno l’antagonismo tra le due classi.
L’avvocato difensore al centro
di una rinnovata coscienza sociale

Non a caso, Montesquieu, nel mentre rifletteva sulla divisione dei poteri, affermando che legge non è altro che la ragione umana che governa i popoli, nelle Lettere persiane, ponendosi il problema della trasmissione del sapere che si trova anche nei sentimenti, nelle esigenze, nelle difficoltà, che talvolta codici e pandette non sono in grado di trattenere, farà dire ad un magistrato all’immaginario persiano Rica, preoccupato del fatto che il suo interlocutore avesse venduto la biblioteca: «se voi conosceste il Palazzo, non mi fareste questa domanda: noi abbiamo dei libri viventi che sono gli avvocati; essi lavorano per noi e si incaricano di istruirci».
Dunque, la deontologia passa per la responsabilità di un ruolo che pone il difensore al centro della coscienza sociale di un Paese. Altro che nostalgia!
La quota liberale dell’istituzione giudiziaria non si salva, allora, solo se l’abito professionale dell’avvocato sia fatto di pratica, utile e serrata, efficiente e idonea a mettere in sicurezza l’imputato certamente, ma affatto priva di ideali e di impegno morale.
La sintonia con l’umano che attraversa i rapporti tra gli uomini può stabilirsi affiancando alla tecnica la capacità di lettura della cultura profonda di un fenomeno sociale e verificare, appunto, se il contenimento o la risoluzione di esso sia compatibile con il diritto delle libertà e delle garanzie.
Talvolta, una tale sintonia si rinviene in romanzi o in commedie, in film o nei classici, in quei luoghi della cultura ove l’osservazione del vivere tra gli uomini non è condizionato dalla tecnica della norma, ma che al contempo aprono la mente e l’animo per spunti da far propri e da offrire in comunicazione a chi esercita il difficilissimo compito di giudicare e voglia farlo nell’aridità di un confine nel quale ogni approccio umanistico sia bandito in nome dell’efficienza, delle statistiche e della risposta più o meno pronta alla richiesta di lotte al crimine.
Il diritto tra le righe, appunto.
Ed è tra quelle righe che i motivi, tanto risalenti nel tempo, come spesso lo è la letteratura interrogata ed esplorata nel percorso appassionante e pieno di fascino che ho intrapreso, proponendolo negli scritti raccolti nel libro, quanto al contempo attuali, che andrebbe analizzata la situazione contemporanea e pensata qualche soluzione per il futuro.
Certo, in esse non troviamo termini e concetti fedeli alla lettera della norma, anzi, talvolta sorridiamo per qualche improprietà.
Ciò non toglie il godimento (e il rammarico, spesso) nell’apprezzare come l’Artista abbia saputo, meglio del legislatore, cogliere i valori del diritto e rappresentarne la portata, ora nel loro rovescio, ora nell’anticipazione di una soluzione che poi verrà, ora nella garanzia assicurata, o al contrario negata.
Il cammino tra le righe è stato ovviamente parziale, ma assicuro che tanto altro c’è da esplorare in una miniera di preziosi che attendono solo di essere colti.
Eppure, utilissimo.
Soprattutto a me, si intende. Sin da quando ho appreso che la legge – nel suo perimetro di autolimite – nasce dal riconoscimento reciproco tra prossimi, nella relativizzazione della sovrabbondanza del proprio Io e, contemporaneamente, nel valore solidale del Tu. Forse dal liceo, con Kant, nella dimostrazione che obbedire alla legge morale è difendere la libertà.
Avevo creduto che il nuovo codice
ponesse il contraddittorio al centro
Ci avevo creduto, infatti. Io, che mi sono formato poi sul e col “nuovo” codice di procedura penale (quello della Repubblica!), avevo creduto al “nuovo processo dominato dalle parti” e al contraddittorio non sulla prova, ma per la prova.
Avevo creduto che il nuovo sistema ponesse al centro del processo non più il giudice, ma il contraddittorio tra le parti.
Ci avevo creduto perché, a differenza del precedente codice del 1930, si potesse ambire ad un sistema in cui la parità delle parti non fosse contraddetta dal ruolo dell’accusa quale organo pubblico e rappresentante dello Stato al pari del giudice, e quindi restio ad assumere il ruolo di parte.
Ci avevo creduto perché, contrariamente al passato, la presunzione di innocenza avrebbe dovuto essere regola probatoria e l’obbligatorietà dell’azione penale non più il paravento dietro il quale stabilire criteri di priorità secondo scelte autorefenziali.

Ci avevo creduto quando i principi dell’oralità e dell’immediatezza vollero segnare lo spartiacque col “vecchio” codice. Prima che si avviasse il concentrico attacco a tali innovazioni- come scrive Agostino De Caro-; prima, cioè, che si iniziasse a leggere il sistema processuale alla luce delle sue prassi, conferendo ad esse un ruolo di governo del processo, obliterando le regole capaci di imporne di virtuose e contrastare quelle deleterie. De Caro denuncia il caso-vero e proprio- della rinuncia alla immediatezza, la quale pretende che il giudice che condanna sia lo stesso che abbia condotto l’istruttoria, nell’eventualità, altro che remota, in cui lo scorrere del tempo comporti il mutamento delle persone dell’organo giudicante, senza che questo significhi più la necessità della riassunzione delle prove già esperite, in nome di un efficientismo onnivoro.
Le delusioni, meglio le disillusioni, sono state tante, insomma, ed utile è a questo punto interrogare altre fonti (non tecniche!) per comprendere in profondità come la crisi del processo accusatorio e del diritto penale liberale siano crisi del principio di razionalità e cedimento all’atto di imperio di una “società punitiva” (vendicativa) che vuole il processo penale come strumento di lotta e forma di controllo sociale al pari – errando molto su questo punto – di qualsiasi altro mezzo atto a mantenere l’ordine pubblico.
Il processo penale non deve essere
strumento di controllo sociale
Il processo penale e la norma penale in genere non servono, però, a tali finalità, pena la riduzione delle garanzie individuali, con il predominio della fase delle indagini rispetto a quella del giudizio, con l’arresto immediato e la conseguente stigmatizzazione del soggetto accusato con lo scopo del controllo del contesto sociale.
Ancelle (come le gride manzoniane) di un processo che voglia stabilire prima del suo inizio se un cittadino debba essere colpevole, e dunque come puro strumento di lotta alla criminalità, sono l’interpretazione e la creazione di norme penali sostanziali del “doppio binario”: quello che condiziona addirittura il funzionamento e i tempi del processo. Cui si somma un “sistema” legislativo farraginoso, compulsivo e sovrabbondante, al quale, peraltro, fa da fratellastro leonino un impianto burocratico paludoso, talvolta contraddittorio e che del ritardo e degli ostacoli che pone quasi si fa vanto.
Ora, in nome alla lotta di questo o di quel “fenomeno criminoso” (corruzione, mafia, evasione fiscale, per dirne qualcuno) si assiste al paradosso per il quale le garanzie diminuiscono quanto più aumentano le sanzioni o la mera percezione del crimine da “combattere” al momento, alla bisogna; si accetta la riduzione delle libertà democratiche in nome del male minore.
Anche da questi scivolamenti è nato il populismo giudiziario, il quale avendo come obiettivo la criminalità (una società priva di crimine!) lavora senza fatica, portando sotto braccio come compagna la paura: alimenta l’allarme e le risposte vengono da sole e non possono che essere il contenimento delle garanzie. A prescindere- qui sta la truffa illusoria- dal contesto in cui opera: ben può darsi in una democrazia come la nostra che, se scossa a dovere dalla “percezione” del crimine (l’alimento principe del populismo), è disposta, immettendo una gravissima falla, a cedere pezzi di sovranità del principio liberale della presunzione di innocenza (togliendo dal suo riparo civile l’esistenza dell’individuo, esposta, viceversa, all’arbitrio dei moti violenti ed irrazionali del sentimento di sicurezza del momento).
Michael Sandel ammonisce, al riguardo, che la giustizia non è soltanto il modo giusto di accertare le cose, ma il modo giusto di valutarle.
Bisogna avere a mente che in tempi inquieti l’uomo è più inerme e il giurista deve prestare maggiore attenzione all’esiguo confine tra l’avere ragione e la prepotenza del voler avere ragione, costi quel che costi.
In tempi inquieti è più facile la crisi delle differenze (risultando più sfumati i valori centrali di una democrazia) e si fanno strada le populiste passioni di attesa, per soddisfare le quali la contingenza e l’imperio dell’evento la fanno da tiranno.
Ma noi contemporanei non possiamo più abitare «il cielo dei casi», di cui canta lo Zarathustra di Nietzsche, proprio di un mondo di ieri, con le sue illusioni di armonia, di compiutezza, con le sue pretese di esattezza da ricercare con la forza delle fatue ideologie, vuoti profetismi e promesse salvifiche. Un mondo che si è visto quali traguardi abbia raggiunto quando si è affidato alla purezza dell’uomo “diverso e superiore”.
Eligio Resta è chiarissimo nell’affermare: «la legalità allora è questo limite, questo confine tra speranza e certezza, tra il caso e la regolarità, tra il noto e l’ignoto, tra la forza e la violenza».
D’altra parte, nulla più della riflessione schmittiana – scrive Francesco Mancuso – illumina circa la pericolosità di un’idea di legittimità assoluta, priva di qualunque limite e freno, di uno Stato artificiale che abbia il popolo e la sua salvezza come riferimento simbolico.

Ma già Walter Benjamin, come noto, poneva il problema se in determinati casi la violenza fosse sempre mezzo per fini giusti o ingiusti. In un sistema di fini giusti la sua critica sarebbe data implicitamente. Ma non è così, afferma il filosofo esprimendo il suo concetto di critica alla violenza. Infatti, anche ammettendo che sia al riparo da ogni dubbio, tale sistema conterrebbe non tanto un criterio della violenza stessa come principio, quanto un criterio per i casi di applicazione.
Un’interpretazione che si fa particolarmente utile allorché si tratti di tenere tra le mani lo strumento delicatissimo con il quale si stabilisce se un uomo sia colpevole o innocente, rispetto ad un’accusa che abbia come fondamento solo un fatto.
Bisogna, quindi, domandarsi, se si voglia dar corso al giudizio di ragionevolezza, per precisare che in esso non rientri il “giudizio di valore”, ma solo- appunto! – “quello di fatto”.
La distinzione risale a Hume: i giudizi di fatto esprimono proposizioni conoscitive e verificabili, di cui si può giudicare dunque la verità o falsità, mentre i giudizi di valore hanno radice in un atto di volontà, non controllabile da un punto di vista conoscitivo.
Non a caso, Beccaria e Verri, infatti, già circa duecentosettanta anni fa promossero un movimento di radicale laicizzazione dell’intera questione penale: i reati sono tali, non “peccati”.
Assurdo impegnarsi a “inventare”
i reati: trasvalutazione dei valori
Chi si è interrogato a lungo sul tema, come Roberto Racinaro, non ha avuto remore a scrivere che alla radice di certi atteggiamenti inquisitori vi è addirittura un “presupposto teologizzante” che guarda alle atrocità di un mondo rovesciato, fitto di responsabilità del male.
Un mondo in cui non è il reato che provoca il processo. Ma, tutt’al contrario, è il processo che si impegna a inventare un reato e i relativi colpevoli, con gli esiti paradossali di un’epoca di “trasvalutazione” di tutti i valori.
Il travisamento, secondo Racinaro, inizia proprio dall’errata interpretazione della parola Ius.
Essa, più correttamente intesa, significa forza e iustitia valse da prima quanto iustitium, cioè iuris statio, termine, limitazione delle forze. Onde iustus si disse anche l’uguale. Infatti, aequum è detta altresì la legge, essendo l’equilibrio delle forze.
Si comprende a questo punto il senso della sferzante ironia con cui Croce descrive la richiesta di onestà in politica e – per dirla ancora con Racinaro – di chi pretende la storia ridotta sotto il concetto generale del codice penale: «L’ideale che canta nell’anima di tutti gli imbecilli».

Conclude, al riguardo Racinaro che ciò costituisce il contrario del senso profondo e modernissimo del pensiero di Gaetano Filangieri e Mario Pagano, i quali posero in risalto, come cifra del valore inestimabile della libertà civile, il disvalore dell’etica dell’intenzione, che non può non condurre che a una logica del sospetto. Quella dei populisti dell’onestà.
In linea di massima, di fronte ai disordini di una società, alla violazione delle norme e all’infrazione della legge, i suoi membri sono portati ad affidarsi a una risposta fatta di sanzioni e ciò accade quando queste vangano fatte credere utili e necessarie perché il crimine è il problema e il castigo l’unica soluzione. Non ci si accorge – scrive Didier Fassin -, se non in ritardo, che con il momento punitivo è il castigo a diventare il problema per il penale liberale.
Il diritto penale, così, diventa totale – è la felice intuizione di Filippo Sgubbi – ed ha come obiettivo ultimo la libertà stessa che si trasforma in frammentaria.
La potestà penale si “identifica” con l’etica pubblica e di questo paradigma il frutto più avvelenato è la tipicità postuma, o meglio, il reato percepito.
Ma la questione è ancora più complessa. Dice Sgubbi che lo scenario mette in discussione l’impalcato costituzionale, in quanto si passa dalle norme penali che puniscono alle norme penali che conferiscono legittimazione a decidere e in questo senso l’intervento penale assume la funzione nuova ed estemporanea di legittimare provvedimenti adottati sì dalla magistratura, ma aventi “natura di amministrazione” e di “governo” e ispirati all’opportunità politica.
Dal binomio innocente-colpevole
alla tragica antinomia puro-impuro
Il processo penale, di conseguenza, si fa performativo e la responsabilità penale, originariamente fondata sul binomio “innocente\colpevole” ora è ispirata dal binomio “puro\impuro”: il reato e la colpa precedono la commissione del fatto.
Si sbilancia l’equilibrio, la cui essenziale funzione era sostenuta da Andrea Antonio Dalia, tra autorità e libertà.
Col penale totale, infatti, dilaga la cultura del sospetto, le presunzioni sostituiscono le verità e le narrazioni le interpretazioni (come nel mito di Gige).
L’esiguo margine di legittimità costituzionale di alcune condotte criminose mette a dura prova, così, la possibilità di una rilevanza penale della causalità psichica, e – secondo Francesco Schiaffo – la difficoltà di provare l’efficacia motivazionale della condotta incriminata compromette, in ogni caso, la effettività delle scelte legislative.
Esempio eclatante è il sottosistema punitivo delle misure di prevenzione, zona franca oltre i limiti del diritto penale stesso, in cui c’è da chiedersi in cosa si riduca il compendio probatorio a sostegno del sospetto, se non nel “diritto del nemico” (la criminalità, ovviamente, sia reale che percepita).
Insomma, tra le righe, c’è tanta roba (passi l’ironia), ma soprattutto, quel che più conta, c’è un modo culturale di capire quanto sia pernicioso l’approccio che voglia emozionalmente delegare al potere la propria sicurezza e la sua tutela attraverso l’aumento della risposta penale e la corrispondente perdita di razionalità delle garanzie, a partire dalla constatazione della crisi di rappresentatività che ha portato con sé lo sfaldamento del principio di legalità.
In un tale contesto, valgano dunque la cultura del processo garantista e del giudizio di razionalità.
Ma, nessuna riforma (è il modesto pensiero dell’incerto navigatore tra le righe del diritto dei brani commentati e raccolti nel libro) potrà guardare ad un modello del processo penale secondo ragione, appunto, se non farà chiarezza sulla concezione della verità.

Il nostro tempo attuale è quello del confronto delle tesi nella “dialettica”, lo spartiacque tra la verità rivelata (dell’inquisizione e del processo inquisitorio) e il razionalismo (della verità dialettica e del rito accusatorio).
Dunque, una riflessione è opportuna sul ruolo del giudice rispetto alla verità, perché è intorno ad esso – come teorizza Gaetano Pecorella – che ruoterà l’intero assetto di un nuovo processo penale o quantomeno del suo uso.
O il giudice è il difensore dello Stato e a lui spetta tutelare l’ordine pubblico (di fatto così si contrapporrà sempre all’imputato), oppure è equidistante dallo Stato e dal cittadino (indifferente per davvero al risultato del processo).
È ovvio che la scelta non riguarda le caratteristiche del giudice (né intendo prosaicamente essere legato ad esempi concreti, peraltro fitti di quelli che si riferiscono a giudici virtuosi, svalutando in tal modo il significato del discorso rispetto al valore più alto della teoria generale), ma il tipo di processo. Basti considerare, infatti, che, in ogni caso, il nostro ordinamento conserva per il pubblico ministero la concezione di un quasi giudice.
Si pensi soltanto al rapporto giudice-pubblico ministero rispetto all’interrogatorio dell’indagato.
È ancora offuscato dalla confusione dei ruoli il sistema (il nostro, ahimè!) che prevede l’obbligo di sottoporsi all’interrogatorio dell’accusatore e, contemporaneamente, il diritto dell’accusato di mentire, non senza tener conto del fatto che quell’interrogatorio, nel ricorrere di determinate condizioni, sia riversato nel dibattimento, diventando patrimonio del giudice, fase in cui però l’imputato può rivendicare il suo diritto di tacere.
Il che riporta al ruolo della giurisdizione come è venuto trasformandosi.
Infatti, il giudice è sempre più creatore di norme attraverso l’interpretazione evolutiva del diritto stesso, orientando la fattispecie al caso. Quasi, oramai, assumendo il ruolo di judiciary power (di matrice anglosassone), cioè del giudice portatore della cultura dei diritti e delle garanzie.
Ebbene, in tutti i sistemi in cui tale ruolo è svolto vige, però, la separatezza – innanzitutto culturale – tra l’esercizio di un tale tipo di giurisdizione e il pubblico ministero che esercita l’azione penale e rappresenta (quale unico organo deputato) gli interessi dello Stato ad accusare. Cambia la prospettiva del Giusto processo: ovvero, la posizione del cittadino rispetto al potere; il giudice garantisce (sin dal 1215 con la Magna charta libertatum) il processo come un limite al potere dell’accusa che non può conculcare la libertà senza, appunto, un Giusto processo.
Non resta che stare di qua o di là. Come?
Tra le righe, io ho trovato la risposta alla ricerca del diritto razionale che impronta tutta la civiltà moderna.
Vi ho trovato la persona e la necessità di garantirla nelle sue libertà da parte di uno Stato che intenda il penale come limite all’intervento punitivo; con una attenzione spasmodica a tenere distinti i principi dai valori.
Siamo soliti parlare spesso indifferentemente di principi o valori, senza preoccuparci troppo di tenerli separati.
È un errore. I principi vanno interpretati secondo i valori di riferimento. Perché ne costituiscono proiezioni e al tempo stesso sono strumenti finalizzati ad attuarli sul piano del modo del diritto e della sua procedura.
Qui può misurarsi, tra l’altro, il maggiore o minore tasso di garanzia. Agostino De Caro si sofferma, al riguardo, sulla differenza in tema di prescrizione del reato tra il principio della ragionevolezza dei tempi processuali e il valore della necessità dell’esigenza di punizione da parte di uno Stato che tenga presente i limiti temporali del diritto all’oblio.

L’esempio è significativo e chiarificatore: i principi della legalità e della colpevolezza convergono entrambi nel garantire, sotto aspetti che si integrano, il valore della libertà personale.
Ha, in definitiva, ampia ragione Lugi Kalb quando a proposito del concetto di Giusto processo afferma che esso vada costruito e riempito di contenuto.
Per farlo, prima di richiamare l’art 111 della Costituzione, che è il punto di arrivo del principio del giusto processo, è importante ricordare quali siano le fonti di ispirazione dei valori.
Nel diritto “tra le righe” compaiono
già i contenuti del giusto processo
Bisogna, cioè, riferirsi all’ Equo processo della CEDU, all’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, agli articoli sulla Dichiarazione universali dei diritti dell’uomo ed infine alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, per poi, quindi, arrivare all’art. 111 della Costituzione.
Il Giusto processo è, allora, innanzitutto un ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla legge ed è direttamente collegato ai diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo, nel senso del valore di esso; nel senso dei principi, la norma di cui all’art. 111 Cost. impone, invece, una importantissima riserva di legge anche in materia processuale, volendosi affermare che il legislatore ha sancito il limite della legalità processuale in qualche modo omologo a quello che vale nel diritto penale sostanziale.
Il Giusto processo è, così, l’espressione con la quale si indicano le forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi, la facoltà di agire e, soprattutto, di difendersi in giudizio.
L’insieme dei principi della Costituzione di riferimento del diritto processuale obbliga il legislatore alla ricerca delle forme procedurali più idonee per assicurare le garanzie di un accertamento equo (per usare un’espressione della giurisprudenza europea).
I principi costituzionali più tradizionalmente prossimi al giusto processo sono tratti dagli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.
È proprio in essi che vi ho trovato il valore della persona, in quanto (meglio di altri)- nell’intreccio tra il precetto penale e il suo accertamento processuale- consentono di riconoscere il sé nell’altro.
Nell’art. 2 riecheggia la memoria di Mazzini: l’incoercibilità anche da parte del pubblico potere dei diritti inviolabili.
Nell’art. 3 si ammira il risultato di una storia culturale sensibile alla dimensione pubblica della dignità, quella sociale, oltre la angusta dimensione esistenziale.
L’art. 24 Cost. è sempre la controprova al risultato esatto che deve dare l’equazione processo penale\stato democratico: il diritto di difesa non può degradare dal suo rango di diritto inviolabile, per non essere limitato o conculcato.
L’art. 27 Cost. induce a pensare (tremando) a cosa fossero le pratiche criminali di cui si discuteva nell’Accademia dei Pugni ad opera dei fratelli Verri (Pietro suggerendo il tema e Alessandro mettendo a disposizione la sua esperienza di avvocato dei poveri), i quali ebbero il gran merito di ispirare il pamphlet di Beccaria, i cui principi sono giunti ai giorni nostri, circa la presunzione di non colpevolezza e la dimensione non disumanizzante della pena.
Tra le righe, insomma, una esplorazione alla ricerca dei valori che ispirano i principi anche della stessa Costituzione, per la verifica della qualità garantista della norma positiva.
Le incoerenze del giudizio
e il soccorso della letteratura
E così si ha modo, per stare un attimo sull’attualità interessata dalle novità di recente conio circa il processo penale, ma risalendo anche alle radici del senso culturale del contraddittorio (sempre alla ricerca dei valori e della loro corrispondenza con i principi) quale connotato di un penale liberale, di esprimere aspre perplessità su una serie di contenuti riformatori.

Lascia insoddisfatti la soluzione in materia di riti alternativi che sposta la premialità dalla semplificazione dell’accertamento alla rinuncia al diritto alla impugnazione.
In egual misura, non è soddisfacente quella che si limita a rimettere alla mera facoltà nella disponibilità della persona chiamata a rendere dichiarazioni (facoltà che declassa invece un obbligo, peraltro condizionata dal possesso materiale della strumentazione) la videoregistrazione dell’assunzione delle dichiarazioni delle persone sentite in fase di indagini.
Inquietante è la disciplina del processo a distanza, come quello non partecipato dalle parti e scritto (nel penale!). Come detto, le modalità del contraddittorio e di formazione della prova al dibattimento sono l’essenza del rito accusatorio.
Anche la rinnovazione dell’assunzione della prova in caso di mutamento del giudice scivola in basso sul piano inclinato dell’aggiramento del principio di immediatezza, secondo cui la persona sottoposta a processo possa interrogare e fare interrogare i testimoni dinanzi al giudice della decisione.
In tema di giustizia riparativa, sarebbe stato preferibile esaltare l’iniziativa lasciata all’imputato, piuttosto che minare la genuinità del suo consenso all’”ordine” che possa provenire dal giudice e dal pubblico ministero.
Nella materia delle impugnazioni, l’inammissibilità è oramai un’ossessione che si ripropone con costanza e col fine di limitare e conculcare il diritto di reazione a sentenze errate ed ingiuste.
La nuova disciplina della prescrizione – prevedendone la cessazione con la sentenza di primo grado anche in caso di assoluzione – ha creato l’orrore dell’ircocervo della figura assurda dell’assolto processabile a vita.
Perplessità che possono, quindi, nascere anche da una consapevolezza del diritto non cercata solo sulle tradizionali “pandette”.
Allora, vengano in nostro soccorso le Eumenidi eschilee dove è presente la “proceduralizzazione” del diritto.
Osservando Antigone e la sua disobbedienza civile, spirito di riforma.
Ricordando la discriminazione anche nell’onore femminile di Arpino.
Difendendo la libertà di opinione, condannata con Socrate.
Tifando per l’ingegno della Porzia di Shakespeare.
Ammirando l’umanità del giudice di Mc Ewan.
Sfidando la vita nel gioco di Durrenmatt.
Temendo le cure di Stato per limitare il delitto in Burgess.
Calcolando l’equazione presunzione di colpevolezza e verità con Sciascia.
Affidandosi alla magia dell’avvocato di Connely.
Comprendendo quanto si rinunzi in fatto di ragione se si coltivano l’inquisizione e la superstizione dei personaggi di Vassalli.
Le troppe colonne infami del presente
e gli ammonimenti di Kafka, Gide e Camus
Attualizzando l’infamità delle colonne di oggi, rispolverando Manzoni.
Imparando la deontologia e il coraggio degli avvocati, messi a confronto tra i tipi di Verga ed Harper Lee.
Soffrendo per le allucinazioni della giustizia solo efficiente di Dick.
Indagando nel delitto dell’anima di Gide e Camus.
Restando ingabbiati nel tempo sospeso di un processo con Kafka.
Macchiati per sempre dal processo mediatico, che non abbia colto l’esempio di Carrère.

Ribadendo il valore della difesa tecnica con Stendhal.
Opponendosi alla lotteria della giustizia organizzata dalle macchine di Charpentier.
Percependo l’ostilità degli ambienti carcerari descritti da Cechov.
Sospettando della legge dei potenti insieme a Satta.
Interrogandoci circa il rapporto tra scienza libera e religione sulla scelta di abiura del Galilei di Brecht.
Sorridendo alle stramberie di una sentenza fantasiosa di un vecchio pretore di provincia.
Rigirando intorno alla colpa di Dostoevskij.
Chiedendosi che fine avrebbe fatto il Pinocchio di Collodi se ad Acchiappacitrulli la riserva di legge avesse limitato il potere del giudice.
Apprendendo che talvolta è necessaria la difesa di rottura, quella di de Sèze in difesa del re.
Sentendo le pene del carcere come Wilde.
Commuovendoci per la testimonianza per la quale la giustizia non è mai di chi vince di Racinaro.
Scoprendo che anche Foscolo si interessò delle garanzie del processo.
Rabbrividendo al racconto di Hugo dell’ultimo giorno di un condannato a morte.
Badando alle debolezze del giudice di Lee Master e di De Andrè.
Cogliendo il negativo del ritratto grottesco e non edificante degli avvocati di Dickens, gravati nei loro comportamenti da nebbia morale.
Parteggiando per la ragione nel conflitto di Pirandello tra buon senso e delirio.
Andando a scuola di cronaca giudiziaria con Gatto, cronaca priva di pruderie e voyerismo.
Guardando il film di Amelio di un caso politico di plagio, ma non giudiziario, per riflettere su come il legislatore repubblicano abbia la possibilità di non ripetere gli errori di quello del 1930.
Riaprendo un vecchio racconto di storia fantasticata di Bufalino, soffermarsi sui corrucci del pentitismo.
Incantati davanti ad un quadro di Carracci, sedersi e aspettare che la ragione del disvelamento delle frodi, nel tempo ad essa necessaria e connaturata, sia sorella della verità.
L’insopprimibile valore democratico
della critica e del vaglio culturale

In conclusione, chiuso il romanzo, o il classico della letteratura greca, o canticchiata la canzone, e così rievocato il dolore con la tragedia o suscitato il riso con la commedia, piuttosto che nel ritorno a casa da un buon film, scrutato un mirabile quadro, non può e non deve non prenderci la riflessione sui principi che ci tocca, con modesto mestiere, vedere applicati, avendo però maggiori e diversi strumenti culturali e di conoscenza al fine di esercitare la democrazia della critica e comprendere a quali valori siano ispirati o, talvolta peggio, a quali si voglia che essi siano piegati. Soprattutto, sorvegliando quello della solidarietà, principio e valore al tempo stesso, nel senso che esso non sia più considerato estraneo al diritto, ma precettivo e strumentale- come sostengono Stefano Rodotà e Guido Alpa- per registrare meglio, così, l’arretramento dei diritti fondamentali.
Non è considerazione di poco conto assistendo alle trasformazioni “velocissime” in atto che vedono inasprirsi i contrasti proprio sulle garanzie che, solo con la persona (nella sua unicità, la quale è anche diversità) come baricentro assoluto di un sistema di libertà che non voglia essere graziosamente ottriato, possono, di fronte alle politiche efficientiste e securitarie della nostra modernità, che già volge verso il futuro della decisone della macchina, difendere da ogni tentativo di torsione la concezione della giustizia che hanno voluto i Costituenti; non un fornitura di servizi, ma la necessità del confronto tra le parti, decisivo perché il consesso sociale conosca le ragioni della decisione e partecipi ad esse.
In tali sensi, si badi che il procedimento di accertamento di una verità processuale non sia contro l’imputato ma con l’imputato.
E ci si ricordi di non essere sussiegosi guardando al passato. Il rito inquisitorio- al contrario, è bene tenerlo a mente- è un tipico prodotto della nostra Europa continentale, quale espressione dell’idea di giustizia dello Stato assoluto; un archetipo processuale che, in buona sostanza, voleva significare che lo Sato non può fallire, fino al punto di estorcere la verità dei fatti con il dolore.
Fu solo l’Illuminismo – e il movimento di ragione e di diritti verso l’autorità che lo preparò – ad avanzare critiche al modo stesso di intendere la giustizia, cioè universale, non più fatta scendere dalla grazia dell’autorità, ma come contropartita del consenso stesso dell’autorità.
Si pensi che nel tardo 1670 il genio letterario di Voltaire demolì l’Ordonnance criminelle di Luigi XIV per la quale già il cospetto davanti al giudice doveva spaventare, nel convincimento che si fosse destinati esclusivamente a soccombere.
Alle nostre latitudini, Carlo Alberto nel preambolo dello Statuto scrisse paternalisticamente che: <<Con lealtà di Re e affetto di padre>> “ordinava” ai regnicoli i diritti da lui garantiti. Di conseguenza, il codice di procedura penale del 1930 si apriva necessariamente con la disciplina dell’azione penale, incentrata sulla figura centrale del pubblico ministero.
Al converso, la Costituzione repubblicana del 1948 sancisce che la sovranità appartiene al popolo. Qui la conseguenza è ovviamente diversa: l’art. 1 del codice del 1988 ha come rubrica la giurisdizione penale, disciplinando – in una visione opposta e speculare il rapporto autorità\libertà – il ruolo centrale del giudice.
Annotava, al riguardo, Franco Cordero che un regime colloca l’autorità al vertice dei valori, con il volenteroso concorso della cultura ufficiale, e in contesti del genere il contraddittorio si accorda poco con le culture totalitarie.
È necessario, allora, opporre la cultura della ragione e valorizzare la libertà nella sua forma di massima espressività che è la dialettica.
È l’augurio che faccio; con maggior cuore ai giovani.
A costoro dico di riempire la valigia del proprio sapere col senso della storia del diritto delle persone anche fino al fondo oscuro (Italo Mereu) sul quale si è disegnata la storia d’Europa (da non ripetere e da cui essa stessa ha saputo emanciparsi).
Nel loro da farsi nei confronti degli altri, nel viaggio che stanno intraprendendo, passando dal mondo analogico a quello digitale. Sapendo che la giustizia – Antoine Garapon indugia di recente sui rischi per la libertà insiti ad un diritto fatto di determinismo tecnologico – è una aspirazione della speranza, mai un obiettivo finito; pertanto, da togliere dalle mani di chi voglia concederla come un suo potere da dispensare con arbitrio, privandola del suo senso ultimo della occasione garantista di modifica del destino e della sorte di un uomo sottoposto a giudizio.
Infine, per affermare – sempre! – che il contrario dell’autoritario accadimento del tutto perché casualmente accade è l’attenzione liberale da porre e dar far porre sull’accadimento del tutto (controllabile, verificabile e falsificabile secondo la ragione del dubbio) perché causalmente accade.
Buona lettura.