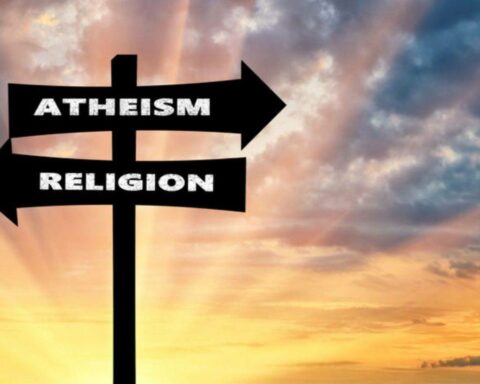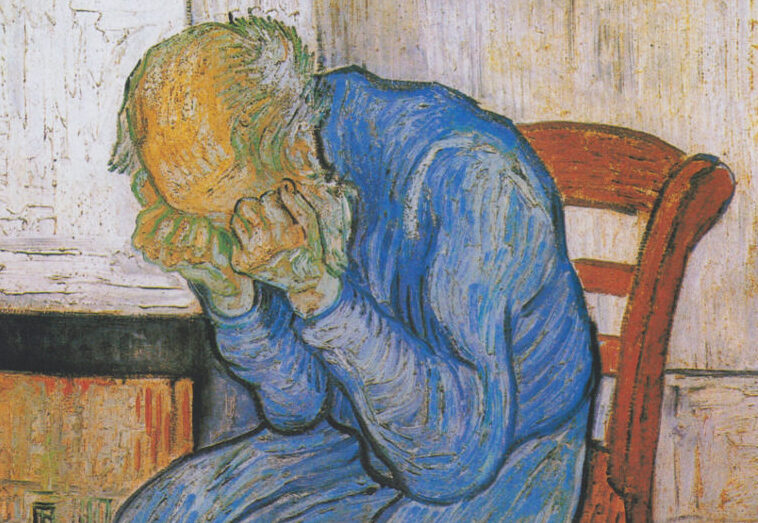Verso la fine degli anni ’90 si iniziò a parlare in Italia e in altri paesi europei della città delle 24 ore: la città che non dorme mai. Una serie di commentatori e analisti ne parlavano come di un successo, un progresso. Era la città della vita notturna estesa fino al mattino, dei bar e locali che sperimentavano le aperture senza sosta, dei centri commerciali che iniziavano ad aprire anche di domenica e negli altri giorni festivi.
Il tempo di lavoro e consumo della città si dilatava. E con esso iniziava a dilatarsi anche quello personale, invaso e catturato dalle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare dalla posta elettronica. Sono arrivate poi le app dei social e gli smartphone a diffondere ancora di più questo processo di cattura, per il quale sempre più persone – milioni e milioni – sono costantemente connesse. E, così, alla città delle 24 ore si sono accoppiate le persone delle 24 ore: città e persone che non dormono mai. Connessi, attivi, propositivi, a disposizione: sempre.
Leggere e rispondere ai messaggi e farlo continuamente, senza soste, in qualunque condizione esistenziale è diventato un dovere che dalla sfera del lavoro remunerato è tracimata – senza grandi ostacoli – in tutta la vita, assorbendola sia nella sua organizzazione materiale che nel modo in cui essa viene pensata: una vita messa al lavoro, sottoposta alla logica dell’esposizione alle domande altrui, come se fosse un’impresa che deve sempre rispondere ai clienti, al mercato.
Tutta la vita viene pensata come se fosse in produzione, organizzata secondo una logica economica di utilità ed efficienza. Questo processo si sta dispiegando da quasi tre decenni e almeno due generazioni sono diventate adulte al suo interno, diventando “grandi” dentro le sue logiche. Una serie di segnali ci dicono che questo processo è giunto al culmine e trova sempre più opposizioni, le quali si esprimono più che nella sfera politica in senso stretto nelle scelte personali, nelle resistenze individuali, nelle defezioni, nelle autosospensioni. C’è chi non legge e non risponde alle email per alcune settimane, chi si sottrae ai messaggi delle chat, chi si cancella dai gruppi nei social o non ne legge i messaggi, chi rinuncia sin dall’inizio o in corsa all’iscrizione ai diversi social esistenti, fino ad arrivare a chi, con tempi e modalità che dipendono anche dalle condizioni materiali di vita, si dimette dal lavoro o si prende una pausa, più o meno lunga.
In un libro pubblicato in questi giorni, frutto di una lunga ricerca, la sociologia Francesca Coin ha approfondito proprio questo fenomeno. Nel testo “Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita” pubblicato da Einaudi si evidenzia “come oggi dimettersi significhi non solo impedire alle condizioni di sfruttamento di deteriorare la nostra salute e le nostre relazioni, ma anche riconquistare tempo per noi stessi e per la nostra vita”. È proprio questa la necessità che si afferma dopo tre decenni di vite tirate allo stremo, educate a vivere in una logica di permanente attivazione economica: riprendersi la vita, sottrarla alla logica della performance produttiva. Certo, questo non vuol dire che tutti possono farlo, ma vuol dire che milioni e milioni di persone pensano di farlo, sono interessate a liberarsi da questo imperativo.
Bisogna fare i conti, in altri termini, con la stanchezza, ma anche con il fatto che la vita non è eterna: un’idea che anche l’esperienza della pandemia ha rimesso all’attenzione a livelli di massa e lo ha fatto come ipotesi e questione concreta, materialmente sperimentata o percepita. Stanchezza di una vita stretta nella logica produttiva a oltranza ed esperienza della finitudine sono due forze materiali che, sicuramente nel caso italiano, stanno spingendo una parte della popolazione alla critica pratica sebbene non politicamente organizzata della vita messa al lavoro. Sono due forze materiali e, insieme, emotive: non è detto che troveranno una traduzione politica o sindacale, ma sicuramente si stanno manifestando nei rifiuti e nelle prese di distanza che le persone mettono in atto per liberarsi dalla logica della persone – oltre che della città – che non dorme mai per rispondere alla domanda di presenza produttiva.