Pubblichiamo questa profonda riflessione di Pino Grimaldi, scomparso prematuramente tre anni fa, sul “paradosso dell’era digitale”, nel corso della quale all’aumento esponenziale della disponibilità dei contenuti corrisponde da parte di molti operatori l’inconsapevolezza della complessità. Il testo, la cui pubblicazione è stata autorizzata dalle figlie di Pino, Daria e Ilaria, è tratto dal libro “Il design della comunicazione. La grafica è finita, il design non sta tanto bene. Il marketing non c’è” (Artem, 2020). Un modo per continuare ad avere Pino Grimaldi, intellettuale di vaglia e maestro indiscusso nel suo settore, come compagno di viaggio nella sfida di RQ contro omologazioni e deragliamenti del senso comune.
Appena si riflette sul significato della parola ignorante, si scopre che il termine non va inteso solo nel senso che comunemente si usa, ma nel più circoscritto significato dell’ignorare determinate cose, non conoscerle, in altri termini va inteso anche privo di quel
senso fortemente offensivo che banalmente nel linguaggio corrente gli viene attribuito.

La provenienza dal verbo greco gnorizein (conoscere), poi, ci aiuta a chiarire meglio il concetto, che vuol dire semplicemente “mancanza di conoscenza”, dunque, si scopre che tutti siamo ignoranti, per il semplice motivo che non vi è essere umano al mondo che non sia ignorante in qualcosa.
È ignorante colui che ignora. Tutto qui. E non andrebbe usato come una clava.
Ma vi è anche il contraltare che presuppone che più si conosce, più si approfondisce la conoscenza di un argomento, una disciplina, più aumenta la consapevolezza della propria ignoranza.
Ci si chiederà allora del perché il termine è affiancato alla parola emergenza.
Occorre, inoltre, riflettere sul tema della complessità che ha visto incrementare esageratamente il fabbisogno cognitivo di ogni attività professionale e, conseguentemente, sulla rapida obsolescenza dei percorsi formativi che – i pochi davvero “illuminati” – contengono e prevedono il concetto di “aggiornamento”.
Non è così, le parole sono importanti e aggiornare non è sinonimo di rivoluzionare e comunque aggiornare non basta più. “L’educazione è diventata addestramento, un training arido e unidirezionale per farci imparare ‘qualcosa di utile’ da spendere nell’economia globalizzata” (Tonello, 2012: p. 11).
Dopo la fine del millennio siamo in presenza di una rivoluzione digitale causata dalle tecnologie descritte con l’acronimo ICT (Information and Communications Technology), siamo in presenza di nuovi paradigmi, abbiamo necessità di rivedere completamente la struttura organizzativa, le modalità e le metodologie della formazione.
Si tratta ormai di una dimensione digitale antropologica, ovvero la tecnologia è ormai parte del nostro ecosistema culturale.
Tuttavia la questione più grave – e pericolosa – per chiunque svolga una funzione connessa alla formazione è l’inconsapevolezza della complessità.
È il ‘paradosso dell’era digitale’: anche se la tecnologia ha aumentato esponenzialmente la disponibilità di contenuti, in molti casi alle persone non interessa approfondire le proprie conoscenze.
La facilità di accesso alle informazioni, alle conoscenze, in persone, dal fragile itinerario culturale, produce quella che io chiamerei la “sindrome del sapiente”. Quando serve sapere una cosa, si ritiene di poterla sempre trovare su internet, senza considerare l’ignoranza dei percorsi di validazione delle informazioni e l’incertezza drammatica delle fonti. Tom Nichols, un po’ iperbolicamente, scrive che sul web il 90% di ogni cosa è spazzatura.
Siamo in presenza di un gigantesco ribaltamento del socratico “Sapere di non sapere”, siamo nell’era del “So di poter sapere (all’occorrenza)”.
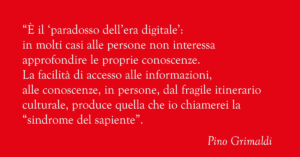
Con l’esponenziale crescita dell’utilizzo dei social network, è aumentata in maniera esagerata la percentuale di persone che creano e fruiscono di contenuti, che condividono o li commentano.
Fa sempre un certo effetto, quando si affronta un aspetto della cultura, conoscere i dati e le cifre delle ricerche. Ed è a questi che mi riferisco quando utilizzo la parola emergenza.
Sono oltre 9 su 10 gli italiani che accedono ad internet (circa 55 milioni) e il numero totale di utenti italiani attivi sui social è pari a 35 milioni. In particolare, l’incremento per l’uso di questi ultimi solo nel 2019 è stato pari al 2,9% . A fronte di questa grandissima partecipazione, non corrisponde purtroppo una solida consapevolezza dell’uso delle conoscenze; infatti, soltanto il 36% degli individui in Italia è in grado di utilizzare internet in maniera complessa e diversificata. Ma c’è di peggio e di molto più allarmante (di qui l’uso del termine emergenza): solo il 21% dei soggetti tra i 16 ed i 65 anni è in grado di comprendere in maniera funzionale un testo scritto. (Dati OCSE, Skills Outlook Italy 2019).
[…] Ma non è tutto, in seguito alla convinzione di una sorta di “conoscenza potenziale”, ovvero “tanto quando voglio sapere una cosa la trovo su internet” vengono trattati con fastidio, delegittimati e derisi gli esperti (cfr. il celebre “questo lo dice lei”), si manca di rispetto ai docenti, non da parte degli studenti ma, spesso, proprio da parte dei genitori.
Ma cosa ancora più inquietante è quanto scrive Tom Nichols su quella che egli chiama “la marcia americana verso l’ignoranza”: “non è l’assenza di conoscenze in sé [a preoccupare] ma l’arroganza con cui questa assenza di conoscenza viene esibita” (Nichols, 2018: p. 215).
Purtroppo ritengo che sia diventata potente e diffusa in maniera virale quella che gli psicologi chiamano ormai come la sindrome da “Effetto Dunning-Kruger”. Frutto dello studio sperimentale di David Dunning e Justin Kruger, relativo alla propensione degli incompetenti a sopravvalutarsi. La sintesi è drammaticamente efficace: gli incompetenti sanno troppo poco per sapere di non sapere.
Quando non si è esperti di un tema non si riesce a comprenderne la complessità, per cui la propria opinione – basata su poche rudimentali conoscenze o su pregiudizi personali – viene considerata saccentemente valida, ma, quel che è peggio, superiore rispetto a qualunque altra.
Ma vi è un’altra emergenza, nel nostro campo del design della comunicazione, ed è quella che io chiamo ‘benevolmente’ la “filologia di prossimità”, ovvero, siamo in presenza di una generazione di studiosi formatisi negli atenei italiani e attivi ormai dal 1993 nell’insegnamento del disegno industriale – come si diceva – che usano la filologia come strumento relazionale, in altri termini, si fa poca ricerca e si producono studi il cui apparato filologico – note, bibliografie, fonti – è spesso frutto di opportunità “condominiali” piuttosto che della ricerca e della finalità scientifica della produzione.

Si pensi a quanto diffusa sia oggi e rudimentale la nozione di immagine coordinata, che appartiene ormai solo alla fragile capacità di descrivere le attività di branding da parte di molti designer e alla povertà di strumenti metodologici da parte
della letteratura scientifica sul design della comunicazione.
Nel linguaggio professionale si usa ancora sovente il termine “immagine” (che possiede una semantica evocativa molto ampia e onnicomprensiva) per indicare solo una piccola parte di prodotti e strumenti di comunicazione (di stretta pertinenza della sola visione),
mentre l’immagine di un ente, impresa o istituzione è un concetto molto più ampio e comprensivo di innumerevoli aspetti che riguardano dai comportamenti delle persone alle opinioni radicate negli stakeholder.
Nell’universo digitale vi è il rischio che si sovrappongono e vengano confuse ‘informazione e conoscenza’, due aspetti molto diversi: la prima è un mero dato, la seconda implica connessioni, confronti e consapevolezza delle complessità. Eppure, questa distinzione poco sembra interessare gli ‘opinionisti social’ che con qualche manciata di notizie credono di avere conoscenze sufficienti per argomentare, scambiando “pensierini” per autorevoli editoriali, spesso destinati a poche decine di persone.
Non vi sono ricette semplici per il tema dell’ignoranza, ma vale un principio: nessuno dovrebbe demandare ad altri il proprio percorso formativo che è una delle dimensioni più preziose che appartengono all’individuo e a quello che si aspetta di ottenere dalla propria professione.
Il successo non potrà mai avvenire senza sacrificio, impegno e studio. Un professionista del design – dopo la formazione classica universitaria o accademica – non smetterà mai più di imparare se ha imparato come studiare e perché saprà usare le conoscenze in
ogni circostanza del proprio lavoro. Non sarà neppure una vittima della teoria dell’ignoranza razionale di Anthony Downs, secondo cui la maggior parte di noi evita di approfondire quando il costo di formare se stessi su una determinata questione supera il potenziale
beneficio che la conoscenza fornirebbe.
Non bisogna neppure confondere istruzione con apprendimento, perché “l’istruzione è ciò che altre persone ti danno. L’apprendimento è ciò che tu dai a te stesso” (Ito, Howe, 2017: p.160)
E poi c’è il problema degli algoritmi.
Ma questo è un altro studio.


