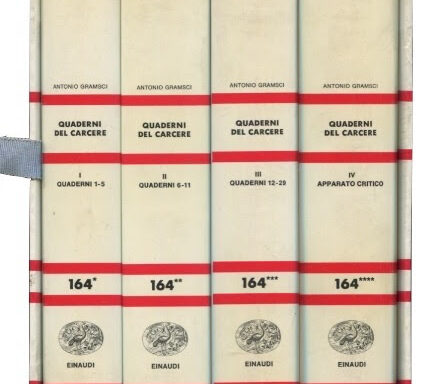No, non abbiamo proprio nulla da insegnare ai più giovani, anzi. Siamo stati, spesso, “cattivi maestri”. Abbiamo “predicato bene e razzolato malissimo”. Attanagliati da una egolatria asfissiante, abbiamo fatto in modo che le nostre parole, gonfie di retorica e buoni propositi, risultassero, il più delle volte, inutili e inefficaci. Parole senza percorsi di vita conseguenti. Parole vuote, “parole, parole, parole… soltanto parole”.
Badando di più alle carriere, al successo, abbiamo lasciato andare le belle idealità che avevano accompagnato la nostra “avventurosa gioventù”. Per un piatto di lenticchie, abbiamo svenduto tutto quello in cui avevamo creduto. Abbiamo svolto i nostri “educati compitini” che hanno messo in pace la nostra coscienza e abbiamo buttato la croce delle nostre inettitudini sempre lontano da noi stessi. Qualche volta abbiamo dato la colpa ai nodi di una storia maligna, a volte alle perverse congiunture di un neocapitalismo globale o, per restare più vicini a noi, abbiamo scaricato tutto su di un pervasivo “berlusconismo” televisivo.
Eppure, sarebbe bastato essere meno indulgenti con noi stessi e capire che “il problema” siamo noi, “il legno storto” della storia. Presuntuosi, vili, menzogneri, e, soprattutto, poco leali proprio con i giovani ai quali abbiamo lasciato un mondo pessimo. Pessimo nelle relazioni personali, amicali, politiche, istituzionali. Educare significa letteralmente “(…) tirare fuori”, sostenere e stare vicino a chi cerca di scoprire ciò che ha dentro e ciò che il mondo e i diversi linguaggi evocano in lui”. È arduo, però, farlo se non siamo disposti a metterci in gioco e, finalmente, uscire da questa insana ipocrisia.
E ancora: “educare è liberare potenzialità, allargare gli sguardi, forgiare e mettere a punto conoscenze e strumenti in grado di moltiplicare le possibilità di scelta di ciascuno, ma non dovrebbe mai pretendere di portare dove vogliamo noi”. Ecco, non dover continuare in questa noiosissima e perversa recita di “educatori” del nulla. L’unica educazione possibile, allora, è un’educazione “controvento”, come ci insegna Franco Lorenzoni, in un bel libro recente che ha proprio questo titolo.
Detto questo, ecco, auspicare ancora una volta l’apparizione di Dioniso, che solo potrà guarirci dalle nostre distorte certezze. Nelle “Baccanti” di Euripide, un testo epifanico di 2500 anni fa, c’è forse la soluzione di tutto. Penteo, cugino di Dioniso e re di Tebe pronuncia una battuta che è anche la sua disfatta: “Io sono Penteo”. Nel dire ciò e nell’enfatizzare il pronome personale, Penteo si scava la sua fossa. Detta, questa battuta, difronte a Dioniso, non può che suscitare in quest’ultimo un beffardo sorriso. Chi può, insomma, con tanta protervia dire, Io, se siamo abitati dall’altrove. Dioniso è il dio dell’altrove, dello straniero che è dentro di noi, non fuori. Il re Penteo, ha la presunzione di non dubitare di sé stesso; Penteo non sa che siamo originariamente scissi. Che non è la vita perversa che giocando con noi ci divide. Penteo non sa che siamo un’aporia vivente, un caos originario, un caos che, etimologicamente, sta per “spazio aperto”, dove vige una logica simmetrica (alla Matte Blanco, per intenderci), lontana mille miglia dalla chiarezza aristotelica.
Se siamo questo, allora, scendiamo dalle nostre cattedre e affrontiamo lo sguardo innocente e impaurito dei nostri giovani con una diversa attitudine. Abbeveriamoci alla loro beltà, e lasciamoci andare al loro abbraccio. Accogliamo le loro istanze, ascoltiamoli e fidiamoci della loro voglia di vivere in un mondo migliore di quello che noi siamo stati in grado di preparare per loro. Guardiamo i loro occhi, che spesso sono luce che libera e dona felicità. Quella felicità che noi, stanchi e annoiati, non riusciamo più a provare.