Non ho che una lingua e non è la mia. Derrida ha incenerito fino in fondo il linguaggio. La filosofia è lingua morta, dice Agamben. E riprende. La lingua dei poeti è sempre una lingua morta… curioso a dirsi: lingua morta che si usa a dar maggior vita al pensiero. Pur tuttavia si continua a parlare, a scrivere. In quale lingua? Forse, un dialetto, una lingua morta e tuttavia sorgiva. Una lingua che come una testa di Medusa riprende vita ogni volta dalla sua stessa cenere.
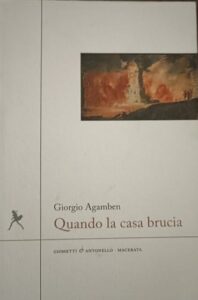 Una lingua non è uno scherzo, ma la misura di una speciale intemperanza. Eccedenza. Scompenso. O incessante domanda. Qual è il senso? E, precisamente, qual è il senso di tutto ciò che si fa, mentre la casa brucia? Domanda cardine e nucleo precipuo di questo piccolo (novantasei pagine) ma denso pamphlet di Giorgio Agamben dal titolo La casa brucia e portato alle stampe dalla preziosa Giometti&Antonello.
Una lingua non è uno scherzo, ma la misura di una speciale intemperanza. Eccedenza. Scompenso. O incessante domanda. Qual è il senso? E, precisamente, qual è il senso di tutto ciò che si fa, mentre la casa brucia? Domanda cardine e nucleo precipuo di questo piccolo (novantasei pagine) ma denso pamphlet di Giorgio Agamben dal titolo La casa brucia e portato alle stampe dalla preziosa Giometti&Antonello.
Ma quale casa sta bruciando, si chiede Agamben. Il paese dove vivi o l’Europa o il mondo intero? O forse è già tutto bruciato in un immenso rogo talmente grande che ci ha così avvolti che ormai non ci accorgiamo di essere già stati morsi dal fuoco e divorati dalle fiamme? E, tuttavia, copriamo di bianco le rovine, di alcune restano solo dei pezzi di muro, una parete affrescata, un lembo del tetto, dei nomi, moltissimi nomi, già masticati dalle fiamme. Viviamo in case, scrive amaramente e senza piglio di filosofo, Agamben, in città arse da cima a fondo come se stessero ancora in piedi, la gente finge di abitarci ed esce per strada mascherata fra le rovine, quasi fossero ancora i familiari rioni di un tempo.
E ora la fiamma ha cambiato forma e natura, si è fatta digitale, invisibile e fredda, ma proprio per questo è ancora più vicina, ci sta addosso e circonda in ogni istante. Che una civiltà – una barbarie – sprofondi per non più risollevarsi, questo è già avvenuto e gli storici sono abituati a segnare e datare cesure e naufragi. Ma come testimoniare di un mondo che va in rovina con gli occhi bendati e il viso coperto, di una repubblica che crolla senza lucidità né fierezza, in abiezione e paura?
La follia del nostro secolo è il potere
che considera l’uomo simile a una cosa
La cecità è tanto più disperata, perché i naufraghi pretendono di governare il proprio naufragio, giurano che tutto può essere tenuto tecnicamente sotto controllo, che non c’è bisogno né di un nuovo dio né di un nuovo cielo – soltanto di divieti, di esperti e di medici. Panico e furfanteria. Il potere, in pratica che cerca di impossessarsi della nuda vita, l’uomo simile a una cosa. La follia del nostro secolo. Uomini ridotti alla pura essenza biologica. Dispositivo o ingranaggio non fa nessuna differenza quando l’uomo è cosa tra corpi che non sono altro che la cosa stessa. Da qui l’uomo che è ancora il volto. Il volto come ciò che esiste di più umano. E che attraverso il linguaggio, la poesia e la filosofia ricordano una lingua e la sua pregnanza di libertà, ci ricordano che possiamo parlare. Il linguaggio è il nostro volto, afferma Agamben.
Il linguaggio non è uno strumento è l’aperto in cui siamo. Il volto che si espone e comunica. Non numeri e cifre ma volti. Mille volti avrebbe detto Deleuze. Mille piani e un Dio. Il viso è in Dio, ma le ossa sono atee. Fuori, tutto ci spinge verso Dio. Dentro, l’ostinato, beffardo ateismo dello scheletro. Che l’anima e il corpo siano indissolubilmente congiunti – questo è spirituale. Lo spirito non è un terzo fra l’anima e il corpo: è soltanto la loro inerme, meravigliosa coincidenza. La vita biologica è un’astrazione ed è quest’assurdità che si pretende di governare e curare.
Un’opera dal tono apocalittico
con una potenza di linguaggio unica
Il libro è così consistente che bisognerebbe riportarlo fino all’ultima sillaba per non fare nessun torto all’autore né all’opera stessa. Dilatando, sembra di toccare parole che sono fatte di brace e di respiro. Il tono è apocalittico, messianico, – nessuno ormai fa più affidamento ai profeti – ne emerge una semplicità, una potenza di linguaggio insopportabile. Senza tempo né storia. Si percorre così tutta l’indicibile potenza di una parola che si è fatta seme e cenere per rinascere estremità, margine. Composto poetico. O anche prosa. Una medietà. Una via di mezzo come diceva Platone che non è poesia e nemmeno è filosofia. Una scrittura che non è tecnicismo filosofico, come lo stesso Agamben ci aveva abituati, ma una tensione febbrile verso quel pensiero che rischia di trovarsi ogni volta senza lingua di fronte alla voce. E senza voce di fronte alla lingua. “I bufali e i cavalli hanno quattro zampe: ecco ciò che io chiamo Cielo. Mettere la cavezza ai cavalli, perforare le narici del bufalo: ecco ciò che chiamo umano. Per questo dico: bada che l’umano non distrugga il Cielo dentro di te, bada che l’intenzionale non distrugga il celeste”.
C’è una lingua che parla, allora. Una scrittura che dimora nel linguaggio prima di ogni sparizione. Prima che l’uomo scompaia sopraffatto dai calcoli del potere e della scienza. L’uomo è ormai privo di un mondo. Ed è forse soltanto da questo scempio scrive Agamben che qualcos’altro potrà un giorno lentamente o bruscamente apparire – non un dio, certo, ma nemmeno un altro uomo – un nuovo animale, forse, un’anima altrimenti vivente. Nella seconda parte del libro, “Porta e soglia”, la riflessione verte sulla figura di una porta orizzontale. A Carlo Scarpa, per il progetto dell’ingresso dello IUAV, gli è chiesto di utilizzare una porta di pietra d’Istria ritrovata durante i lavori di restauro del Convento dei Tolentini. L’architetto decide di adagiare la porta al suolo e di immergerla nell’acqua. Qual è il senso di un’operazione all’apparenza così avventata: una struttura verticale per eccellenza in una posizione adagiata?
La porta non è più il luogo dell’attraversamento né dell’ambito su cui sostare, ma del fuori, del distante, del pensiero come esperienza della differenza, o dell’indifferenza, dell’esteriorità, una sorta di epochè, di sospensione in cui s’interrompe per un attimo il senso per ritrovare quella libertà possibile di un passaggio che non conduce. E come nella porta sommersa di Scarpa l’acqua riflette il cielo, diventa cielo, così la porta-creatura è soltanto fuori di sé nell’aperto, felicemente sottratta tanto alla legge delle chiavi che a quella delle soglie. Siamo alla lettera Aleph, la terza sezione del libro è divisa in brevi frammenti contrassegnati da lettere dell’alfabeto ebraico, dove s’introduce la figura del profeta. E si continua la riflessione sul linguaggio. Geremia al Signore che lo chiama risponde con un balbettio. Profeta è chi non sa parlare.
L’efficacia della parola profetica, anzi la sua funzione, scrive Agamben, è di restare inascoltata, o di essere in qualche modo fraintesa. Il profeta è la presenza stessa del Regno. Il Regno non è una cosa, una chiesa, un partito. Esso avviene con la sua voce. Il Regno coincide sempre col suo annuncio, non ha altra realtà che la parola – la parabola – che lo dice. È la parola, in breve, a restituire quella voce che il nostro tempo ha perso nella vacuità delle dicerie e dei vaniloqui o del formalismo scientifico. L’essere la neve bianca, il suo inaudito apparire allo sguardo in un mattino d’inverno deve ritornare a essere considerato un evento e non un fatto. L’idioma dell’annuncio ha luogo fuori dalla lingua. Là dove non è né scrittura né grammatica ma parola veniente. Testimonianza e verità.
La solitudine del testimone
e l’assenza di nesso tra parole e cose
Quarto e ultimo capitolo. La verità della testimonianza non ha a che fare col suo contenuto semantico, non dipende da ciò che dice. La testimonianza non è un logos apofantico nel senso di Aristotele, un discorso che dice qualcosa di qualcosa. Non è nemmeno una preghiera, un’invocazione o un comando. Poiché non si definisce da ciò che dice, la testimonianza è sempre vera: soltanto si dà o non si dà. Testimone è chi non può avere altra testimonianza. Il testimone è solo. Il testimone è sempre testimone di se stesso. Non può dimostrare nessun nesso tra le parole e le cose. E tuttavia il testimone non dispone per la verità di un altro luogo, di un’altra possibile via di accesso che non sia il linguaggio. È l’esperienza stessa della poesia di Hölderlin. La poesia è la lingua in cui qualcuno testimonia per la lingua. Però è anche l’esercizio della filosofia, dove il testimone è chi dà testimonianza della verità. La testimonianza, si potrebbe dire, comincia proprio quando ogni via predeterminata alla verità – ogni methodòs – viene meno. È perché si trova di colpo senza una via alla verità che il testimone può solo testimoniarne. E così interrompere la storia e il discorso della menzogna, senza inaugurare un tempo e un discorso addizionale. Il testimone sa che non vi è una storia della verità, vi è solo una storia della menzogna. La lingua pura. Una parola che non dice nulla se non la sua stessa inaccettabilità.








